
Da giugno 2018 vive e lavora a Cavallino Treporti.
É la sua terza partecipazione al Concorso.
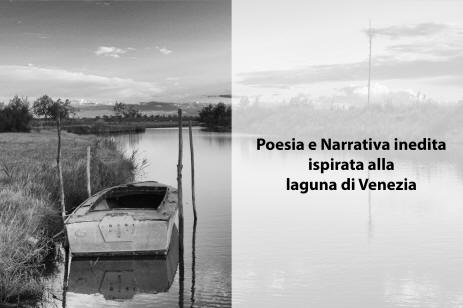
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti
che rassomigliate a sepolcri imbiancati,
essi all’esterno sonbelli a vedersi, ma dentro
sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume
(Matteo cap. 23 versetto 27)
PROLOGO
La barca scivolava lenta sull’acqua: complice la fitta nebbia invernale che smorzava i suoni, lo sciabordio del remo sembrava un’eco lontana sospesa sopra la laguna.
Seduta, avvolta in un ampio e caldo mantello foderato di vaio, un altrettanto ampio cappuccio che le nascondeva il volto e la proteggeva dal rigore notturno, una donna attendeva pazientemente di raggiungere la meta.
Aveva viaggiato per giorni, attraversando i domini della Serenissima in terraferma: Verona, Vicenza, Padova, sempre attenta affinché non trapelasse nulla del suo passaggio che potesse giungere alle orecchie del Doge e soprattutto dei Dieci, timorosa di ritrovarsi a udire la frase “Recordève del pòvaro Fornaretto”: non era ancora certa che, nonostante il lungo tempo trascorso, la Serenissima potesse aver dimenticato.
Sicché, giunta in laguna, aveva atteso occultata alla città grazie a persone compiacenti e era approdata fin li, complice una notte senza luna e la nebbia che sembrava attutire tutti i rumori più pericolosi.
Non alzava lo sguardo, conosceva bene il paesaggio che la circondava, nonostante il buio fitto: quei luoghi erano stati la sua dimora per lungo tempo.
Dimora? Prigione semmai, non dissimile dalla “cisterna” di Palazzo Ducale, un inferno in terra, anzi un sepolcro, un freddo sacello per giovani donne ingombranti, sorvegliate da donne che tali più non erano, invecchiate senza conoscere dolcezza e gelide come le pietre che le circondavano.
Da troppo tempo a Venezia giovani donne erano sacrificate affinché i beni di famiglia non si disperdessero e soprattutto le doti non intaccassero seriamente i patrimoni. Per la verità c’era anche chi lamentava questo stato di cose che, col tempo, avrebbe potuto condurre all’estinzione di molti nobili casati del patriziato veneziano, ma si trattava di poche voci fuori dal coro.
Ricordava voci rapprese, graffianti, una cacofonia di suoni che ferivano le orecchie, rimbombavano tra quelle pareti, in quelle sale dove avrebbero dovuto albergare dolcezza e misericordia.
La barca raschiò sul basso fondale sabbioso e si fermò con un rumore sordo contro la barena.
Il barcaiolo scese e si apprestò a aiutare la donna a fare altrettanto.
«Aspettami qui»
«Siora, la staga atenta che xe pien de bisse»
Incurante dell’avvertimento, si allontanò dalla riva.
Procedeva sicura lungo un sentiero a lei noto, che poteva vedere con gli occhi della memoria, impassibile ai fruscii simili a sussurri che si andavano moltiplicando al suo passaggio.
Era alta, il fisico asciutto; i lineamenti del volto, celato dal cappuccio, spigolosi, induriti dal tempo e dalle prove a cui la vita l’aveva sottoposta: ne era uscita vittoriosa e l’esperienza le aveva donato quel suo incedere superbo e regale.
Non era sempre stato così però, rifletteva con un sorriso tra l’ironico e l’amaro, ricordava ancora con stupefacente lucidità i giorni in cui tutto era accaduto: conservava nella memoria ogni attimo, parola o espressione.
Si fermò, gli occhi abituati al buio della notte sapevano cogliere i particolari necessari per comprendere in quale punto dell’isola fosse giunta.
Superando il terreno basso e fangoso, aveva raggiunto ciò che rimaneva del monastero di Sant’Ariano di Costanziaco, fondato nel Millecentosessanta dalla beata Anna Michiel.
Riconosceva quella parte della struttura, era stato un ampio locale realizzato ad ovest dell’area cortilizia dopo il disastroso incendio del Millequattrocentodieci che aveva quasi distrutto il convento: con la riedificazione avevano posto qui il refettorio e il dormitorio.
Si sedette su un tratto di basso muro, stringendosi nel caldo mantello di panno scarlatto, rabbrividendo non per l’aria pungente, né tantomeno per la nebbia che avvolgeva come un sudario ciò che rimaneva dell’isola, ma per i ricordi a lungo sopiti che ora riaffioravano prepotentemente alla memoria.
Figura solitaria e pensierosa, in quel silenzio di morte, avvertiva l’originaria nobiltà di quei luoghi, ora lugubri e desolati.
La decadenza di quelle isole, abbandonate negli anni a causa dell’impaludamento provocato dalle acque dolci dei fiumi che sfociavano in laguna, aveva il sapore di una punizione divina: Dio aveva reso sterile, mortifaffiere e desolate quelle terre emerse per colpa della malvagità e avidità degli uomini e donne che le avevano abitate, nonostante fossero servi del Signore.
Rise sottovoce, di un riso secco e amaro, tornando con la memoria agli accadimenti di quei giorni ormai lontani.
I
Un vento fortissimo si era sollevato sulla laguna in quella notte d’estate del Millequattrocentotrentatré, all’alba la pioggia aveva iniziato a scrosciare e la grandine picchiava sui fragili vetri di Murano con una tale violenza che all’interno del palazzo ci fu chi temette potessero frantumarsi.
Il clima in quegli anni aveva messo a dura prova gi abitanti della laguna: il Millequattrocentoventiquattro aveva portato caldo e siccità estremi sui già provati veneziani dall’epidemia che l’estate precedente aveva falcidiato la popolazione, tanto che la Serenissima aveva creato un hospitale per gli appestati sull’isola di Santa Maria di Nazareth, utilizzando edifici che in passato aveva ospitato i pellegrini in transito per la Terrasanta; nel Millequattrocentotrentuno invece, l’inverno era stato così freddo che anche la laguna era ghiacciata.
Costanza, incapace di prendere sonno, guardava la violenza del cielo riversarsi sul Canal Grande: nel suo animo si agitava una tempesta non dissimile a quella che infuriava sulla città.
Aveva diciannove anni compiuti, essendo nata nel maggio del Millequattrocentoquattordici, suo padre, Marino Contarini, aveva scelto il suo nome in omaggio alla città di Costanza, ove si svolgeva in quel tempo il concilio che poneva fine allo scisma di Occidente in seno alla chiesa cattolica e dove la Serenissima aveva inviato il padre Antonio, quale ambasciatore.
Marino Contarini era infatti un uomo profondamente religioso e poiché la discendenza della famiglia era stata assicurata da ben tre figli maschi, Leonardo, Zuanne e Francesco e una figlia femmina, Maria per la quale aveva a suo tempo stipulato un buon contratto matrimoniale, quando la piccola era venuta al mondo, aveva decretato che sarebbe stata destinata al chiostro.
Gli anni erano trascorsi, Costanza aveva raggiunto ormai l’età che suo padre riteneva adeguata per prendere i voti e ritirarsi dal mondo, sicchè il giorno successivo, o meglio ormai quel giorno stesso, il dieci luglio, la giovane avrebbe lasciato l’abitazione di famiglia per essere rinchiusa in monastero.
Non provava particolari emozioni all’idea di abbandonare quel gran palazzo affacciato sul Canal Grande, nel Sestiere di Cannaregio, che rappresentava il fasto e l’opulenza di cui si circondava suo padre, in aperto contrasto con la fede professata: la “Ca’ d’Oro”, la chiamavano a Venezia, per la sua facciata con alcune parti rivestite del metallo prezioso ma ancora più impressionanti apparivano al visitatore, i pavimenti del primo piano; coloro che erano ammessi a palazzo rimanevano abbagliati dalla lucentezza dei quadri di geometrie realizzati con i marmi più pregiati, dal porfido rosso, al serpentino, pavonazzetto, luculleo. Era stato l’ideale a cui suo padre aveva guardato per tutta la vita, era stato ideatore e mente del progetto: somme ingenti vi erano state investite, persino la dote della moglie.
Sapeva che non le sarebbe mancato quello sfoggio di ricchezza, ad eccezione della biblioteca di casa, che solo lei frequentava assiduamente.
Era infatti una giovane singolare, amava profondamente la lettura, era versata nelle lingue, latino e greco compresi e anche nella matematica; aveva una mente pronta e curiosa, capace di appropriarsi delle nozioni più disparate, comprese quelle sulla mercatura e la partita doppia, degna figlia di suo padre, abile mercante che aveva altresì saputo diversificare le sue attività.
Era insomma tutto ciò che avrebbero dovuto essere i suoi fratelli, ma che non erano mai stati, non perché fossero pigri o indolenti, ma semplicemente perché disinteressati e convinti che non avrebbero mai avuto necessità di apprendere simili noiose materie, poiché al momento c’era chi lavorava per loro, che preferivano trascorrere il loro tempo tra osterie e sollazzi di ogni genere.
A Costanza poco importava che i fratelli non avessero ingegno per gli affari di famiglia, in realtà poco le importava di tutti loro, maggiori di lei.
In famiglia pensavano che quella giovane così riservata, fosse solo fredda e scostante, incapace del più semplice gesto d’affetto: era invece solo molto timida e poiché il padre, così come la madre Soradamor mai le avevano riservato quelle attenzioni che le sarebbero state dovute, che venivano invece riversate tutte sugli altri figli, si era ritirata in un mondo interiore tutto suo.
Il subbuglio che ora albergava in lei, era soprattutto dovuto all’eccitazione del momento, all’idea del cambiamento a cui andava incontro,in particolare a quali piani avrebbe concepito per fuggire, perché di questo era certa, non avrebbe trascorso il resto della sua vita sepolta viva in un chiostro.
«Madonna Costanza, è ora che vi prepariate, tra poco il vostro signor padre passerà da voi,» la voce di Zanetta, la sua cameriera personale, la riportò alla realtà.
«Di già? Credevo fosse ancora presto, aiutami dunque» e spogliatasi della lunga veste bianca da notte, permise a Zanetta di lavarla e asciugarla vigorosamente.
Avvolta in un candido telo, si sedette vicino alla finestra per farsi acconciare, mentre un’altra domestica si faceva avanti con la colazione: latte caldo con miele, pane imburrato, frutta dei loro orti di Sant’Erasmo.
Apparentemente senza alcun interesse per il cibo che aveva dinanzi, iniziò a sbocconcellare del pane per scoprirsi affamata, in poco tempo ripulì il vassoio; nel frattempo, anche i suoi capelli erano stati raccolti in due grosse trecce fissate sulla nuca.
Si osservò nel riflesso del vetro, aveva un aspetto modesto, che bene si addiceva al luogo ove sarebbe stata condotta, ma in contrasto con la pericolosa luce che accendeva i suoi occhi.
In piedi, Zanetta l’aiutò ad indossare il semplice abito che era stato scelto per l’occasione, privo di gioielli, ricami e passamanerie: era di un bel tessuto di cotone grigio, che si accordava con il colore metallico dei suoi occhi.
Un tocco imperioso alla porta, si girò: «sono pronta.»
Sull’uscio apparve Marino Contarini.
II
Si era sempre sentito a disagio di fronte alla figlia, sin da quando questa era una bimbetta appena in grado di reggersi sulle gambe e di pronunciare le prime confuse parole; la colpa era di certo di quegli occhi, grigi color del piombo, a tratti con lievi pagliuzze dorate, sembravano emanare pericolosi bagliori quando sapeva fosse irata: era l’unico segnale di collera, peraltro mai manifestata.
Non era mai stato in grado di comprendere quali pensieri attraversassero la mente di sua figlia, in realtà la riteneva priva di sentimenti.
Queste frettolose e superficiali considerazioni, gli avevano consentito di accantonare qualsiasi remora circa il futuro che le aveva riservato.
In realtà si sentiva continuamente giudicato, aveva la sensazione che lo sguardo di Costanza si posasse su di lui ogni qualvolta prendeva una decisione, sia riguardo la famiglia che in merito agli affari, rinchiuderla lo avrebbe finalmente affrancato.
“È ridicolo” pensò tra sé, “un uomo come me che si sente in soggezione di fronte a una ragazzetta”: liquidò la questione con una impercettibile alzata di spalle e si rivolse alla figlia che attendeva in silenzio di fronte a lui.
«Bene figliola, oggi state per avviarvi a una nuova vita e poiché non avete manifestato contrarietà, devo dedurne che si tratti di una scelta consapevole la vostra.»
«Se è quanto fa piacere a voi e alla famiglia,» fu la lapidaria risposta, il tono monocorde.
Contarini non indugiò oltre, «falle indossare un mantello, è ora che scenda. Accompagnala alla porta d’acqua, dove l’attendono la sua signora madre e i suoi fratelli,» fu il secco ordine che impartì alla cameriera, dopodichè lasciò la stanza senza ulteriori commenti e senza degnare di una occhiata la giovane.
Come ebbe indossato il mantello, alzò il cappuccio sul capo e uscì dalla stanza senza nemmeno un breve sguardo a quel luogo che era stato per anni il suo rifugio e scese al piano terra dove la madre e i fratelli l’attendevano, mancava sua sorella, che da cinque anni aveva lasciato la casa di famiglia per andare sposa a Pietro Bragadin: non ne provò dispiacere, come non ne aveva provato quando si era sposata, troppi anni le separavano, non avevano nulla in comune.
Non ci furono parole di commiato né lacrime di commozione, non un gesto di tenerezza: Costanza porse le guance a ognuno di loro e seguì il padre sul pontile per prendere posto sulla grossa barca che l’avrebbe condotta verso la sua nuova vita.
La barca lentamente si mosse, in principio lungo il Canal Grande, per addentrarsi in un rio secondario; l’acqua pressochè ferma, esalava fetidi odori, Costanza si coprì il volto con il cappuccio.
Poi, come d’incanto, fu un’esplosione di luce, l’imbarcazione aveva lasciato il rio alle spalle per scivolare sulle ampie acque di fronte a Murano: in lontananza, complice la limpidezza della mattina, in seguito al temporale notturno, si scorgevano le vette delle cime più alte, alcune ancora innevate, che si stagliavano sullo sfondo di un cielo terso che pareva lavato di fresco.
La voga proseguiva sostenuta, una lieve brezza accarezzava il viso della giovane che respirava a pieni polmoni di quell’aria salsa, che sapeva di mare.
Lasciarono alla loro destra l’isola di San Michele, proseguendo verso l’isola del vetro.
Costanza non aveva idea di quale fosse la sua destinazione, né intendeva dare soddisfazione al padre chiedendoglielo. Quest’ultimo, seduto di fronte a lei, evitava di guardarla in viso per non dover sostenere una qualunque conversazione, in realtà non avrebbe saputo che dirle, non avevano mai avuto argomenti in comune, né tantomeno ricordi da condividere.
A Murano il legno imboccò il canale dei Marani, dirigendosi sempre verso nord. L’acqua scorreva veloce, mentre il paesaggio si faceva a mano a mano sempre più rarefatto e se possibile ancora più silenzioso, la pace della laguna era rotta solo da rauche grida di gabbiani.
Uscirono dal canale per trovarsi nuovamente in uno specchio di laguna dai riflessi accecanti.
Costanza vide davanti a sé il profilo di un’altra isola che intuì essere Torcello, di cui aveva letto: la storia narrava che qui fossero approdati gli Altinati in fuga dai barbari; sapeva che l’isola e quelle limitrofe erano ricche di chiese e monasteri.
Dunque suo padre aveva deciso di seppellirla lì, non troppo lontano dalla città, sì da poter essere tenuta sotto controllo, ma in un luogo apparentemente privo di vie di fuga a meno che non si possedesse un’imbarcazione e soprattutto la si sapesse governare.
Per la prima volta fu colta dallo sconforto, ma si riprese rapidamente, fu un attimo, la debolezza di un momento.
Superarono anche Torcello, imboccando il canale della Dolce, sino a quando giunsero a Sant’Ariano, un’isola circondata da ghebi e barene, collegata alla maggiore Costanziaca da alcuni ponti.
La barca infine accostò ad uno stretto pontile.
Senza profferire parola, padre e figlia scesero a terra, seguiti dal barcaiolo con il poco bagaglio di Costanza.
Il sole era ormai alto nel cielo, quando giunsero alle porte del monastero di Sant’Ariano, uno dei più antichi e ricchi, avendo accolto tra le sue mura numerosi nobili veneziane e ricche donne della classe mercantile, sia come monache che come converse, che avevano portato in dote orti, terreni e vigneti.
Seppur restio, anche Contarini aveva dovuto dotare la propria figlia affinché potesse essere accolta in quel cenobio e a malincuore aveva ceduto una grossa porzione degli orti di Sant’Erasmo di sua proprietà, con la clausola però, che qualora la figlia in seguito avesse scelto un altro romitaggio, i terreni sarebbero tornati nella sua disponibilità.
La badessa, in quegli anni Caterina Michiel, avvezza a contrattare nonostante il fervore religioso di cui si ammantava, accondiscese dietro però il versamento di una cospicua somma di denaro, che avrebbe dovuto compensare l’eventuale perdita della rendita.
Costanza era venuta a conoscenza della trattativa spiando gli incontri di suo padre con l’avvocato del convento, convincendosi una volta di più che uomini e donne di chiesa erano pur sempre solo uomini e donne e che nemmeno un briciolo di santità si avvertiva in loro.
III
Alle porte del convento la monaca portinaia li fece accomodare in una stanza che la ragazza immaginò essere il parlatorio, diverso da come lo aveva immaginato, privo di quei divisori che avrebbero dovuto impedire alle monache contatti diretti con chi proveniva dal mondo esterno: alcune panche addossate a dei muri bianchi di calce, un unico ornamento sopra la porta, un grosso crocifisso ligneo, plasticamente intagliato nella figura del Cristo, che rifletteva tutto il dolore di quella atroce tortura.
Alla calura esterna faceva da piacevole contrasto il fresco della stanza in penombra.
Costanza rifletteva che se il caldo li non giungeva nemmeno in piena estate, in inverno sicuramente le temperature sarebbero state rigide anche all’interno, sperava dunque che i locali in uso a monache, converse e novizie fossero opportunamente riscaldati, dal momento che, ne era certa, in quel convento non vigeva certo la regola del rispetto della povertà: in realtà non aveva mai udito che a Venezia e non solo ci fossero molti religiosi che rispettassero tale regola, a cominciare dal vescovo di Roma…
La badessa giunse senza farsi annunciare, Costanza e suo padre si alzarono contemporaneamente, quasi come se qualcuno avesse impartito loro un ordine.
«Madre badessa.»
«Prego messer Contarini, tornate a sedere, staremo più comodi» e rivolta a Costanza, «ben arrivata mia cara.»
«Madre,» disse chinando il capo in segno di rispetto, per rialzarlo immediatamente e fissare i propri occhi nei suoi.
La badessa fu colta di sorpresa da quell’atteggiamento così insolito in una ragazza così giovane, quasi risentita si volse verso Contarini, mentre Costanza continuava ad osservarla, quasi stesse soppesandone il valore: era una donna non più giovane, nonostante la pelle del viso risultasse bianca e liscia, aveva naso aquilino e bocca sottile, zigomi sporgenti e mento leggermente appuntito. I contorni del volto erano delimitati dal velo scuro che acuiva quel senso di durezza che emanava alla sola vista di lineamenti così scabri.
Le mani, rivelatrici della sua età, si muovevano senza posa mentre parlava, tradendo così il suo nervosismo.
«Dunque Costanza, affronterai un anno di noviziato prima di prendere i voti, è la regola, dobbiamo essere certi che tu faccia la tua scelta in piena coscienza,» si era rivolta a lei così all’improvviso che la ragazza, presa dalle sue considerazioni, si era quasi sentita colta in fallo, ma si era ripresa immediatamente ed era certa che né la donna, né suo padre si fossero accorti del suo estraniamento, né tantomeno del fuggevole sorriso che le era comparso sulle labbra quando la monaca le aveva parlato di un anno di noviziato prima di prendere i voti. A lei invece non era sfuggita l’espressione di stizza del padre a quella notizia.
«Sia come voi dite Madre.»
«È sempre così accondiscendente e remissiva?»
«Non ci ha mai dato pensieri.»
«Molto bene, non avete idea dell’angoscia in cui verso quando ho a che fare con giovani donne recalcitranti, convinte di poter fare sempre a modo loro.»
«Non è il caso di mia figlia.»
«Andremo d’accordo allora» e così dicendo prese le mani di Costanza tra le sue, sfoggiando un incerto sorriso verso quel viso impassibile dagli occhi freddi come pietra e si voltò verso il mercante, «credo sia ora che prendiate commiato da vostra figlia.»
Contarini si alzò, imitato da Costanza che chinò lievemente il capo, mentre il padre, impacciato, le baciava delicatamente la fronte.
Non aggiunse parole, né lo fece lei, si allontanò senza voltarsi, ma Costanza già aveva lasciato il parlatorio, sui passi della badessa.
Fu un passaggio del tutto inusuale: nessuna processione dalla chiesa alle porte del convento, né corteo di parenti e amici, né tantomeno le domande di rito del padre confessore. Nulla quindi, dell’abituale cerimonia che accompagnava l’ingresso di una giovane in convento, tutto si era svolto nel massimo riserbo.
Insieme attraversarono un breve corridoio, sino a una spessa porta di quercia: tutto il legno usato in quel convento pareva essere di quercia.
IV
La badessa sospinse la massiccia anta che si aprì senza alcuna difficoltà, né cigolii sinistri, si fece da parte e permise a Costanza di passare per prima: la giovane fu investita da un fiotto di luce.
«Questo è il nostro chiostro.»
Era uno spazio meraviglioso, di ampie dimensioni, con una gigantesca vera da pozzo al centro, un prato verdeggiante e alcuni alberi di pesco si estendevano tutto intorno, in un’area delimitata da una galleria con una bassa balaustra e archi sorretti da lievi colonne di marmo e capitelli a foglie d’acanto.
Il pavimento della galleria era di grosse lastre di pietra d’Istria posate ravvicinate, che quasi l’occhio non percepiva la fuga, l’effetto era quello di un pavimento uniforme.
Osservando dagli archi, si avvide di come i raggi del sole filtravano nello spazio aperto: la luce colpiva la vera da pozzo e una miriade di minuscoli grani di pulviscolo si libravano nell’aria, simili a polvere d’oro.
Proseguirono oltre, «questo è il nostro giardino dei semplici,» Costanza le rivolse uno sguardo interrogativo «si tratta di un giardino dove coltiviamo erbe aromatiche e medicinali, con le quali prepariamo dei medicamenti, sia per il convento che per coloro i quali non hanno la possibilità di rivolgersi a un medico: è nato subito dopo la grande epidemia del Milletrecentoquarantotto.»
Le era parso di cogliere un lampo di interesse nel suo sguardo, si ripromise di affidarla alla monaca che si occupava del giardino, affinché la introducesse a quella conoscenza.
La visita al convento intanto proseguiva: dalla chiesa pievana, ai locali di servizio e quelli d’uso della comunità, rivolti a sud, dove potevano godere di una maggiore esposizione al calore del sole e la cucina, con un enorme focolare.
Giunsero infine a un ampio ambiente a ovest del grande cortile, dove erano il refettorio e il dormitorio.
Le fece strada in un vasto locale rischiarato da finestre ogivali poste in alto lungo i due muri longitudinali: sotto, erano posti dei letti, uno a fianco all’altro, vicino ad ognuno, un inginocchiatoio e ai piedi del letto una piccola cassapanca, priva di qualsiasi ornamento, solo le monache avevano diritto a una propria cella.
«Questo è il dormitorio delle novizie, al momento siete solo sette, ma come vedi la stanza ne può accogliere molte di più, quello è il tuo giaciglio,» le indicò uno stretto letto coperto di una ruvida coperta e altrettanto ruvide lenzuola, a destra della porta di ingresso.
«Lasciamo alle novizie un piccolo baule per conservare le loro cose che abbandoneranno nel momento in cui prenderanno i voti: un piccolo rito di passaggio, dalla condizione mondana, a una vita dedicata a Dio, alla preghiera e per quel poco che è nelle nostre possibilità, a far del bene al nostro prossimo. È un modo per prendere coscienza del cambiamento. Ho visto che hai bagagli veramente esigui, cosa hai portato con te dal mondo?»
«Poche cose madre, soprattutto libri, scelti con il confessore di famiglia e con l’ausilio del mio precettore.»
«Questo ti fa onore mia cara, la mente è un campo che va coltivato in continuazione. Al momento potrai riporre nel baule anche abito e mantello, da oggi dovrai indossare quello da novizia con la cuffia, anzi a tale proposito, dobbiamo procedere al taglio dei capelli»
«No, i capelli no,» Costanza si portò le mani sul capo, quasi a voler far scudo con le mani della sua chioma e d’istinto arretrò di un passo.
«Ma figliola, è la regola…»
«Vi prego madre, li terrò in ordine e costantemente raccolti, nascosti sotto la cuffia, ma permettetemi di tenerli così sino a quando prenderò i voti.»
La notizia del taglio dei capelli l’aveva sgomentata, se fosse fuggita con i capelli corti, chiunque avrebbe compreso quale fosse il suo stato e non avrebbe perso tempo a denunciarla alle autorità ecclesiastiche.
«Via che sciocchezza è mai questa?»
«Lo avete detto anche voi prima, in fondo di questo si tratta, un simbolo, tagliare con la propria vita precedente…»
«No, questa è solo vanità, Dio non ammette…»
«Allora perché Dio mi avrebbe fatto dono di questa chioma, se poi per compiacere Lui devo mortificare me stessa tagliandola?» La interruppe Costanza.
La badessa rimase interdetta, scosse il capo e sorrise: «sei una impudente e anche presuntuosa, ma apprezzo il tuo modo di argomentare, hai una bella mente, se ti impegnerai otterrai ottimi risultati e forse, chissà, un giorno potresti diventare badessa. E sia, ti concedo di conservare i tuoi capelli, ma non farmi pentire di questo mio atto di misericordia nei tuoi confronti, sii obbediente, studia e andremo d’accordo. Cambiati ora e raggiungi il refettorio, lì ti presenterò al resto della comunità.»
Rimasta sola Costanza potè finalmente rilassarsi: aveva ottenuto ciò che voleva e per giunta le permettevano di conservare quanto aveva portato con sé, abito compreso; si accinse dunque a cambiarsi: non le occorse molto tempo, l’abito da novizia era di fattura molto semplice, quasi frugale, la cuffia, appena un po’ larga, ben si adattava alla sua acconciatura.
Si ricompose psicologicamente, assunse un’espressione neutra e si avviò, pronta ad incontrare la sua nuova famiglia.
V
L’inizio della nuova vita colse Costanza di sorpresa.
Aveva paventato lunghe giornate tutte uguali, dedite alla preghiera, alla contemplazione e alla meditazione, invece aveva scoperto una comunità operosa, dove ognuna aveva compiti precisi.
Le donne del convento non erano solo monache: c’erano le novizie, come lei, tutte più giovani, poco più che bambine, forse alcune di loro infine avrebbero lasciato il chiostro per contrarre qualche matrimonio politicamente importante, c’erano poi le vedove che avevano preso l’abito vedovile dinanzi al vescovo e pur vivendo in convento potevano portare avanti i loro commerci, infine c’erano le converse, donne allo stato laicale che vivevano nel convento e si occupavano di differenti attività all’interno del convento stesso, anche di natura amministrativa e commerciale; una in particolare, Sidiana, godeva della stima e della benevolenza della badessa, che spesso le affidava compiti delicati.
Di norma dormivano in zone separate dalle monache e prendevano i pasti dopo di loro, ma nella quotidianità le loro vite si incontravano.
La badessa esercitava una autorità assoluta, ogni monaca era soggetta al suo imperio.
Costanza comprese molto presto quali fossero i meccanismi che regolavano la vita a Sant’Ariano, era un cenobio composto da una allargata cerchia parentale che gravitava intorno alla badessa: Beatrice, Agnese, Maria, Corradina e Benvenuta appartenevano alla famiglia Michiel e a altre imparentate con questa.
La giovane quindi evitò qualsiasi scontro con queste monache, senza peraltro compiacerle in modo particolare.
Aveva inoltre sviluppato interesse per Marchesina Foscari, una conversa di pochi anni maggiore di lei.
Perché proprio lei? Istinto, poi la vicinanza di età e la comunanza per certi aspetti nella sorte famigliare: Marchesina era infatti figlia illegittima dell’attuale doge e la madre, dal momento che il nobiluomo, pur avendola riconosciuta come sua, non intendeva occuparsene, l’aveva spinta a cercare sostegno all’interno di un convento, non potendo organizzare per lei nozze adeguate.
La giovane non aveva più saputo nulla della madre da quando quattro anni prima aveva varcato la soglia del convento, pur non avendo voluto prendere i voti, in cuor suo aveva comunque detto addio al mondo, da esso si era separata.
Costanza non voleva seguire il suo stesso destino: la conversa era il suo memento quotidiano, si sentiva accomunata a questa donna dalla stessa carestia affettiva che aveva caratterizzato la sua vita fino a allora, purtuttavia molte erano le differenze di carattere e di animo tra le due giovani.
Aveva scelto di non condividere la propria vita con il resto del cenobio: pur essendo monache erano tutto fuorchè sante donne, l’invidia e il sospetto convivevano quotidianamente nei loro rapporti.
Il peggio di loro si esprimeva quando, durante la congregazione delle colpe, le monache proclamavano i peccati commessi: più erano gravi e più le loro sorelle che avevano ascoltato le loro confessioni erano soddisfatte all’idea delle punizioni che quelle avrebbero dovuto subire.
Coloro che non facevano parte del circolo ristretto della badessa, dovevano prestare attenzione al loro comportamento, ivi comprese le visite che ricevevano, le delazioni erano all’ordine del giorno.
La badessa, agendo con cautela, non avendo ancora inquadrato il carattere della giovane, l’aveva affidata a suor Berta perché la introducesse alla conoscenza delle erbe officinali così, ogni mattina, dopo la preghiera, la raggiungeva nel gipresentuosaardino dei semplici.
«Guarda, questo è iperico, le foglie aiutano a cicatrizzare le ferite, lì invece trovi la melissa e la lavanda che sono ottimi calmanti.»
«Quella, sorella, cos’è?»
«Salvia, si masticano le foglie e calma il mal di denti, oltre profumare l’alito, mentre quello è biancospino, utile quando il cuore incomincia a ballare troppo, s usano sia le foglie, che i fiori e i frutti. Ora andiamo in laboratorio» e qui le mostrava i vasi che contenevano la radice di mandragola, la polvere di liquirizia, le foglie di faggio, la corteccia di salice…
Il tempo trascorreva veloce per la giovane, le giornate sembravano non bastare mai, tante erano le cose da apprendere.
Aveva preso l’abitudine di compilare un diario, con gli usi di tutte le erbe, teneva poi un registro di quante ne venivano usate, poiché molte venivano acquistate da mercanti che venivano appositamente in convento.
Costanza si rese presto conto di come la vita del mondo esterno ruotasse intorno al convento.
C’era intanto la gestione dei beni patrimoniali, affidata a un avvocato, Steno Candiano, legato alle famiglie nobili che avevano interessi nel cenobio: Costanza lo aveva veduto con la badessa, era giunto in un pomeriggio d’agosto, sofferente per il caldo, paludato nel suo abito nero, si trattava della medesima persona che aveva preso accordi con suo padre. Allora non vi aveva prestato molta attenzione, questa volta, poiché era stata lei a introdurlo nello studio della Madre, aveva avuto modo di osservarlo più attentamente e non le era piaciuto: non troppo alto, pingue, capelli radi, di un biondo slavato, la carnagione pallida, ma di un pallore malsano, occhi piccoli e scuri che saettavano ovunque, come per timore di essere aggredito.
Aveva mani piccole e grassocce, non molto maschili e la voce nasale: per un qualche motivo a Costanza parve più un chierico che un uomo di legge e soprattutto che di uomo avesse ben poco.
Liquidò questi suoi pensieri con una alzata di spalle, poiché riteneva che non avrebbe mai avuto bisogno dei suoi servigi, preferiva dedicarsi allo studio assiduo sotto l’occhio vigile di suor Berta, l’unica monaca di cui si fidasse realmente; aveva avuto modo di vederla incidere ferite in suppurazione, le aveva insegnato a fare le suture, a far partorire una giovane puerpera e a salvare un neonato di una donna sfiancata dalle troppe gravidanze: aveva praticato un lungo taglio nel ventre della donna ormai morente e ne aveva estratto il piccolo, un taglio netto al cordone ombelicale e due vigorosi colpi sul dorso e aveva emesso il suo primo rabbioso vagito.
Le era toccato assistere impotente alla morte di un’altra per una emorragia dopo il parto.
«Spesso ci chiamano quando è troppo tardi, raggiungere da qui chi ha bisogno di noi, spesso non è agevole, ma c’è anche un altro elemento: la pulizia.»
«Ovvero?»
«Queste povere donne si affidano a delle altre donne perché pensano che noi monache non siamo in grado di aiutarle a partorire, in realtà il nemico più subdolo è la mancanza di pulizia, non mi chiedere per quale motivo, ma ho potuto constatare che le donne che hanno partorito qui e gli uomini che ho curato qui, sono sopravvissuti: io mi limito a lavarmi le mani quando li tocco e a pulire bene i ferri ogni qualvolta li uso, passandoli anche sul fuoco.»
«Chi vi ha insegnato tutto ciò?»
«Un lontano parente che frequentava la nostra casa aveva trascorso molto tempo in Terra Santa e a Bisanzio, dove aveva conosciuto dei medici arabi e da loro aveva appreso queste informazioni e molto altro che mi trasmise, vedendo quanto fossi interessata» e le mostrò una serie di fogli non più grandi di una mano, rilegati con una copertina in pelle sulla quale era inciso a fuoco il suo nome.
«Raccontatemi,» la incitò.
«Ero così presuntuosa da credere che avrei avuto credito nella mia opera come guaritrice, invece da subito il nostro confessore prese a criticare il mio operato e dopo aver parlato con i miei genitori, si recò anche dal vescovo. Rischiavo di dover andare in giudizio, discolparmi da sola, poiché nessun avvocato avrebbe mai patrocinato la mia causa, la gente mi avrebbe visto come una strega. Così chinai la testa, dissi che ero stata una sciocca e presuntuosa e che avrei abbandonato quelle pratiche. Fui io a chiedere di prendere i voti: i miei genitori la considerarono una idea eccellente, avevano altre figlie da maritare, io poi ero diventata imbarazzante, così accondiscesero alla mia richiesta.
Venni qui, la madre badessa, era già colei che anche tu hai conosciuto e le chiesi di affidarmi il giardino dei semplici. Con lei non avevo bisogno di dissimulare, anzi mi incoraggiò ad utilizzare le mie conoscenze, seppure con discrezione, cosa che faccio ancora oggi: chi viene qui ha buone probabilità di salvarsi, le nostre monache godono di buona salute, nonostante l’ambiente diventi ogni anno sempre più malsano.»
Si allontanò da Costanza che teneva ancora in mano il piccolo diario e da uno scaffale prese un volume, grande come uno dei quaterni che costituivano i registri del convento, ma con molti più fogli.
«Questo è il “Libro di Isacco Giudeo degli alimenti e dei rimedi semplici”, riuscii a celarlo nel mio bagaglio quando fui condotta qui, ancora oggi nessuno sa che lo possiedo, nemmeno la badessa.»
«Perché io?»
«Perché mi ricordi me stessa alla tua età, non che siano trascorsi moltissimi anni, ma rivedo in te la stessa curiosità e la voglia di imparare.»
«Grazie per la fiducia che mi accordate.»
«Studiali attentamente.»
In realtà Costanza fece molto di più, si procurò dei fogli che tagliò in fogli più piccoli e la notte, dopo compieta, quando le piccole novizie dormivano profondamente, con l’ausilio di una candela di sego, ricopiava i due libri che la monaca le aveva dato: scriveva sino a quando la candela era ridotta a un mozzicone, allora si risolveva a dormire… per svegliarsi subito dopo per il mattutino.
Non sentiva la stanchezza, tanta era la voglia di imparare e custodiva gelosamente i suoi piccoli quaterni in fondo al baule, occultati in un piccolo doppio fondo dove erano anche pochi gioielli e monete che aveva trafugato da casa, pensando alla sua fuga.
Si era resa conto che ancora non l’aveva pianificata, tanto era stata assorbita dallo studio e dal lavoro e intanto il tempo correva via veloce, già sei mesi erano trascorsi.
VI
Era pieno inverno, le nebbie che salivano dalla laguna avvolgevano l’isola agli occhi del mondo, tuttavia non si percepiva un acuirsi dell’isolamento: operai lavoravano ai guasti prodotti dall’acqua e dalla pioggia, artigiani venivano a versare i canoni d’affitto, parenti, e non solo, di monache e converse, facevano loro visita.
Fu proprio durante questo periodo che scoppiò uno scandalo: complice la nebbia, suor Faustina una notte aveva lasciato aperta la porta sotto l’altare della chiesa che conduceva all’esterno del convento; una suora più anziana, insospettita dal suo comportamento ambiguo, fece irruzione nella sua cella e la trovò in compagnia di un uomo.
La monaca fece grandi strepiti, ma i due riuscirono a fuggire prima che lei potesse dare l’allarme.
Si venne poi a sapere che suor Faustina era incinta e che l’uomo che l’aveva concupita era sposato e aveva altri figli, ma per lei aveva rischiato la galera: insieme avevano abbandonato i domini della Serenissima.
Nonostante tutto la badessa riuscì a mettere a tacere lo scandalo versando alla moglie tradita una considerevole somma di denaro per il mantenimento dei figli e facendo altresì una donazione in suo favore, garantendole così una rendita.
Fu in un tetro pomeriggio di dicembre in cui Costanza era impegnata con Marchesina Foscari a ricamare una tovaglia per l’altare di Santa Fosca, che al convento giunse una visita inaspettata.
Il giovanissimo Federico da Montefeltro, in allora ostaggio della Serenissima, si presentò al convento: avendo saputo della bravura di quelle monache nel preparare medicamenti, cercava qualcosa che lo guarisse dalla tosse che da tempo lo affliggeva.
La badessa, lusingata dall’interesse del figlio di Guidantonio da Montefeltro, lo condusse lei stessa nel laboratorio officinale e mandò suor Berta a chiamare Costanza: aveva seguito con attenzione i progressi della giovane e voleva premiarla facendo si che fosse lei a occuparsi del giovane nobile, non immaginava di compiere così il destino della ragazza.
«Costanza, vieni figliola, la madre badessa vuole che tu la raggiunga subito in laboratorio.»
Senza fare domande la ragazza abbandonò l’opera a cui era intenta, non senza un moto di soddisfazione, a lei non era mai andato a genio il ricamo.
A passo lesto seguì Berta che invece correva, non comprendendo il motivo di tutta quella fretta.
Sulla porta si bloccò interdetta, la badessa si stava intrattenendo con un bambino a cui mostrava tutta la sua deferenza, o forse era per gli uomini al suo fianco? Uno lo riconobbe immediatamente, si trattava di Andrea Dandolo, nobile veneziano, l’altro le era invece sconosciuto: era molto alto, aveva il fisico di un soldato, spalle larghe, braccia possenti, gambe muscolose, frutto di lunghe ore in sella, capelli biondi lisci e lunghi, un viso dai lineamenti regolari, espressivo.
Come se avesse sentito il suo sguardo, l’uomo si voltò e le puntò addosso due iridi verdi come gli occhi di un gatto, stimò che avesse almeno cinque, sei anni più di lei.
«Costanza venite avanti,» lei mosse alcuni passi verso la badessa.
«Mio signore, questa è la nostra giovane erborista e cerusica, sarà lei a consigliarvi il rimedio migliore» e rivolta a lei «questi è messer Federico da Montefeltro, figlio del signore di Urbino e il cavaliere che lo accompagna…»
«Giorgio Ordelaffi da Forlì,» disse l’uomo inchinandosi.
Costanza, imbarazzata si limitò a un cenno del capo e si rivolse al piccolo uomo davanti a lei, «posso sentire il vostro respiro?»
All’assenso del ragazzino, si chinò verso di lui e posò l’orecchio sul suo dorso chiedendogli di respirare profondamente più volte.
«Avete catarro, vi darò della betonica da usare come infuso da bere più volte al giorno, delle foglie di agrifoglio per un decotto da bere anch’esso due volte al giorno e della valeriana: assumetela prima di coricarvi, vi farà riposare impedendo alla tosse di tenervi sveglio,» mentre parlava si era portata vicino agli scaffali e aveva cominciato a armeggiare con i grandi vasi di ceramica.
«Tornate tra tre giorni o mandate qualcuno a prendere altri medicamenti» e di istinto si voltò verso Ordelaffi.
Federico e il cavaliere si limitarono a un cenno di assenso e seguirono la compiaciuta badessa.
A Costanza batteva il cuore: aveva forse trovato la soluzione ai suoi problemi grazie a quei due personaggi.
Le notizie del mondo giungevano anche lì, sapeva chi fosse il signore di Urbino, se avesse risolto il malanno di Federico, forse avrebbe potuto domandare il suo aiuto, o almeno quello del cavaliere, per la fuga.
Furono giorni di spasmodica attesa, i sensi sempre all’erta nel percepire voci e passi di estranei. Berta, che ormai la conosceva bene, si era resa conto di qualcosa di anomalo nel suo comportamento e quando, nel pomeriggio del terzo giorno, Ordelaffi si presentò in laboratorio, vedendo l’impercettibile reazione di Costanza, comprese, o meglio credette di averne compreso il motivo.
Sospirò, aveva sempre pensato che la giovane non fosse adatta alla vita conventuale e aveva avuto anche l’intenzione di mettere a conoscenza la badessa di questo suo giudizio, poi, per un qualche inspiegabile motivo, aveva preferito tacere ora comprese il perché: la sua era una famiglia importante, la badessa non avrebbe mai patrocinato la sua causa contro Marino Contarini, solo con la fuga da quelle mura la novizia avrebbe potuto liberarsi dal giogo di una professione estorta contro la sua volontà e lei le avrebbe dato il suo aiuto, per quello che poteva, anche se per tale azione rischiava il bando.
«Buonasera.»
«Buonasera messere, come sta il vostro giovane signore?»
«Molto meglio grazie, anche se non è completamente guarito, ha bisogno ancora dei vostri rimedi.»
Berta era in imbarazzo, non le fu difficile capire come la sua presenza fosse di troppo, «vado a vedere se la cuoca ha preparato i biscotti per la badessa, così ne prendo per omaggiare il signore Federico» e senza attendere risposta si allontanò dal laboratorio.
«Coltivate voi le erbe?»
«In parte, io e suor Berta, altre le acquistiamo.»
«E voi sareste anche un cerusico?»
«All’occorrenza.»
«Cosa siete in grado di fare?»
«Suturo ferite, estraggo denti, riduco fratture, aiuto le donne a partorire…»
«Complimenti sorella.»
«Non sono una monaca.»
«No?»
«Sono una novizia, non ho fatto ancora professione…»
«Avete dunque preparato ciò che occorre al mio signore?»
«Si certo, ecco…» rispose consegnandogli un pacchetto di erbe avvolte in un panno bianco: le loro mani si sfiorarono, Costanza arrossì violentemente e abbassò gli occhi, Giorgio Ordelaffi si allontanò senza parole di commiato.
Era confusa, per la prima volta una crepa si era aperta nella corazza che si era costruita addosso negli anni, doveva assolutamente riprendere il controllo delle proprie emozioni, ma soprattutto sperava che il cavaliere tornasse nuovamente.
VII
La vita al convento sembrava trascorrere nella normalità: spesso era al capezzale di suor Arcangela, una anziana monaca, entrata in convento come educanda nello stesso anno in cui lei veniva al mondo.
Era stata obbligata alla monacazione a causa di una forte zoppia che l’accompagnava da quando era nata, ma non si era mai rassegnata. Aveva tentato più volte la fuga, vagando tra Sant’Ariano e le isole che costituivano il nucleo di Costanziaco, per essere sempre ricondotta in convento.
La sua mente era ormai offuscata: era una pena sentire i suoi gemiti di disperazione, quando non erano urla strazianti.
Costanza aveva scoperto che le monache incaricate di sorvegliarla la legavano per impedirsi di farsi del male e quando la situazione degenerava, la imbavagliavano perché suore, novizie e converse non fossero disturbate dai suoi lamenti; aveva quindi pregato la badessa di lasciare a lei la cura della poveretta.
La reverenda madre aveva accettato, curiosa di vedere come avrebbe risolto quello che per lei era diventato un problema serio e che ormai faticava a tenere nascosto ai famigliari delle altre monache.
Con infinita pazienza Costanza le somministrava infusi di malva, camomilla e lavanda per calmarla, decotto di erba di San Pietro per farle espellere gli umori dai reni, su consiglio di suor Berta le applicò degli impacchi di borragine sulle escoriazioni che le strette corde le avevano provocato ai polsi e alle caviglie.
Era ormai trascorso anche il carnevale, la primavera era in fase avanzata e la giovane novizia non aveva più avuto notizie né del piccolo Federico, né del suo cavaliere, presto sarebbe giunto il mese di luglio e con esso la cerimonia di professione.
Per non farsi sopraffare dalla disperazione, con la scusa di raccogliere erbe selvatiche di laguna per il laboratorio, si attardava lungo il perimetro dell’isola e riempiva la sporta di salicornia, santonico, enula marina, porcellana di mare.
Spesso si attardava a guardare le fronde delle tamerici bianche di sale, camminava a lungo fino a zone in cui maggiore era lo sbocco di acque dolci e le barene cedevano il posto ai canneti dove nidificavano gli scriccioli, oppure seguiva l’andamento sinuoso di un ghebo in barena, fino a dove alimentava un chiaro.
Nelle giornate limpide il suo sguardo correva verso Torcello e di là, come se si fosse trovata in volo con uno stormo di folaghe, vedeva Burano, Murano e più in là ancora, Venezia.
Poi, la cacofonia dei versi delle beccacce di mare e dei chiurli quando calava implacabile il falco di palude, la riconduceva alla realtà e allora voltava le spalle alla libertà e tornava sui suoi passi, verso il convento, sostando per una preghiera nel camposanto del monastero, invidiando per un momento quelle povere anime che erano sfuggite alla prigione.
VIII
Si era ormai rassegnata all’idea di dover immaginare un altro piano per fuggire da lì prima dell’estate, ancora era titubante al pensiero di renderne partecipe Marchesina, non era poi così certa che questa l’avrebbe aiutata, invece di denunciarla alla madre badessa; un pomeriggio fu proprio lei a venirla a informare che c’era una visita in parlatorio.
Nemmeno per un momento immaginò che potesse essere il cavaliere, pensò invece alla madre e al padre, curiosamente faticava a rammentarne i volti.
Nel parlatorio invece, in piedi vicino a un’ampia finestra, era Giorgio Ordelaffi.
«Sono venuto a prendere commiato madonna, a giorni il mio signore Federico e io lasceremo Venezia, l’epidemia scoppiata in città non lascia presagire nulla di buono, il signore di Urbino ha ottenuto dalla Serenissima di far condurre il figlio a Mantova, come forse saprete, poiché le notizie dal mondo giungono anche qui, Federico era stato inviato a Venezia come ostaggio.»
«Comprendo.»
«Madonna…»
«Dite.»
«Non so per quale motivo sono venuto, proprio non lo comprendo.»
«Vi do io un motivo, conducetemi fuori da questo luogo.»
«Che idea è mai questa?»
«La mia sarebbe una monacazione forzata, vi sto chiedendo di aiutarmi a ritrovare la libertà.»
«Cosa vorreste che facessi per voi?»
«Quando partirete?»
«Tra non più di cinque giorni lasceremo la residenza del doge Foscari.»
«Trovate una barca e tra due notti a partire da oggi a mezzanotte fatevi trovare al pontile, io sarò lì.»
«E poi?»
«Sarà sufficiente che mi lasciate a Burano, da lì troverò più facilmente chi mi possa condurre sulla terraferma.»
«È tutto madonna?»
«Si signore, non chiedo altro, saprò cavarmela… Almeno spero.»
Ordelaffi annuì, «sta bene, da qui a due giorni verrò a prendervi.»
«Dio ve ne renderà merito.»
«Ne siete certa?»
«Dio non può essere contento di una monaca a cui sono stati fatti pronunciare i voti contro la propria volontà.»
«Ce ne sono molte.»
«Appunto, non è necessario che ce ne sia una di più.»
Senza aggiungere altro Ordelaffi le prese le mani, pose un lieve bacio sui suoi polsi e si accomiatò.
Uscendo dal parlatorio incontrò Marchesina Foscari: Costanza non aveva desiderio di intrattenersi, ma la conversa le si parò davanti, bloccandole il passaggio, «dunque anche voi ricevete visite particolari.»
«Che dite, era il cavaliere del signore Federico da Montefeltro, è venuto a ringraziare per i servigi resi al suo signore e a accomiatarsi, poiché a breve lasceranno Venezia.»
«E ha chiesto di voi e non della badessa?»
«Non so che dire, avrà parlato prima con la reverenda madre.»
«No, dal momento che l’ho accolto io e mi ha chiesto solo di voi.»
«Allora non so che dire.»
«Vi spiegherete con lei» e si allontanò.
Non trascorse molto tempo che venne convocata nello studio della badessa.
«Dunque Costanza, come mai non sono stata informata di questa visita?»
«Sono spiacente madre, non immaginavo che il cavaliere Ordelaffi mi avrebbe fatto visita.»
«E secondo quanto ha raccontato a Marchesina, sarebbe venuto per ringraziare e accomiatarsi, di solito chi ringrazia non si limita alle sole parole, reca dei doni.»
«A me non ha lasciato nulla, Marchesina mi ha incontrata all’uscita del parlatorio e potrà confermarvi che in mano non avevo nulla.»
«Levati l’abito.»
«Come?»
«Hai capito, levati l’abito.»
Lacrime di rabbia e di vergogna le riempirono gli occhi ma non disse nulla, serrando le labbra si spogliò completamente.»
La badessa comprese immediatamente di aver commesso un grave errore e di aver dato dimostrazione di grettezza e avidità, ma il danno era fatto, non poteva rimediare, né tantomeno domandare scusa.
«Bene, rivestiti e torna pure alle tue occupazioni.»
Costanza ubbidì e senza ulteriori commenti voltò le spalle alla monaca e uscì dallo studio: fremeva di ira repressa, se avesse avuto la conversa tra le mani… Ma non poteva, avrebbe rischiato di rovinare tutto.
Si impose la calma e tornò verso il laboratorio, nel corridoio lungo il chiostro Marchesina attendeva, ma non ottenne soddisfazione.
Rabbia e eccitazione le impedirono di dormire quella notte, la mattina dopo era distratta, Berta comprese immediatamente che c’era qualcosa di strano.
«Figliola, cosa ti accade?»
«Nulla sorella, va tutto bene.»
«Non mentire con me, sei in questo stato di angoscia da quando è venuto a farti visita messer Ordelaffi.»
«No, vi assicuro.»
«Gli hai chiesto di aiutarti a fuggire dal convento?»
«Cosa dite?»
«Non sono cieca e soprattutto sono consapevole del fatto che non saresti una buona monaca, come pensi di fare?»
«Verrà domani notte, mi porterà via con una barca,» sussurrò Costanza.
«E come uscirai dal convento? Pensi sia sufficiente aprire il portone?»
«Pensavo di approfittare della porta vicino all’orto, oppure di quella sotto l’altare.»
«No, su quel lato affaccia la stanza della badessa: la madre ha il sonno leggero, se ne avvedrebbe, l’altra invece dopo lo scandalo di suor Faustina è sprangata dall’esterno.
La superiora inoltre non potrebbe tacere il fatto alle altre consorelle e Marchesina Foscari ne approfitterebbe per informarne il doge: tu hai sempre pensato che quella conversa ti fosse amica, non hai capito che stava al tuo fianco solo per trarne qualche vantaggio.»
La giovane non profferì parola, pensando all’episodio del giorno precedente e che preferì tacere alla monaca, lo sconforto si leggeva sul suo viso.
«Nessuno è al corrente che dal laboratorio si dirama un vecchio cunicolo, retaggio della più antica costruzione del convento, probabilmente esisteva già dai tempi dei primi abitanti di queste isole, forse serviva in caso di attacchi nemici provenienti dalla terraferma, arriva sino al pontile di attracco delle barche… Ecco vedi, è qui l’ingresso,» disse spostando una botte.
«Ti lascerò una candela e un mantello pesante, questa è la seconda chiave del laboratorio, la feci fare tempo fa da un fabbro che era venuto a riparare dei chiavistelli, nemmeno la badessa ne conosce l’esistenza, ero certa che prima o poi sarebbe servita.
«Sorella, io non so cosa dire.»
«Ricordati di portare con te i quaterni,» disse con un sorriso.
«Voi sapete…»
«Le altre non lo notavano, men che meno la badessa, convinta del tuo carattere così mite, ma a me non potevano sfuggire le tue occhiaie, né il fatto che mancassero delle candele dalla scorta, ho faticato non poco a convincere Sidiana che aveva fatto male i conti. Ricordi che poi fosti tu incaricata di tenere la contabilità dei prodotti di consumo del convento?»
«Non dimenticherò ciò che fate per me.»
«Ne sono certa, ora però continuiamo a lavorare, aiutami con queste preparazioni, così quando sarò nuovamente sola, il mio impegno non sarà troppo gravoso,» riprese a lavorare come se nulla fosse e Costanza con lei.
IX
E venne il giorno successivo, ad esso seguì la sera e poi la notte.
Dopo compieta si ritirò con le piccole novizie e si mise a letto fingendo di dormire.
Una mezz’ora prima della mezzanotte, accertatasi che le novizie dormissero profondamente e che nessun suono si sentisse tra le mura conventuali, Costanza uscì dal dormitorio: aveva indossato il suo vecchio abito e preso un fagotto contenente le monete, i gioielli, i suoi quaterni e un paio di pianelle con la suola in legno per quando fosse stata all’aperto, in mano teneva salda la chiave del laboratorio.
Attraversò il giardino dei semplici, aprì con cautela la porta, era ben oliata e non fece rumore, la richiuse immediatamente dietro di sé con la chiave che nascose in un vaso vuoto vicino al bancone; si avvicinò alla botte che le aveva mostrato il giorno precedente suor Berta, sopra erano appoggiate due candele e un piccolo pacchetto che la giovane suppose fossero erbe.
Spostò la botte, entrò nel cunicolo e accese una candela, ricollocò la botte al suo posto e si avviò.
Il percorso non era lungo, ma a lei parve eterno, temeva che il rumore dei suoi passi rimbombasse all’esterno, nella quiete del chiostro. Vide una luce farsi sempre più vicina, finalmente fu all’aperto, proprio a fianco del vecchio pontile su cui aveva attraccato l’imbarcazione che un anno prima l’aveva condotta lì.
Non dovette attendere a lungo, sentì, prima che vedere, lo sciabordio del remo, poi ecco comparire una barca: riconobbe la figura del cavaliere in piedi al centro dello scafo, dietro di lui a poppa, un unico vogatore.
La barca finalmente attraccò, Ordelaffi scese sul pontile.
«Madonna voi tremate.»
«Ho solo un abito leggero sotto il mantello, è tutto ciò che possiedo.»
«La barca ci condurrà a Burano, lì sarete ospite del mio barcaiolo, Vittore, non temete, non ne farà parola con alcuno, avrebbe troppo da rimetterci. Salite ora, presto saremo arrivati e potrete riposarvi.»
Costanza prese posto sull’imbarcazione, stretta nel pesante mantello di ruvida lana, ancora incredula all’idea di essere davvero riuscita nel suo intento, fuggire dal monastero; il pensiero corse fugacemente a suor Berta: si augurò in cuor suo che la monaca non dovesse subire ritorsioni o peggio ancora, che venisse accusata di complicità. Temeva inoltre che la potessero rintracciare e rabbrividiva all’idea di quale avrebbe potuto essere la pena da scontare per aver osato tanto.
Le parve di essersi appena assopita, quando due braccia la scrollarono dolcemente, «Costanza siamo arrivati, ancora un piccolo sforzo» e la sollevò quasi di peso per farla scendere a terra. Lei era ancora intorpidita e lo lasciò fare, a terra seguirono Vittore che li condusse alla propria abitazione, ironia della sorte, non troppo distante dal monastero della Valleverde: pochi rapidi colpi e la porta si aprì, una donna li accolse, sul viso rughe di preoccupazione.
«Questa è mia moglie, Cantaruta, si occuperà di voi signora.»
«Santo cielo, ma è poco più di una bambina.»
«Ho quasi vent’anni,» fu la debole protesta.
«Sembrate più giovane, venite ora, vi preparo una tazza di brodo caldo e un bicchiere di vino: lo produciamo qui a Mazzorbo» e le versò una dose generosa di liquido ambrato, poi scodellò della zuppa.
«Dormirete meglio dopo,» le disse, porgendole la scodella fumante e indicandole il giaciglio vicino al fogher.
«Io tornerò domani per vedere come state,» poi Ordelaffi posò una piccola borsa di pelle sul tavolo e se ne andò.
Costanza assaporava il brodo e con esso la ritrovata libertà, mentre marito e moglie la osservavano in silenzio, intimiditi dalla presenza di quella giovane che, seppur nella semplicità del suo abbigliamento, si intuiva essere di buona famiglia.
«Grazie ancora dell’ospitalità e perdonate l’incomodo…» iniziò a dire.
«A messer Ordelaffi non si può negare nulla, ora distendetevi al caldo e cercate di riposare,» la interruppe Cantaruta accompagnandola al giaciglio.
I due si ritirarono nella stanza attigua, lasciandola sola.
Fu allora che prese realmente coscienza della sua nuova situazione: lentamente portò le mani alla nuca e sciolse i capelli, le due trecce caddero pesantemente sulle spalle e a poco a poco liberò i capelli dall’intreccio, infine scrollò il capo, la sua chioma riprese corposità, le parve di essersi tolta un peso che da troppo tempo gravava sulla sua testa.
Si distese e si dispose a dormire, temeva di non riuscirvi, per via della tensione che l’aveva accompagnata e che ora a poco a poco andava sciogliendosi, ma appena chiuse gli occhi scivolò in un sonno profondo e senza sogni.
«Madonna è ora di levarsi,» Cantaruta con un tocco leggero come una piuma, svegliò Costanza, «se volete potete andare nell’altra stanza per sistemarvi.»
Ancora intontita Costanza fece un cenno affermativo con il capo, si alzò e si diresse con le sue cose nell’altra camera: qui regnava un piacevole tepore, aprì il pacchetto che le aveva lasciato suor Berta, c’era un piccolo pezzo di sapone odoroso di verbena, una fiala ben chiusa e tanti altri piccoli pacchetti con erbe diverse.
Fece le sue abluzioni, aprì l’ampolla, era acqua di rose, ne passò con parsimonia sul viso e sul collo, con un paio di foglie di menta si strofinò denti e gengive, poi si sciacquò la bocca.
Si rivestì, prese una spazzola che era appoggiata vicino alla brocca dell’acqua e diede lunghi colpi di spazzola alla sua capigliatura, sino a farla diventare lucente.
Raccolse le sue cose e tornò nell’altra stanza, nel frattempo era giunto Giorgio Ordelaffi: stava parlando con Vittore quando lei fece il suo ingresso in cucina, il giovane si interruppe bruscamente, la fissò, «buongiorno madonna.»
«Buongiorno signore.»
«Vi vedo fresca e riposata.»
«Si, ho dormito profondamente.»
«Data la stagione, vi ho portato abiti più adeguati,» ammiccò a quanto aveva appoggiato sul tavolo: una lunga camicia di spesso cotone, una camora in velluto con maniche pesanti blu scuro, calze di panno scarlatto e pianelle solate in velluto.
«Grazie, come potrò ricambiare la vostra gentilezza?»
«Non mi dovete nulla.»
«Quando partirete?»
«Dopodomani al più tardi.»
Cadde il silenzio tra loro, Giorgio incantato guardava i capelli della giovane sciolti morbidamente sulle spalle, le fiamme del camino le donavano riflessi ramati che sembravano dare vita alla chioma.
«Messere, conducetemi con voi.»
«E con quale ruolo di grazia?»
«Conosco le erbe, ho esperienza come cerusico, so ricamare…»
«Madonna, non è una corte quella che si sposta, ma un gruppo di uomini in arme.»
«Avete detto che andate a Mantova, permettete che io faccia il viaggio sotto la vostra protezione e quella del vostro signore, in città lui stesso potrà raccomandarmi presso qualche nobile famiglia.»
Implorava, era angosciata all’idea di venire abbandonata, ora che si ritrovava nel mondo da sola, aveva perso tutta la sua sicurezza.
«Andate a cambiarvi o vi buscherete qualche malanno.»
Costanza si allontanò, Giorgio Ordelaffi in piedi al centro della stanza pareva riempirla tutta con la sua sola presenza.
Vittore e Cantaruta in un angolo, avevano assistito in silenzio al loro dialogo, dopo un breve cenno d’intesa, la donna prese coraggio e parlò: «signore, noi la ospiteremmo più che volentieri, ma già si sarà sparsa la notizia della fuga. Di certo non la cercheranno subito qui a Burano perché è troppo vicino e penseranno che si sia allontanata di più, ma l’isola è piccola e un viso nuovo si nota subito e anche noi potremmo passare dei guai, sarebbe davvero meglio se la conduceste via con voi.»
L’uomo non controbattè, nel frattempo Costanza era rientrata nella stanza.
«Spero di non dovermene pentire. Vittore, prendi la tua barca subito e accompagna madonna Costanza verso Venezia, poi proseguirai verso la terraferma lungo il Canal Salso, là all’approdo troverai una locanda, sull’insegna è intagliata una grande barca dipinta di bianco e rosso con un drago come polena: il locandiere mi conosce, gli consegnerai questo denaro e questo biglietto con il mio sigillo» e prese dalla scarsella un pezzo di pergamena e della ceralacca, vi impose il suo anello, lasciando impresso lo stemma della casa degli Ordelaffi, poi riprese «gli dirai che nessuno dovrà sapere della presenza di madonna Costanza, che si unirà a noi appena giungeremo in terraferma.»
Vittore fece un cenno affermativo e si apprestò a uscire.
«Grazie signore.»
«Andate con lui ora, siate cauta, quando giungerete a destinazione non uscite dalla vostra stanza sino a quando arriverò e vi manderò a chiamare.»
Costanza non ribatté, si limitò a indossare il mantello, coprì la sua vistosa chioma e seguì Vittore.
Il tragitto fu molto più lungo di quello dell’anno precedente e questa volta trascorse il tempo riflettendo sul futuro.
Non le era certo mancato il coraggio, ma adesso era piena di dubbi: per vent’anni aveva vissuto protetta, ora sarebbe stata in balia di se stessa e degli accadimenti che il fato avrebbe messo sulla sua via.
Improvvisamente sentì una forte nostalgia per la sicurezza del suo laboratorio e per sorella Berta, ma soffocò sul nascere quello stato, doveva guardare avanti.
X
Al monastero nel frattempo la comunità era in fermento, avevano scoperto la sua assenza quando non si era presentata al mattutino e dopo averla fatta cercare in tutti gli edifici di cui era composto il convento, la badessa era giunta a conclusione che fosse fuggita, ma non riusciva a comprendere come potesse esserci riuscita.
Suor Berta, temendo di venire convocata e di subire un controllo nel laboratorio, vi si era recata immediatamente: aveva sistemato la botte in modo tale che l’ingresso al cunicolo fosse completamente occultato, recuperato la chiave, messo a posto il vaso. Si guardò in giro e soddisfatta, uscì.
Era nella galleria attorno al chiostro, quando vide Marchesina Foscari venirle incontro; fece un profondo respiro, atteggiò il viso a una sicurezza che non provava e attese.
«Suor Berta, la madre badessa vuole parlare con voi subito.»
Certamente quella vipera doveva averle instillato il sospetto che lei fosse al corrente di qualcosa o che addirittura l’avesse aiutata a fuggire.
Entrò nello studio della badessa, la conversa con lei.
«Entrate suor Berta, Marchesina chiudete la porta.»
La monaca si dispose a ascoltare, sul suo viso traspariva la più completa serenità.
«Suor Berta, la nostra conversa sostiene che voi siete al corrente dei piani di fuga di Costanza e che in qualche modo l’avete aiutata.»
«Non vedo come avrei potuto reverenda madre.»
«Voi le dovete aver indicato una via di fuga,» intervenne la conversa.
«E quale? Conosco il convento quanto voi e non mi risulta ci siano uscite segrete, voi reverenda madre siete al corrente di qualcosa di simile?»
«No, da che il monastero è stato costruito e ricostruito dopo l’incendio, non sono mai venuti alla luce passaggi segreti.»
«Ma proprio l’altro giorno Costanza si è intrattenuta con il cavaliere…»
«Via Marchesina, non penserete che un cavaliere del seguito del signore Federico si sia lasciato coinvolgere in una vicenda simile e comunque non posso certo scomodare il signore per tale questione, il doge stesso fermerebbe ogni mia azione,» la interruppe la badessa.
Calò il silenzio, la conversa appariva contrariata, Berta non potè fare a meno di sorridere tra sé.
«Bene, poiché a breve il vescovo mi chiederà conto di questa vicenda e messer Contarini anche, dovremo farci trovare preparate: parlate con tutti coloro con cui Costanza può aver avuto a che fare, magari scoprirete qualcosa.»
«Reverenda madre, se posso, suggerirei di sentire soprattutto coloro che vengono da Lio Bianco.»
«E perché mai?» Si intromise la conversa.
«Perché sarebbe stato più facile per lei guadagnare la terraferma verso quel tratto di costa che non transitando per Venezia dove rischierebbe di essere riconosciuta,» rispose suor Berta, guardando la madre badessa e ignorando volutamente Marchesina.
«Avete ragione suor Berta, è da li che inizierete le vostre ricerche, ve ne occuperete insieme, andate ora.»
Suor Berta e Marchesina Foscari lasciarono lo studio della badessa.
«Non mi incantate, vi controllerò, prima o poi commetterete un passo falso,» le sibilò la conversa appena oltre la porta, la monaca fece mostra di non aver raccolto l’avvertimento.
XI
A Ca’ Zoiosa Federico ebbe modo di forgiare il suo carattere, di approfondire la sua erudizione e di migliorare le sue condizioni fisiche: studiava filosofia, retorica, ma anche aritmetica e geometria, latino, greco, musica canto e disegno, oltre all’attività fisica quotidiana.
La scuola di Vittorino da Feltre, dove era stato accolto, si situava tra il castello di San Giorgio e la Magna Domus ma isolata da questi due edifici.
Quando giunsero a Mantova, Costanza per volere di Federico venne ospitata proprio nella Magna Domus, che era la parte più antica della cittadella gonzaghesca: le stanze che occupava erano al secondo piano e le sue finestre, a sesto acuto, affacciavano a est, dove si trovava il Palazzo del Capitano, che al pari della Magna Domus, era la parte più vetusta del complesso: quando l’aveva veduta per la prima volta, ne era rimasta impressionata, con la facciata che poggiava su un portico gotico sul quale si affacciava un primo ordine di piccole finestrelle sormontato da un secondo di bifore gotiche; al primo piano erano le gogne, gabbie dove venivano esposti i condannati al pubblico ludibrio, in tutto simili alle chebe veneziane.
In questo edificio aveva preso dimora Giorgio Ordelaffi, per essere vicino al suo signore con una protezione discreta.
Federico aveva accettato di buon grado la sua presenza, senza domandare spiegazioni a Giorgio Ordelaffi: apprezzava la discrezione di Costanza, la sua riservatezza e soprattutto le sue qualità di erborista quando andava da lei acciaccato dai colpi ricevuti durante le esercitazioni.
Dal canto suo lei cercava di farsi notare il meno possibile.
In principio quella compagine completamente maschile l’aveva atterrita, ma la costante presenza del forlivese aveva evitato spiacevoli incidenti.
Capitava che venisse convocata a Ca’ Zoiosa per impartire i rudimenti della scienza erboristica ai giovani che frequentavano il convitto, tra cui Federico e approfittava di quelle occasioni per prendere in prestito qualche volume e approfondire così le sue conoscenze mediche.
Aveva inoltre fatto amicizia con alcune giovani donne della corte gonzaghesca: furono loro a condurla per le vie della città, fino alla bottega di Bonforte da Concorezzo, famoso mercante di lana e stoffe.
Quando giunse di fronte alla bottega, Costanza rimase interdetta: a Venezia non aveva mai avuto modo di vedere botteghe così sontuose, l’edificio era su tre piani, la bottega era sotto il portico, le decorazioni in rilievo in cotto di finestre e colonnine pensili erano ricoperte di foglie d’oro su fondo rosso e in parte le ricordavano il palazzo sul Canal Grande della sua famiglia.
Sotto il portico vi era un’iscrizione con inciso il nome del proprietario, mentre sull’architrave sopra l’ingresso della bottega vi era un bassorilievo con riprodotte le merci in vendita.
Costanza varcò la soglia della bottega, il mercante stesso le venne incontro, avendo visto la giovane in compagnia con delle dame di corte, immaginò trattarsi di una persona facoltosa.
In quel frangente la figlia del mercante emerse in tutta la sua prepotenza: la donna non si fece intimidire né confondere, soprattutto nella scelta delle stoffe, poiché ben sapeva cosa cercava; in ultimo contrattò sul prezzo con tale accanimento e abilità da farla credere una consumata commerciante veneziana.
Tornò verso palazzo con i suoi acquisti, lieta di essere riuscita nel suo intento e soprattutto di aver superato la prova del rapporto con persone a lei sconosciute in maniera brillante.
Quando il cavaliere ne venne a conoscenza si infuriò e recatosi alla Magna Domus la redarguì malamente, la giovane ne fu mortificata.
Avendo compreso di aver esagerato, Ordelaffi cercò di correggere il tiro, «dovete capire che un simile atteggiamento potrebbe divenire un fatto noto e finireste per essere sulla bocca di tutti e essendo veneziana, la notizia potrebbe giungere alle orecchie dell’ambasciatore.»
«Non avevo riflettuto su questo aspetto.»
«Il signore Federico è stato armato cavaliere, tra pochi mesi lasceremo Mantova per rientrare a Urbino dove saranno celebrate le nozze di Federico con Gentile Brancaleoni: la sua futura sposa è vostra coetanea, verrete al seguito, potrete diventare una delle sue dame di compagnia.»
Costanza, già al corrente della prossima partenza del giovane signore, non aveva osato sperare in una simile fortuna, fu un sorriso di autentica gioia più che di gratitudine quello che rivolse a Ordelaffi lasciandolo interdetto.
Federico era però un uomo d’arme e trascorse ben poco tempo con la sua giovane moglie, entrando nella compagnia di ventura di Niccolò Piccinino.
Nel Millequattrocentotrentotto ottenne la sua prima condotta, sotto le insegne del duca di Milano Filippo Maria Visconti: furono anni di intensi combattimenti, aspre battaglie, sino alla fine del Millequattrocentotrentanove quando, ferito seriamente durante l’assedio di Campli, dovette rientrare frettolosamente a Urbino per curarsi.
Fu Costanza, su precisa richiesta di Federico, a prendersi cura di lui: la donna non si risparmiò, mettendo a frutto tutto quanto aveva appreso da suor Berta, dall’osservazione dei medici della corte gonzaghesca e soprattutto quanto aveva studiato sui libri che Vittorino da Feltre le aveva permesso di leggere durante il soggiorno mantovano: utilizzava quotidianamente dell’olio di iperico per accelerare la cicatrizzazione, controllava le suture e cambiava le bende dopo aver disinfettato con aceto le ferite, preparava impiastri di emula per evitare le piaghe, gli somministrava infuso di foglie di erba stella dalle proprietà calmanti.
Giorgio Ordelaffi, saputo dell’incidente, aveva abbandonato Forlì per rientrare a Urbino: quando Federico nel maggio dell’anno precedente si era fermato a Forlì prima di raggiungere Milano, nel suo incontro con Antonio Ordelaffi aveva chiesto espressamente al signore della città che Giorgio fosse definitivamente posto al suo servizio.
L’incontro con Costanza avvenne in maniera insolita, fu quasi uno scontro: lei usciva dalla camera dell’infermo, l’altro era appena giunto e aveva urgenza di raggiungere il suo signore, quando nel corridoio di palazzo si trovarono l’uno nelle braccia dell’altro; Costanza ebbe la peggio, andando letteralmente a sbattere sul torace dell’uomo, rivestito della corazza.
«Madonna vi domando perdono, vi siete fatta male?»
«Colpa mia cavaliere, ero disattenta, ben tornato a Urbino.»
«Come state dunque?»
«Io bene, ma credo sia il caso che andiate dal nostro signore, vi attende.»
«Si certo, a dopo.»
Costanza si sentiva sottosopra e non per il colpo infertole, da tempo non vedeva il cavaliere e non immaginava che ritrovarselo dinanzi all’improvviso le avrebbe provocato una simile reazione, né poteva sapere che la stessa sensazione l’aveva provata Giorgio Ordelaffi.
La reazione di quest’ultimo fu alquanto repentina e per nulla ponderata; gli avvertimenti del Montefeltro furono lettera morta, così come le accorte considerazioni di madonna Gentile, aveva intenzione di fare di testa sua, come sempre.
Dopo aver preso commiato dal Montefeltro, si recò nella sala dove le dame di corte erano solite riunirsi.
Quando fece la sua comparsa, il leggero chiacchiericcio si smorzò di colpo, Costanza sollevò lo sguardo per capire cosa fosse avvenuto e si avvide della sua presenza.
«Madonna Costanza dovrei parlarvi,» senza aspettare si voltò e uscì dalla sala, la giovane appoggiò il ricamo e lo seguì: le tornò improvvisamente alla memoria una scena analoga avvenuta diversi anni prima e curiosamente, anche allora Giorgio Ordelaffi ne faceva parte.
Si ritrovarono fuori dal palazzo comitale, sulla piazza su cui aggettava anche il duomo cittadino. Era una tiepida giornata di sole di fine dicembre, fu Giorgio Ordelaffi a rompere il silenzio.
«Costanza, avrei dovuto domandarvelo subito quando vi ho conosciuta, ma per qualche motivo me ne è sempre mancato il coraggio, volete diventare mia moglie?»
«Ma la vostra famiglia…»
«Sono un figlio illegittimo che ha scelto di mettersi al servizio dei Montefeltro, nessuno pensa a me.»
«In fondo ci assomigliamo, io praticamente sono senza famiglia.»
«Allora costruiamo il nostro sodalizio.»
«D’accordo.»
«Non vi pentirete di avermi dato fiducia.»
«Ve la diedi sei anni fa, lo avete dimenticato?»
XII
Per Costanza gli anni della tranquillità erano improvvisamente terminati: con il matrimonio aveva iniziato a seguire il marito che combatteva nell’esercito mercenario di Federico da Montefeltro.
Più volte si trovò a ridosso del campo di battaglia, impegnata con altri cerusici a soccorrere i feriti: abito, mani e viso imbrattati di sangue, i capelli raccolti alla bene e meglio, si prodigava sino allo strenuo, senza dimenticare le nozioni impartitele da suor Berta, anche se a volte doveva improvvisare a causa della mancanza di bende e altro.
Al termine di ogni scontro si sentiva svuotata, sia per la fatica fisica che psicologica: in ogni soldato che vedeva aveva timore di riconoscere le fattezze del marito, paventava il momento in cui avrebbe dovuto soccorrerlo perché ferito, o per ricomporre le sue membra straziate da una bombarda, ma Giorgio pareva invincibile.
«Ho promesso di non deludervi, non posso abbandonarvi,» era solito dire quando, nella calma innaturale che seguiva a ogni battaglia, avevano modo di ricongiungersi.
Costanza non riusciva a comprendere come si potesse vivere in quel modo, a volte lo pregava di smettere, che la generosità di Federico li aveva resi benestanti se non ricchi, ma l’uomo ribatteva che non conosceva altro mestiere che quello delle armi.
A luglio del Millequattrocentoquarantaquattro Federico si trovava a Pesaro quando fu assassinato il fratellastro Oddantonio: informato dell’accaduto, alle prime luci dell’alba partì alla volta di Urbino, Giorgio e Costanza al suo seguito.
Giunto a Urbino si fece immediatamente proclamare signore della città, amnistiò i partecipanti alla congiura e allontanò le sorellastre, Violante Agnesina e Sveva, facendoloro contrarre buoni matrimoni.
«Ma non capite che così facendo dà forza alle voci che lo indicano come il mandante dell’omicidio del fratello?»
«Via Costanza, Oddantonio era crudele e odiato dalla sua gente, nessuno lo rimpiangerà e Federico ben presto farà dimenticare queste voci.»
Anni dopo Giorgio Ordelaffi fu smentito in questa sua affermazione: il signore di Urbino si vide costretto a reprimere nel sangue la congiura ordita da parenti e amici del fratellastro e in seguito dovette sedare la rivolta di Fossombrone, sobillata dal Malatesta la sua spina nel fianco; per tre giorni la città fu messa a ferro e fuoco da seicento dei suoi migliori balestrieri.
Era un uomo d’arme, che sapeva essere crudele e violento, ma Costanza gli riconosceva un mecenatismo senza eguali: grazie alle innumerevoli condotte che lo avevano reso ricco, aveva iniziato tra l’altro una collezione di manoscritti, prodromi di quella che sarebbe diventata una delle più grandi biblioteche del loro tempo, a cui Costanza aveva avuto da subito libero accesso.
Nonostante le innumerevoli battaglie combattute, rischiò la vita durante un torneo a Urbino, nel Millequattrocentocinquantuno: durante il secondo combattimento nella giostra venne ferito da un colpo di lancia che, sollevatagli la visiera dell’elmo, gli tranciò l’osso nasale e gli si conficcò nell’occhio destro.
Costanza, consapevole di non potergli salvare l’occhio, si prodigò affinché la ferita non suppurasse. Federico non era un bel vedere in quei giorni e il forte dolore la obbligò a sedarlo a lungo con un infuso di semi di papavero.
A poco a poco l’uomo riprese vigore e tornò alle sue normali attività; la palpebra era rimasta pendula e si vedeva il bianco del bulbo oculare, così risolse di portare una benda sull’occhio offeso.
Anche il suo profilo ora era singolare, il colpo, tranciando l’osso nasale, aveva creato un angolo retto: ben presto nacque la leggenda che si fosse fatto togliere apposta quella parte di naso per avere una visione migliore con l’occhio sano.
Costanza aveva con lui il suo bel daffare, nonostante l’età non avanzata Federico soffriva anche di gotta, il dolore a un piede spesso gli impediva di dormire: così le scriveva, pentito di non aver seguito la rigida dieta che lei gli aveva prescritto né di aver bevuto con continuità la tisana di ribes nero e ciliegio, promettendole di porvi rimedio… Fino alla volta successiva.
La sua corte stava diventando un ricettacolo di artisti, letterati, teologi, maestri d’arme: bisognava realizzare una dimora adeguata, che non fosse da meno rispetto alle regge più fastose dell’epoca.
Iniziò quindi ad acquistare alcune abitazioni limitrofe alla proprietà di famiglia, facendole inglobare in una nuova costruzione, ma non era ancora ciò che voleva.
In questo suo desiderio di donare alla città e a se stesso un luogo che li rappresentasse, Costanza rivedeva suo padre.
Occorsero anni e il genio di un arista dalmata: la novità, lo splendore del palazzo stava nel non essere chiuso in una strada e neppure in una città, la parte che affacciava sulla piazza aveva una invitante rientranza, un cortile da cui si accedeva alla biblioteca e allo scalone d’onore; la parte aggettante all’esterno, affacciata sul paesaggio urbinate, era la prima cosa che si mostrava al viaggiatore prima che entrasse in città.
Costanza ne aveva seguito con interesse le fasi costruttive, nulla di simile si era mai visto in laguna: se il palazzo dei dogi rappresentava la magnificenza, questo riproduceva forza e eleganza, era il simbolo del signore di Urbino, lo connotava appieno.
Aveva apprezzato inoltre le splendide decorazioni realizzate da Paolo Uccello, il pittore aveva soggiornato a Venezia, ma in anni lontani quando lei ancora era una ragazzina e solo ora poteva ammirarne appieno il genio.
Finalmente Giorgio si arrese alle continue richieste della moglie di abbandonare la vita del soldato, lei aveva desiderio di tranquillità e sebbene non avessero avuto figli, potevano ora godere della compagnia reciproca, avviarsi a una serena vecchiaia insieme.
Di tanto in tanto Costanza tornava con la memoria al convento di Sant’Ariano, a quell’isola persa tra i canneti e le acque della laguna da cui aveva avuto la fortuna di trovare infine la sua strada.
A volte rileggeva i suoi quaterni a cui aveva aggiunto nuove pagine fitte di appunti, frutto dell’esperienza fatta sul campo nei lunghi anni di guerra al seguito del marito.
Ripensava alla sua famiglia, ai suoi fratelli: non aveva modo di sapere se avessero dissipato o meno la fortuna di famiglia.
Si domandava se un giorno sarebbe potuta tornare nella sua città, più il tempo trascorreva, e più si acuiva la nostalgia di Venezia, dei suoi palazzi affacciati sul Canal Grande, dei colori che le diverse stagioni disegnavano tra acqua e cielo sulla laguna.
Si era trovata bene a Mantova che in parte era una città d’acqua, essendo nata sul Mincio, il fiume che intorno ad essa formava quattro laghi, dove era possibile vedere ranuncoli d’acqua e poi folaghe e germani reali.
Urbino invece era una rocca formidabile, il paesaggio intorno di un verde brillante, ma mancava l’elemento con cui lei aveva convissuto da quando era venuta al mondo.
Federico, pensando di farle cosa gradita, le aveva donato splendidi vasi e bicchieri di vetro di Murano finemente lavorati e in ultimo aveva fatto giungere espressamente per lei alcuni volumi a stampa, i primi del loro genere, realizzati proprio a Venezia.
Il marito si avvedeva di questa sua malinconia, «non credo sia una buona idea tornare a Venezia.»
«Ma chi volete che rammenti la fuga di una novizia di venti anni fa? Il doge allora in carica è morto da tempo, non sappiamo nemmeno se messer Dandolo che vi accompagnò quel giorno al convento, sia ancora vivo. Porto il vostro nome e la mia chioma non è più fulva come allora.»
«Gli occhi e i vostri lineamenti però non sono cambiati signora, a me sembrate ancora la giovane che mi trafisse con il suo sguardo la prima volta che ci incontrammo nel laboratorio erboristico.»
«Questa poi.»
«Non credete alle mie parole?»
«Considerando quanto ho dovuto penare per convincervi a portarmi con voi.»
«Questo è ciò che credete.»
«Che intendete dire?»
«Che avrei accettato una qualsiasi soluzione pur di portarvi con me, anche quella di andare da vostro padre per convincerlo a non obbligarvi a prendere i voti.»
«Certo signore che siamo una coppia inusuale, una monaca mancata e un figlio illegittimo.»
«Eppure mia signora, abbiamo dimostrato di essere persone per bene e affidabili nonostante le nostre origini.»
«Si avete ragione, ciò non toglie però che abbiate sviato il discorso.»
«Ne riparleremo più avanti madonna, ora poi avete il vostro bel daffare con la nuova signora di Montefeltro, che mi dite di lei piuttosto?»
«È giovane, ha una mente pronta, eccelse doti culturali e una naturale attitudine al governo.»
«Di questo è consapevole anche Federico, poiché è lei che governa durante le sue assenze.»
«È anche molto pia sapete? È terziaria francescana, ha un cuore generoso, ha allevato i figli naturali di Federico come se fossero suoi.»
«E vi è molto affezionata, tanto che una delle loro figlie porta il vostro nome.»
«Mi hanno fatto questo onore, si.»
Calò il silenzio, fu Costanza a romperlo: «vorrei che faceste qualche ricerca sul monastero e sulla mia famiglia.»
«D’accordo, se questo può servire a farvi stare tranquilla.»
XIII
La monotonia non aveva spazio nella vita di Costanza: c’erano i giovani figli del duca da seguire, la salute di questi, della duchessa e quella di Giorgio: era il più anziano di tutti loro e andava lentamente declinando, lo aveva compreso Federico, che sempre meno di frequente lo convocava agli incontri preliminari di qualche nuova battaglia, lo aveva compreso lui stesso e accettava di buon grado la situazione, non potendo porvi rimedio.
Il vecchio cavaliere trascorreva gran parte delle sue giornate nello studiolo che Costanza aveva fatto approntare nella loro abitazione: era una piccola riproduzione dello studio di Federico, anche qui il soffitto era a cassettoni, sebbene fossero di legno naturale e privi delle imprese, le pareti erano coperte da tarsie lignee, che creavano effetti illusionistici di continuazione dell’architettura; lo schema della decorazione prevedeva nella parte superiore un alternarsi di sportelli semiaperti, che rivelavano armadi con oggetti, mentre la parte inferiore imitava degli appoggi, sulle quali erano disposti strumenti musicali ed altri oggetti.
Gli oggetti ritratti negli armadi alludevano alle Arti, in particolare alla medicina e alla letteratura, le passioni di Costanza.
Da qui, seduto a uno scrittoio vicino all’ampia finestra che affacciava sul verde paesaggio urbinate, l’anziano Ordelaffi intratteneva rapporti epistolari con molte parti d’Italia.
Fu così, che tramite l’ambasciatore di Urbino a Venezia, era venuto in possesso delle notizie che potevano interessare Costanza.
In un freddo pomeriggio di fine dicembre dell’anno del Signore Millequattrocentosettantaquattro, marito e moglie, seduti davanti al camino acceso nel salone della loro dimora, vennero a conoscenza delle notizie riguardo la famiglia di Costanza, il convento e altro ancora.
«Ecco Costanza cosa riferisce il nostro ambasciatore: vostra madre morì pochi anni dopo la vostra fuga e vostro padre si risposò con madonna Lucia Correr, da cui ebbe un figlio, Pietro. Fu lui a ereditare il patrimonio di famiglia alla morte di vostro padre, giacchè anche i vostri fratelli erano morti. Il monastero invece è stato soppresso dal papa nel Millequattrocentotrentotto, ufficialmente per l’aria malsana e le serpi che infestavano l’isola, ma in città si mormorava che la badessa Caterina Michiel fosse caduta in disgrazia in seguito alla fuga di una novizia della quale, nonostante le ricerche, non si seppe più nulla.
L’ambasciatore scrive anche che il padre di questa fece un tale strepito che la badessa fu condannata a reclusione: venne trasferita nel monastero di San Girolamo dove visse fino alla morte sotto stretta sorveglianza e senza mai ricevere visite, se non il proprio confessore.»
«Non vi dice nulla di suor Berta?»
«Lei e alcune altre furono accolte nel monastero di Santa Caterina a Mazzorbo.»
«È il monastero che si trova vicino all’abitazione di colui che fu il vostro barcaiolo di allora, rammentate?»
«Si.»
«Ma è viva?»
«Non ha saputo dirmelo,» vedendo che la moglie non replicava, continuò, «Sant’Ariano pare sia ormai un covo di ladri che si nascondono tra le rovine del monastero, ne hanno profanato anche il cimitero, pensando di trovarvi chissà cosa. Inoltre, nel susseguirsi delle epidemie l’isola è stata usata come cimitero di appestati: i corpi erano stati lasciati a marcire tra i rovi e le rovine, ora ovunque vi sono ossa che brillano al sole, persino l’erba è bianca,»
Costanza taceva guardando le lingue di fiamma che danzavano nel camino, il calore e il movimento ipnotico l’avevano estraniata.
Giorgio si alzò e si allontanò, reputando dovesse riflettere da sola su quelle notizie, solo lei poteva realmente sapere quali fossero i moti del suo cuore e della sua mente, alle notizie ricevute.
XIV
«Ma vi rendete conto dell’atrocità che ha commesso?»
«Costanza calmatevi.»
«Come ha potuto farsi coinvolgere in una simile enormità?»
«Sapete bene come fossero tesi i rapporti tra lui e Lorenzo de Medici da un po’ di anni a questa parte.»
«Ciò non giustifica l’assassinio.»
«Il papa lo ha nominato gonfaloniere della chiesa.»
«Il papa! Un francescano del tutto dimentico del suo voto di umiltà e povertà. Voleva Firenze e ha coinvolto Federico proprio perché a conoscenza del suo malanimo nei confronti del Medici e ora che la congiura è fallita? Cosa pensate che accadrà? Lorenzo non è uomo da dimenticare, gli è stato assassinato il fratello.»
«Nessuno sa del coinvolgimento di Federico.»
«Ma se la lettera che vi ha fatto inviare ai suoi ambasciatori indirizzata al papa fosse stata scoperta?»
«Era in codice Costanza, ho usato il codice che ci fece avere Cicco Simonetta quattro anni fa, nessuno è in grado di decifrarlo, se non io e messer Simonetta stesso.»
Costanza era comunque in apprensione, la vendetta di Lorenzo sarebbe stata tremenda.
I suoi più cupi presentimenti si avverarono, Lorenzo aveva catturato i congiurati, tra questi vi era Giovanni Battista da Montesecco, un soldato al servizio di Girolamo Riario nipote del papa, che dopo il fallimento della congiura si era rifugiato in un monastero benedettino.
Questi, prima di essere messo a morte, rilasciò una piena confessione in cui faceva riferimento anche al coinvolgimento del duca di Urbino che fu resa pubblica successivamente alla sua esecuzione, nel mese di agosto: il nome di Federico non vi compariva, ma nelle ambascerie d’Italia si sapeva che la parte che lo riguardava era stata stralciata per volere dello stesso Lorenzo, in questo modo lo teneva in pugno.
«Andiamo via da qui Giorgio, il rischio è grande,» l’angoscia traspariva dalle parole di Costanza.
«Dove vorreste andare? »
«Andiamo a Forlì, poi da lì ci trasferiremo a Venezia, in laguna potremo vivere tranquilli. »
«E voi è lì che volete concludere la vostra vita è vero? »
«Si…»
«Avete ragione, ognuno dovrebbe poter morire nel luogo dove è nato. Sta bene signora, occupatevi di organizzare la nostra partenza, io nel frattempo manderò un po’ di lettere che preannunciano il nostro arrivo.»
Occorse del tempo, Federico opponeva resistenza, ma questa volta era Costanza a tenergli testa: era la sua città che voleva rivedere e non glielo poteva impedire nemmeno il signore di Urbino.
Infine Federico capitolò e diede loro il permesso di lasciare Urbino: ad aprile, in una primavera funestata già da sinistri presagi, Giorgio e Costanza si misero in viaggio per Forlì.
Vi giunsero stanchi, in particolare Giorgio, sempre più affaticato, era stato colto dalla febbre malarica e nonostante Costanza lo curasse con decotti e infusi di artemisia, non ne traeva alcun giovamento.
A Forlì trovarono alloggio in una abitazione messa a disposizione dall’ambasciatore urbinate: per i signori di Forlì, suoi parenti, lui era nessuno.
La loro nuova abitazione faceva parte di un complesso edilizio di recente costruzione lungo la via maestra, le case della famiglia Orsi: abitazioni e botteghe tutte in relazione tra loro, con un ampio cortile porticato, su cui aggettavano le abitazioni nobiliari
Costanza si risolse ad attendere che le sue condizioni migliorassero per poter riprendere il viaggio: lo curava personalmente, non si staccava mai dal suo capezzale, dormiva seduta su una poltrona vicino alla sponda del letto, ogni giorno lo detergeva e gli somministrava i medicamenti. Gli preparava infusi di ortica e rosa canina per arginare il sangue che perdeva dalle vie respiratorie, decotto di mela per farlo riposare, gli poggiava pezze imbevute di decotto di fiordaliso sugli occhi.
In preda alla disperazione era giunta a procurargli un salasso, nonostante fosse contraria a tale pratica che debilitava ancora di più l’infermo, ma la situazione non migliorava.
Fu la mattina del tredici maggio che peggiorò drammaticamente: appena svegliatasi Costanza aveva potuto constatare che il suo respiro si era fatto affannoso e aveva perso lucidità.
Comprese che ormai era giunta la fine: con calma ammirevole lo lavò, cambiò le lenzuola, spalancò le finestre per far entrare aria pulita e luce e si dispose seduta al suo fianco, a attendere.
Era da poco trascorsa l’ora sesta, quando il sole si oscurò per una eclissi, gli uccelli tacquero repentinamente, un silenzio inusuale si propagò per la città, fino ad allora operosa.
«Costanza,» Giorgio Ordelaffi aprì gli occhi, in un ultimo sprazzo di lucidità le strinse la mano con il poco vigore che ancora gli rimaneva e spirò, gli occhi infine chiusi, una espressione di serenità sul viso.
Costanza rimase immobile, la sua mano in quella del marito, lentamente la spostò, lo compose e gli depose un bacio sulle labbra ormai esangui.
Lo guardò ancora una volta con dolcezza, poi uscì per andare a dare disposizioni per il funerale.
Il sole stava lentamente riapparendo, un raggio si fece strada tra i vetri spalancati della grande bifora, sino a illuminare il letto, scaldando per l’ultima volta il corpo del cavaliere.
Fu lei sola a accompagnarlo alla sua ultima dimora: avvolto in un sudario candido, chiuso in una semplice bara senza orpelli, su cui aveva fatto incidere il nome, la data della morte e più in basso anche il suo, di nome, lo fece seppellire nel camposanto vicino al duomo, in un caldo mattino di maggio, in cui l’aria profumava di fiori.
XV
Aveva abbandonato la città poco tempo dopo, con un messo ne aveva inviato notizia a Federico, informandolo anche della sua intenzione di proseguire per Venezia. Non aveva atteso risposta.
Il viaggio era stato lungo e disagevole, al caldo opprimente dell’estate padana ormai prossima, si aggiungevano gli strascichi dell’epidemia che ancora imperversava in diverse zone della pianura, per cui doveva fare deviazioni continue per non rischiare la quarantena.
La lettera firmata dall’ambasciatore urbinate a Venezia le fu in questa situazione di grande aiuto.
Era luglio, quando, dalla terraferma in barca si avviò lungo il canal salso prima, la laguna aperta e infine il Canal Grande per giungere a destinazione, in una piccola abitazione messa a sua disposizione in quel di Cannaregio, non troppo lontano dalla Ca’ d’Oro.
Si trattava di una abitazione di testa, con grandi bifore, nella stretta calle del Pistor, parte del lungo percorso commerciale che attraversava Cannaregio parallelamente al Canal Grande.
Era una dimora con un sotoportego, una curia con il proprio pozzo, la cucina al piano terra, vicino alla scala che portava al piano superiore dove erano altre tre stanze, una delle quali Costanza fece adibire a studiolo, avendo portato con sé i libri che aveva raccolto in quegli anni, i documenti del marito; da Urbino poi, aveva fatto giungere le tarsie che ornavano le pareti dello studio della loro casa, lo scrittoio e la poltrona di suo marito: le sembrava ora di aver allestito nuovamente quella piccola stanza che tanta soddisfazione aveva dato a Giorgio Ordelaffi.
Aveva compiuto a ritroso lo stesso percorso di molti anni prima. Non aveva usato il suo nome e tantomeno era intenzionata a presentarsi a quel fratello tanto più giovane di lei che sicuramente non era nemmeno al corrente di chi fosse.
Aveva conservato i gioielli trafugati in allora, non per desiderio di farsi riconoscere, ma per timore che se li avesse venduti a suo tempo, avrebbero potuto risalire a lei.
Non sentiva il desiderio di far parte di una famiglia che l’aveva rifiutata anni prima, i Contarini non le dovevano nulla e lei non doveva nulla a loro: era una donna facoltosa senza problemi per vivere decorosamente, inoltre, pur avendo vissuto in una corte brillante come quella di Urbino, non sentiva la necessità del lusso, era sufficiente la comodità.
E l’alloggio scelto per lei lo era, comodo e soprattutto discreto, con un proprio ingresso indipendente, in una zona ricca di botteghe, dove nessuno faceva caso a un viso nuovo.
Quando finalmente si fu sistemata, decise di farsi accompagnare fino al monastero di Santa Caterina in Valleverde, a Mazzorbo.
Non aveva più varcato la soglia di un convento dalla notte della sua fuga, le tremavano le gambe, aveva un irrazionale timore di essere scoperta.
Chiese di suor Berta e grande fu la sua gioia nel sapere che era ancora in vita, godeva di buona salute e continuava la sua professione di erborista: la suora portinaia le fece strada verso la farmacia, come pomposamente chiamava il locale dove Berta preparava i suoi medicamenti.
Entrò in un locale ampio e ombroso, odorava di erbe secche di colpo le sembrò di essere catapultata indietro nel tempo, in un luogo simile a quello.
«Suor Berta…»
La monaca si girò di scatto, Costanza si avvide di come il suo viso fosse uguale ad allora, fatte salve qualche ruga in più.
«Costanza, sei davvero tu?»
«Mi avete riconosciuta.»
«E come potrei aver dimenticato la tua voce e anche se fosse, i tuoi occhi parlano per te.»
«Ho pensato a voi molte volte, ho sempre temuto delle ritorsioni nei vostri confronti, soprattutto a causa di quella serpe di Marchesina Foscari, ma come avevo potuto credere fosse mia amica? L’avevo mal giudicata, anzi troppo ben giudicata.»
«Ci fu un tentativo da parte della badessa, probabilmente su istigazione di quella stessa conversa, ma non ottenne nulla. Lo stesso vescovo dopo aver sentito la mia versione, ritenne che non fosse il caso di procedere oltre e rivolse le sue attenzioni sulla badessa e sul suo modo di gestire l’andamento del convento. Per sicurezza comunque chiesi di venire qui, adducendo come scusa il clima ormai malarico dell’isola, il resto…»
«Lo conosco, sono stata informata in questi anni, solo non ero mai riuscita ad avere vostre notizie.»
«Era importante per te?»
«Si, molto, voi eravate tutta la mia famiglia.»
Suor Berta la strinse a sé Costanza riconobbe l’odore pungente delle erbe che da sempre aveva accompagnato il ricordo che aveva della monaca.
«Raccontami di te ora.»
«È una storia lunga.»
«Abbiamo tempo.»
Costanza uscì dal convento che il giorno volgeva al termine, la barca la attendeva lungo il canale di Mazzorbo per riportarla a Venezia.
Iniziò dunque la sua vita nella sua città, da donna libera, ma con grande riservatezza e discrezione.
Abituata al fermento artistico della corte di Urbino, Costanza fu piacevolmente sorpresa dal movimento culturale cittadino. Sempre con molta prudenza, iniziò a frequentare le botteghe d’arte, in particolare quella di Giovanni Bellini, in cui la donna rivide l’influenza di Piero della Francesca da lei conosciuto a Urbino, anche se con uno stile più affine ai gusti veneziani e con suo sommo stupore, ai suoi.
Tornò ancora a trovare suor Berta, sino a quando una mattina di dicembre, la portinaia la condusse dalla badessa invece che alla farmacia, Costanza comprese immediatamente.
«Reverenda madre.»
«Madonna Ordelaffi, mi duole informarla che suor Berta questa notte ha reso l’anima a Dio,» vedendo il dolore dispiegarsi sul suo volto, proseguì rapidamente, «è morta in grazia del Signore e prima di spirare mi ha chiesto di consegnarvi questo pacco. Desidero dirvi una cosa, era malata da tempo, ma resisteva pervicacemente all’avanzare del male, sembrava attendere la venuta di qualcuno. Poi, quando voi siete apparsa, in principio è sembrato che si riprendesse, infine ha ceduto.»
Costanza non fece alcun commento, si limitò a prendere il pacco che la badessa le stava porgendo.
«Credo, se ho ben inteso la situazione, che forse vi farà piacere ritirarvi ad aprirlo nella farmacia, che è stata il suo regno.»
Incapace di profferire parola Costanza si limitò a un cenno affermativo e seguì la badessa nella farmacia.
«Ecco, prendetevi tutto il tempo che vi occorre.»
Quando la porta si chiuse dietro la monaca, Costanza aprì il pacco avvolto in tela bianca: fasciati nella stoffa trovò i quaterni di suor Berta, il Libro di Isacco Giudeo, una serie di pacchetti di stoffa più fine e ampolle ben chiuse, una chiave e infine una lettera.
Con gli occhi velati dalle lacrime ruppe il sigillo e si apprestò a leggere le ultime parole della monaca.
“Mia cara Costanza, se leggi queste parole vuol dire che io ormai sono nel Regno di Dio. Non essere triste, da qui potrò guidarti ancora, come feci per tutto il tempo che trascorremmo insieme a Sant’Ariano. Tutto ciò che trovi nel pacco è ciò che rimane del nostro convento.
Conservalo a futura memoria, perché nessuna donna sia più obbligata a scegliere il chiostro dal volere di altri o per la propria sopravvivenza, ma solo perché è il suo cuore che lo desidera.
Ti abbraccio con tutto il mio amore.
Tua sorella in Cristo,
Berta Grimani”
Solo in quel momento realizzò che non aveva mai saputo a quale famiglia appartenesse la monaca.
EPILOGO
La luce del sole lentamente rischiarava le acque della laguna, rendendo visibili i contorni di isole e barene, non troppo lontano si intuiva la sottile linea della terraferma.
Lasciò vagare lo sguardo, intorno a sé lugubri resti umani spiccavano sulla vegetazione di un innaturale colore biancastro: Sant’Ariano era ormai solo un cimitero, un sepolcro senza soluzione di continuità, che lentamente stava affondando, ricoperto dalle acque sempre più alte.
Era il luogo in cui la laguna, lontana dalla città di meravigliosi palazzi che si specchiavano nei canali, tornava a essere se stessa, piena di spiriti: non vi era isola, barena o canale in cui non aleggiasse qualche anima.
Era un luogo spoglio, privo di argini: se esisteva l’Ade, pensava Costanza, questo lembo di terra ormai prossimo a scomparire, ne sarebbe potuto essere il giusto ingresso.
Venezia sembrava lontana, immensa e lontana, oltre i canneti, alle spalle di Costanza era un ginepraio di spine e cespugli, veri custodi dell’isola di anime perse.
Costanza infine si alzò, percorse a ritroso il sentiero che l’aveva condotta sin lì, sotto i suoi piedi conchiglie calcinate producevano un lugubre suono, come se la terra sommessamente esprimesse tutto il proprio dolore.
La barca era attraccata e il barcaiolo rannicchiato all’interno a proteggersi dal freddo notturno.
Si avvicinò al punto in cui sapeva esserci l’imbocco del cunicolo che quarantasei anni prima l’aveva condotta verso la libertà: era invaso dalla vegetazione e dall’acqua.
Salì sul pontile, tra le mani era comparsa una vecchia chiave arrugginita, la lasciò scivolare nell’acqua.
Il lieve tonfo, amplificato dal silenzio del primo mattino, svegliò il barcaiolo.
Costanza salì a bordo, «andiamo, voga verso San Francesco del deserto.»
Il barcaiolo ubbidì e lentamente si portò verso il punto della laguna che lei gli aveva indicato.
Improvvisamente il silenzio della laguna fu riempito dal suono argentino della campana di San Francesco del deserto.
Si poteva udire il frusciare dei piccoli animali oltre la cortina dei cipressi che difendeva l’isola.
In alto, il richiamo roco dei gabbiani in volo.
Con gli occhi dell’immaginazione poteva vedere le distese di barene ricoperte di limonio e salicornia, che d’estate le coloravano di viola, oltre le sembrava di scorgere i profili di antichi edifici, quei chiostri tra le acque che lentamente stavano affondando, laddove la natura si stava riprendendo ciò che l’uomo aveva tentato di far proprio, inutilmente.
Costanza si sentiva avvolta nella natura, accompagnata verso l’oblio, come dal canto delle sirene.
«Torniamo a Venezia.»
NOTE
Alcuni personaggi sono realmente esistiti.
Marino Contarini fu realmente l’ideatore e progettista della Ca’ d’Oro, anche se la sua costruzione e ultimazione è posteriore agli anni in cui è ambientato l’inizio della storia, i nomi dei suoi figli e della moglie gli appartengono, solo a una delle due figlie è stato modificato il nome, da Samaritana a Costanza, l’interprete del racconto.
Il coinvolgimento di Federico da Montefeltro nella congiura dei Pazzi è stato accertato dal prof. Marcello Simonetta, discendete di quel Cicco Simonetta, segretario alla corte sforzesca, ideatore del codice segreto utilizzato da Federico.
È vero altresì che il Magnifico ordinò lo stralcio dalla deposizione di Giovanni Battista da Montesecco delle accuse riguardanti il duca di Urbino.


