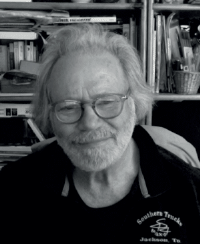
Alpinista e Skipper ha girato il mondo.
Da qualche anno scrive poesie e racconti che hanno ottenuto riconoscimento in importanti concorsi letterari.

APOPTOSI
Suona come musica fatata
la morte cellulare programmata
Indica la fine delle voglie
come dagli alberi cadono le foglie
E intanto spariscono i dolori
così cadono i petali dei fiori
Non è necrosi e neppure svista
è detta anche “morte altruista”
quella che consente la vita
è la nostra “morte pulita”
A contarle puoi fare tardi
ogni giorno sono miliardi
le cellule che sono andate
ed altre eccole rinnovate
A voi forse non sembra vero
ma in un anno è il corpo intero
Così allo specchio mi chiedo
chi è quello che io vedo
che ora indica col dito
il vecchio o il giovane ricostruito
che quasi finge di non sapere
al di là del principio del piacere
perché teme ancora parole storte
quando si dice istinto di morte
Non c’è nulla di triste nel contrasto
di funereo, odioso o nefasto
perché quando la vita scoppia
sempre bianco e nero vanno in coppia
Chiara l’evidenza conduce:
solo nel buio risplende la luce
e forse non ho del tutto torto
se mi credo anch’io più volte morto
e risorto
Emerge allora una riflessione ardita
che cancella il dubbio della sorte
la legge inusitata della vita
è la certezza programmata della morte
Processo inarrestabile e cadenzato
che continuamente conduce ad altro stato
di cui forse conserveremo memoria
Metempsicosi forse...
ma questa è un’altra storia.
In principio fu l’urlo
sottile alterno audace
come un disturbo
Poi rotta ormai la pace
e alzato il limite dell’asta
contro ogni argomento contenuto
ecco la voce che sovrasta
e brucia
l’equilibrio ormai perduto
Quindi viene l’insulto
roboante sfacciato divertito
senza amnistia o indulto
come s’infila nell’occhio il dito
Infine delle anatre il coro
altisonanti grida di oche
guerrieri fieri senza decoro
e con idee rimaste poche
Aspettando che scorra il sangue
l’attenzione certo rimane fissa
Il ragionamento un poco langue
ma fa più spettacolo la rissa
Poi tutti sorridono al conduttore
come un teatro che finge la realtà
Fine della guerra con l’interruttore
ecco lo spazio padrone: pubblicità
Quasi svenuto
mi chiedo dove è avvenuto
e come e quando
Schiaccio triste il telecomando
apro una birra dal frigo
di risposta ne trovo una sola
e cerco in un libro
la vecchia parola.
Nel mare nero
si perde
anche l’uomo più sincero
Quasi di scatto
copre gli occhi con la mano
Lo sguardo distratto
cerca ancora più lontano
La ragione s’inceppa
su quella barca infame
dalla stiva piena zeppa
che rivela perfide trame
Quel tappo che chiude lo sbarco
e affoga donne e bambini
come nelle fiabe l’orrido orco
trasforma i distratti in assassini
Ognuno diventa nefando
se distoglie la vista dal male
Quel tocco di telecomando
che cambia veloce canale
Almeno lo dica sicuro
urlando feroce alle genti
l’idea efficace del muro
è finirla con quei pezzenti
Io vedo il corpo che trema
il pianto del sopravvissuto
E sento nel cuore la pena
per quel che ho e lui non ha avuto
Qualcuno lo dice destino
altri la chiamano sorte
è solo un compagno vicino
che abbiamo condannato alla morte
Dirà più d’uno convinto
“Ma io non ho fatto niente!”
Con questo il verdetto è dipinto
di chi è morto innocente.
L’ EQUILIBRISTA
In alto
ben sopra l’affollata pista
non di solido basalto la pedana
e quasi fuori dalla vista
ondeggia la figura lontana
sul filo sottile
ecco l’equilibrista
Il cuore non vile conquista
la gravità spietata oltraggia
Appeso alla magica asta
d’equilibrio prolungata lancia
l’aria attorno frusta
all’effimero solido s’aggancia.
Dall’una e dall’atra parte
senza possibile remissione
incombe irrimediabile la sorte
alla minima distrazione
Balla minaccioso il filo
di salvezza unico sostegno
rischia ai lati il tragico volo
Il piede avanza con impegno
Il vento fischia improvviso
esplode della folla il boato
La piroetta poi torna il sorriso
di nuovo procede, eccolo salvato
Quel cavo ci tiene tutti
metafora del quotidiano travaglio
Speriamo del futuro i frutti
poi basta un accidenti o uno sbaglio
Così nell’oceano della vita
fragili sull’onda in barca
come equilibristi in gita
inganniamo il taglio della Parca
Perciò il saltimbanco Cagliostro
che la morte sfida con l’asta
è un fratello, è l’eroe nostro
anche per un attimo, ma questo ci basta.

BORA CHIARA IN LAGUNA
Come un delfino
la barca
insegue l’onda
e il nocchiero lieto
l’asseconda
Niente divieto
su quel muro molle
si sale e scende
come sopra un colle
Musicale la tela
tesse il motore
poco rumore
imita una vela
L’aria investe
come mare aperto
antenne deste
di capitano esperto
Dall’alto del balcone
inebria l’orizzonte
morbido il timone
azzanna onde pronte
a imitar le curve
di nuvole imbiancate
Scivola e si perde
tra spume rinfrancate
ardita la prora
Apre la ferita
Spruzza il volto la bora
ancora incollerita
Battezza il tuffo
con urlo e schianto
accompagna lo schiaffo
del salato canto
Solo in tanta natura
non chiedi la ragione
Fine d’ogni paura
resta solo la passione
Rubare al nero le ore
seppur con penitenza
come bimbo esploratore
che cerca conoscenza.
TRAMONTO LAGUNARE
Lentamente si sfila
il lenzuolo di luce
macchiato di sangue
nel fondo che langue
Il tenero azzurro sfiora
la macchia di rosa
Controluce di neri profili
svettano ritti campanili
L’ombra la luce soverchia
Nel giorno che si perde
qualcuno ricerca
il raggio verde
Un attimo ed ecco
che tutto inghiotte
il buio
dell’avida notte
Scintilla una stella
e un’altra lì intorno
Annunciano timide
la fine del giorno
Resiste a ponente
l’ultimo fuoco perdente
Lì dove il sole ormai tace
ancora brucia la brace
Io guardo immobile silente
Orrore e fascino del niente
Sentimento del confine
Struggente bellezza della fine.
Notte delle stelle
cadenti tra le più belle
preda dei tanti desideri
imperanti
Silenti misteri
problemi seri
invadono le menti
e diventano divertenti
se lasci il pensiero truce
Abbandonati alla luce
che abbaglia improvvisa
come lampo senza rumore
Ingoia intatto lo stupore
per un attimo vicino
Come quando bambino
dal cielo sbalordito
precipitavi
nell’universo infinito.
SPIAGGIA INVERNALE
Lungo la spiaggia
grigia di nebbia
del mare ferme le onde
il cielo e l’orizzonte
Il nulla confonde
Limite ritrovato
e ora perduto
si mescola il presente
con l’accaduto
Si fa più saggio
l’incedere del viaggio
quasi liberato dal freno
che la ragione contiene
Assenza del vento
Il tempo non viene
Il senso che premo
si tiene da solo
Nessun disegno
Si apre il mio volo
Fantasmi di un sogno
che dice in silenzio
verità negate
Esplose inaspettate
tra monumenti vecchi
Giochi di specchi frantumati
ritratti mai finiti
sfuggiti senza onore
Sordi ricordi di dolore
tentano di parlare
Poi un raggio di sole
e torna la voglia di amare.
Il corvo
in alto
alle antenne aggrappato
quasi a perdere le penne
gracchia ostinato
E pare
in questi egoismi arcani
inseguire le astuzie amare
degli umani
Neofiti al comando
sputano sentenze
felici snobbando
le umili penitenze
La nuova sorte
toccheranno presto con mano
Pericolo di morte
Arriva il gigante gabbiano.

Il termine latino aquatio, acquazzone origina l’etimologia. Guazzetto deriva da “guazzo” che significa umido (Molti avranno sentito dire la “guazza” per indicare quel bagnato che si trova al mattino sull’erba d’estate, nei giorni sereni).
Il guazzetto è un sugo, una salsa molto fluida in cui si fanno cuocere pesce o carne. Molto diffuso nelle località di mare è il guazzetto di cozze e vongole o quello di “mare” che si prepara con pesce fresco, pomodoro, olio e vino. Esiste anche quello di carne, ben ricordato dal celebre Artusi nel libro “L’arte di mangiar bene e la scienza in cucina”. Il “Vitello in guazzetto”, che nella ricetta originale è cotto in un saporito intingolo a base di latte e delicatamente aromatizzato dallo speck. Secondo l’autorevole cuoco, doveva essere cotto in una pentola sigillata con carta oleata e spago (ora si fa in pentola a pressione).
Una vera leccornia. Una specialità. Una costosa rarità nella Venezia del 1500 già segnata dalla peste, in cui la carne era prevalentemente cacciagione di laguna, cotta allo spiedo e farcita di odori. Piccoli uccelli che venivano infilati in spiedini, alternati con pezzi di maiale, di pancetta o di lardo, accompagnati da tenera polenta (prima quella antica di fave macinate e farro, poi con il mais importato dall’America che venne coltivato su larga scala nel Veneto). “Anatra ripiena” o “petto d’anatra in agrodolce” sono piatti che ricorrono nei menu dei ricchi mercanti e nobili. Così rari e importanti che il doge ogni anno per antica tradizione, a dicembre, donava ai nobili del Maggior consiglio cinque anatre selvatiche. Quando a causa delle guerre, nel 1521, non fu possibile cacciare, furono sostituite con una moneta d’argento, la “osella” (da oselo veneto, uccello) una medaglia di quasi dieci grammi d’argento del valore di “grossi” dodici o “soldi” trentadue. Insomma la carne valeva molto e, come nella lunga tradizione medievale, era un piatto che non si poteva certo definire popolare.
Al popolo era riservata un’altra tipologia di carne. A volte quella bovina, gestita dalla scuola dei “Becheri”, istituita già dalla fine del 1200, con la chiesa di San Mattia a Rialto e il patrono San Michele Arcangelo. Oltre alla macellazione e vendita delle carni, avevano anche in carico la gestione delle spettacolari corride di carnevale in campo San Polo.
Ancor più popolare era la scuola dei “Luganegheri”, i salumai cui era riservata la “macellazione, confezionamento e vendita di carni suine e la vendita di minuzzami di provenienza bovina”. Troviamo traccia di quest’Arte che radunava salsicciai, lardaioli, pizzicagnoli e venditori di minestre, nell’atto di fondazione originale conservato al Museo Correr, il 26 Ottobre 1497, in cui si parla di salumi e zuppe o “squazeti”. Potevano iscriversi all’Arte sia i veneziani che i sudditi, bastando che avessero avuto dimora a Venezia per 15 anni e bottega propria.
L’istituzione più tarda di questa scuola riordinava una consuetudine molto diffusa nelle locande della città, quella della minestra che riutilizzava il minuzzame della lavorazione delle carni, consentendone la fruizione anche agli strati sociali meno abbienti e non in grado di comprare il taglio migliore riservato ai nobili. Il “guazeto” appunto, la carne in umido diremmo oggi, che sempre fumava nel pentolone delle botteghe, pronta per essere scodellata in ogni momento agli avventori, per lo più lavoratori desiderosi di un energetico pasto caldo. I sapori non erano quelli a cui oggi siamo abituati. La carne non veniva conservata con la catena del freddo e spesso emanava profumi poco invitanti. Ma a Venezia c’erano le spezie, cardamomo, zenzero, cannella, noce moscata e benché anch’esse riservate alle classi egemoni, attraverso il piccolo commercio dei marinai, arrivavano anche alla cucina popolare. L’utilizzo secondo le caratteristiche orientali divenne quasi esagerato. Tra le ricette di un anonimo cuoco veneziano del ‘300 giunte a noi, c’è un “pollo allo zenzero” in cui la quantità di spezie è di ben 750 grammi.
Era proprio questo che Tonio cercava. Un “guazeto” dolce, senza tutti quegli strani, piccanti e persistenti odori che coprivano il piacere raro della carne. C’era solo una bottega dove si poteva trovare una simile leccornia. Ne parlava da tempo ormai tutta la città. Si trovava in campo San Zan Degolà (San Giovanni decollato) lungo il Canal Grande, nella taverna di Biagio Cargnio, il friulano. Intorno agli anni venti del Cinquecento, la bottega era divenuta famosa tra il popolo e perfino tra i patrizi che si spingevano ad esplorare quel piccolo locale, lungo e stretto, con pochi tavoli, buio, quasi sordido pur di assaggiare il piatto speciale con cui quell’omone della Carnia era riuscito a conquistare gran parte degli operai dei cantieri lì vicino. Uno squazeto senza rivali, morbido al palato, dolce, perfino inebriante, in cui la carne finemente spezzettata profumava di fresco, quasi di latte. Sì, così ricordava Tonio, lo aveva confermato anche il suo amico marinaio, il “genovese” che in realtà veniva dall’isola grande, dalla Sardegna e nel suo pittoresco dialetto, dopo aver assaggiato la minestra, “U Purceddu!” esclamò, spiegando che di sicuro era un porcellino da latte, che nella loro tradizione si cuoceva allo spiedo. Ma la carne era la stessa, non si poteva sbagliare, c’era un sapore speciale, un aroma che assume solo la carne quando è giovane, ancora in formazione. Avevano bevuto di gusto quel giorno, forse troppo e fecero poi fatica a lavorare in cantiere.
Tonio aveva chiesto più volte al cuoco, che gigante si sporgeva dalla finestra fumante della cucina in fondo al locale, se davvero era il purceddu, il porcellino da latte, il segreto di quella sorprendente ricetta. Biagio aveva risposto ridendo che era il suo segreto, che non poteva rivelare perché si sarebbe rovinato con le sue mani, non vedeva Tonio come andavano bene gli affari? Se qualcun altro avesse riprodotto il suo squazeto sarebbe finita la coda che ogni giorno si litigava i pochi posti del locale. “Accontentati di mangiare questa specialità a poco prezzo!” Aveva concluso il “luganegher” della Carnia.
In effetti, aveva riflettuto Tonio, si pagava davvero poco per un piatto che era decisamente migliore di tutti gli altri della città. Con più carne, fresca, senza quell’abbondanza di spezie che poi ti strizzavano le budella per tutto il giorno. Aveva convinto perfino la moglie, Marietta, a venire con lui un giorno alla taverna. Lei era brava in cucina. Aveva lavorato come aiutante dal Conte Zorzi nella cui cucina non mancava nulla. Sperava che riuscisse a scoprire come riprodurre quella zuppa che avrebbe voluto ritrovare anche a casa, senza dover sempre combattere con la ressa per conquistare il posto e gli schiamazzi di chi aspettava il suo turno e sollecitava gli altri a far presto ad andare via.
Non era contenta Marietta di intrufolarsi in mezzo a tutti quegli operai giovani che la guardavano con curiosità e misuravano, sorridendo tra loro, tutte le sue belle curve. Una follia di suo marito aveva pensato, una delle tante stranezze che una buona moglie deve sopportare per la convivenza. Quando finalmente furono seduti davanti alle scodelle fumanti portate dalle mani possenti del cuoco, fu anch’essa conquistata dall’aroma speciale. E dal sapore davvero pulito della carne. Non seppe però, nonostante si concentrasse nei ricordi della grande cucina nobiliare, identificare l’origine di tanta piacevolezza. “Vitello” azzardò a Tonio, rivedendo quella carne rosa che una volta il cuoco del conte stava preparando e le aveva spiegato “Gli son rimasti pochi denti, questa è più tenera” e le aveva pure fatto assaggiare un pezzo di quel lembo che aveva conservato, anche cotto, un colore più chiaro e dolce. Ma si trattava di specialità con un prezzo così elevato che solo il nobiluomo poteva permettersi. Non era certo carne che si potesse rivendere cotta al prezzo popolare di quella bottega. Un paradosso che la lasciò un po’ a disagio, anche se il giorno dopo con Lindaura, la sua vicina, si era vantata di essere stata a mangiare lo squazeto più famoso di Venezia. E gli occhi invidiosi dell’amica l’avevano ripagata di tutta la faticosa coda che aveva affrontato col marito.
Tonio finalmente aveva conquistato il posto migliore. Vicino alla finestra della cucina. Poteva vedere le pentole fumanti e seguire fin dall’origine il percorso del suo intingolo preferito. Ecco che veniva raccolto col mestolo dal possente cuoco che lo versava una, due volte nella capiente scodella di terracotta. “Vieni a prenderla qua – chiamò Biagio – che mi risparmi la strada”. Poi, mentre porgeva la scodella poggiandola sul davanzale di legno, aggiunse: “La polenta non è ancora pronta, sei venuto presto oggi. Lì dietro, nella madia c’è del pane secco.. è quasi meglio per raccogliere il sugo!” E per tacitare ogni protesta allungò a Tonio una caraffa di vino. Era vero, quella mattina Tonio era arrivato presto. Non aveva voglia di combattimenti con gli altri operai, nelle lunghe fila d’attesa. S’era sbrigato prima con la sua parte di lavoro e aveva da recapitare un messaggio a un fabbro lì vicino. Una buona scusa per scappare in fretta, e arrivare quasi primo alla pausa pranzo. Finalmente avrebbe potuto gustare in pace e soprattutto cercare di scoprire ancora una volta il segreto di tanta bontà.
Dopo aver recuperato dei pezzi di pane secco, perché davvero quel sugo andava onorato lentamente, impregnato in un delicato aiutante, non sfacciato come il cucchiaio che costringeva a inghiottire in fretta, si sedette tenendo in prospettiva la finestrella della cucina. Gli pareva di avere un’occasione favorevole. Almeno due pentole fumanti restavano alla sua vista, anche se talvolta coperte dal corpulento cuoco che alzava alternativamente i coperchi e mescolava. Anzi, di tanto in tanto, Biagio si fermava. Sembrava indagare nel liquido fumante e poi con uno strano mestolo, più simile a una lunga grossa tenaglia, lavorava sul fondo della zuppa. Certe volte sbatteva forte e pareva che fosse un lavoro faticoso, ma certo non poteva spaventare quell’uomo della Carnia che conservava la struttura fisica dei montanari. Qualche volta a Tonio sembrò anche che pescasse qualcosa per poi buttarla via, ma non riusciva a vedere dove. Sì. Davvero quella era la posizione migliore e Tonio cominciava a cogliere qualche dettaglio. Intanto la dimensione della carne. Era una specialità che molti avevano notato. Piccoli pezzi, per la maggiore parte disossati che quasi si sfibravano nella densità del sugo.
Ecco, già un piccolo segreto l’aveva rubato. Quello strano strumento serviva a ridurre in poltiglia, a togliere anche la più piccola asperità per consentire la miglior degustazione. Gli parve quasi di essere indegno di quella delizia, nel suo sconveniente spionaggio. Oggi poi è migliore del solito, pensò, mentre spezzettava il pane duro, facendolo affondare nella lava fumante della scodella. Che bontà, rimarcò, dopo aver assaporato i primi fumanti bocconi. Ripulì il palato con abbondanti sorsi di vino e si rituffò nell’impresa, pescando in fondo alla tazza i bocconi di pane che aveva affondato. Un istante dopo un urlo silenzioso, un lampo imperioso e sorprendente di luce attraversò la sua testa, seguito dal dolore acuto dell’impatto tra i denti e la gengiva, lì dove la mucosa ricorda di essere tenera e facilmente feribile.
La crosta del pane – pensò all’istante – quella scorza annerita non si era sufficientemente ammollita e ora gli aveva lacerato il palato ingordo, causandogli quella fitta acuta. Le dita corsero naturalmente a prelevare l’intruso, per liberare la bocca e dare una giusta punizione a quel fastidioso inconveniente. Lo catturò facilmente, cogliendo subito una strana sensazione. Lo portò davanti agli occhi per vedere meglio, nella fiammeggiante luce della candela che rischiarava il profondo budello, illuminato solo dalla luce della porta centrale.
Ci volle un po’ per capire, perché noi umani vediamo subito solo ciò che ci aspettiamo di vedere e quello che vide Tonio, non se lo sarebbe mai aspettato.
Un dito. Anzi, un ditino. Falangina e falangetta, inconfondibilmente dotata di unghia appuntita, che era stata la causa della sua ferita. Il ditino di un bambino.
Chiunque possieda un adeguato sistema funzionale, sa che l’emozione agisce sul sistema simpatico, causando quegli effetti che a volte (specie nei più sensibili) possono portare allo svenimento. Accelerazione dei battiti, pallore, sudorazione imponente, acufeni, testa gironzolante e, soprattutto, un senso di nausea incipiente che faticava a controllare. Non ci voleva credere e osservò più volte quel reperto. Però Tonio era anche un giovane forte, temprato dalla povera origine a sopravvivere anche nelle situazioni più dure. Aveva pure una mente sveglia e reattiva. Intanto bisogna sopravvivere, poi vedremo il da farsi. Deglutì a fatica l’imponente saliva che gli si era formata. Chiuse rapido nella mano il reperto e lo riversò nel povero panno che sempre teneva in tasca per pulire le mani dalla calce. Riuscì perfino a bere ancora del vino che gli fece bene, riportando un po’ di colore su quel volto che un istante prima pareva infarinato e ceruleo. Lasciò le monete sul davanzale della finestra della cucina, urlando alle spalle del gigante un incomprensibile saluto. Scappò poi fuori, facendosi largo tra i lazzi e le voci urlanti degli operai che si contendevano i posti migliori. Non fece parola con nessuno. Non voleva neppure ripensare a quello che aveva visto. Lo avrebbe immaginato galleggiare nel suo stomaco che ancora brontolava. E fu proprio lì fuori, mentre cercava disperatamente aria, appena raggiunta la riva di un piccolo canale laterale, che vomitò tutto il suo guazeto preferito. Dalla finestra di un palazzo, qualcuno commentò “S’ubriacano anche di giorno ‘sti operai, che mondo!”
Il comandante della guardia Martino Valier, si alzò a fatica dalla poltroncina su cui aveva tentato il riposino dopo pranzo. Certo non avrebbe dovuto stare seduto lì, era la sedia riservata agli ospiti illustri, ai nobili delle quarentie che a volte venivano a esplorare la postazione. Ma era così comoda, vicino al caminetto, con quel tepore che nella penombra, creata dalla spessa tenda, favoriva il dolce scivolo tra le braccia di Morfeo. E poi a quell’ora anche i briganti si sedevano a tavola, siamo tutti umani, in fondo. Lo strepito che proveniva dall’ingresso non poteva, però, lasciarlo indifferente. Tanto ben presto, lo sapeva, avrebbero bussato alla sua porta. Le guardie fanno sempre così, quasi per vendetta. Se c’è un problema si guardano bene dal risolverlo. E che devono lavorare solo loro, mentre il capo mangia, beve e dorme? Se la sbrighi lui. Nessuna iniziativa. Meglio essere pronti, pensò Martino, anzi era una buona occasione per far vedere che, contrariamente a quel che si pensava, lui vegliava sempre.
“Che cos’è tutto questo fracasso?!” Urlò, spalancando l’uscio e andando incontro alla guardia che si avvicinava lungo il corridoio, cercando di tacitare un giovane che continuava a ripetere “Il comandante… posso dirlo solo al comandante.. non è cosa per voi!”
“Ho tentato capo, ma questo non ne vuol sapere di seguire la prassi… Solo al comandante, avete sentito, dice di un orribile caso… un delitto che può raccontare solo a voi, che noi non gli avremmo creduto. E dunque…” “Sì, Sì, Ho capito… E dunque vedetevela voi.. Bravo Tiziano, come al solito.. lascia stare.. fallo entrare ci parlo io… e intanto – aggiunse per pura vendetta – lascia Piero alla porta e tu vai a fare un giro d’ispezione fuori… non si sa mai che sia l’inizio di un subbuglio.” “Ma….” “Niente ma, vai e poi riferisci” Il comandante chiuse la porta, lasciando Tiziano incapace di replicare e fu allora che vide il volto sconvolto di Tonio.
Si era aspettato di dover affrontare la solita seccatura. Un furtarello o una truffa subita ai dadi o al gioco delle tre carte. Magari la consueta filippica sull’agguato di un possibile sicario, ingaggiato dalla moglie infedele o la tradizionale feroce lite con il vicino maleducato. Ma il volto che gli stava davanti muto, urlava con chiarezza di aver assistito a qualcosa di terribile. Era così evidente che Martino disse al giovane di sedersi, proprio sulla sua amata poltroncina e chiese anche se voleva bere dell’acqua. Tonio accettò e schiarita la gola con cui nell’ultima ora aveva acceso una feroce battaglia per dimenticare i sapori prima tanto amati, cominciò a parlare: “Signore so che non mi crederete, perché io stesso stento a pensare vero quello che sto per dirvi… ma … ho le prove… qui.. con me..” Frugò nella tasca ed estrasse lo straccio, stringendolo forte nella mano tremante, esposta in bella evidenza al comandante che lo osservava muto e incuriosito.
“Voi conoscete certo la bottega di Biagio Cragnio, il luganer …” “A San Zan Degolà” Confermò il Valier che, come tutti, incuriosito dalla moda popolare, ci era passato e dovendo pure controllare la qualità della merce, si era gustato il famoso guazeto ,offerto naturalmente dalla casa. “Ci sono stato anche oggi.. Ci vado spesso – Confessò con pungente rimorso Tonio – Ma non potevo pensare mai.. “ “Una rissa.. qualcuno accoltellato.. eh lo so, lì c’è sempre confusione, gira anche brutta gente.” Anticipò il comandante, ipotizzando che la mano stringesse l’arma del delitto, lui le capiva al volo certe cose, era l’esperienza del suo mestiere.
“No, no, nessuna rissa… sono andato presto, dovevano ancora arrivare gli operai.” “E allora?” Interrogò Martino, un po’ indispettito d’essere stato smentito nella sua brillante intuizione. “Vede, comandante, ho chiesto di mangiare il solito guazeto” “Oh ben fortunato voi, che io ho dovuto mangiar solo la sbobba della guardia.” Mentì il Valier, che invece si era divorata una magnifica frittura alla Locanda della Sacrestia. “Sì, ma vede – indugiò Tonio, reso più incerto dal tono confidenziale, che reazione avrebbe avuto il comandante che si capiva conosceva bene i sapori dell’orrida zuppa? – Mentre mangiavo, col pane vecchio, perché la polenta ancora non era pronta..” “Andiamo, figliolo, facciamola corta!” Stimolò Martino che ora non capiva davvero dove si volesse andare a parare, non vorrà mica denunciare che hanno truffato sul conto? “Sì, ha ragione.. è che non so come dirlo.. insomma – si fece coraggio – ho sentito come qualcosa di duro che mi aveva ferito la bocca.. ho pensato a un pezzo di crosta del pane..” Martino lo fissava come fosse apparso un fantasma. Essere svegliato per sentire l’assurda storiella del pane duro nella zuppa.. era un pazzo costui? Tonio intuì e capì che ormai il dado era tratto e si doveva arrivare in fretta al finale. “Non era pane, comandante – disse tutto d’un fiato – era questo!” Aprì la mano e scostò la stoffa.
Il ditino, ripulito dal sugo, apparve in tutto il suo candore. Quella perfezione miniaturizzata che tutti sorprende alla vista delle mani dei bimbi e accende immediata, totale, incontenibile tenerezza e ci fa dire a volte quanto sono belli, da mangiarli (sic!) di baci, apparve nella stoffa orribilmente mutilata. Nella stanza il silenzio esplose come una bomba.
Fu il comandante, il primo a rompere la bolla di melassa temporale in cui la scena era affondata. Immobili istanti che restano scolpiti nella memoria di chi li ha vissuti. Ricordi indelebili anche a distanza di molti anni, quando tutti gli altri dettagli sono scomparsi, rimangono come un presente incancellabile. Valier prese in mano la stoffa. Non ebbe il coraggio di impugnare subito il reperto. Avvicinò la tela al volto e infine, usando sempre il tessuto come filtro, prese tra le dita quel misero resto di una vita. Feroce scoppiò in lui che pure era padre, la memoria del corpicino delicato del figlio maschio, morto tempo addietro. Quelle manine, spesso, il piccolo le confrontava, poggiando il palmo su quelle forti del padre. Allora Martino sentiva tutto il calore del corpo che ora tanto gli mancava e poteva vedere, come in una perfetta cornice, quelle piccole dita dolci che assomigliavano a quelle affusolate della madre. Era come se quel dito che gli stava davanti fosse stato strappato a suo figlio. Orrore e rabbia si fusero nel pensiero, mentre la mente audace percorreva tutte le strade. Anche lui aveva mangiato quella fetida pozione. La nausea lo invadeva e anche uno stupido senso di colpa, quasi di complicità. La mano tremava per l’emozione e ne fu davvero sorpreso. Non pensava di poter essere così fragile. Non si diventava facilmente comandante della guardia a Venezia. E il Valier quell’incarico se l’era conquistato, dimostrando tutto il suo valore guerriero in scontri disperati, da cui chiunque sarebbe fuggito. Sempre si era dimostrato freddo e convenientemente calcolatore. Mai preda del panico e sagace nell’inseguire le migliori strategie risolutive.
“Siete certo di quello che affermate?” Chiese a Tonio che aveva quasi cessato di respirare davanti all’evidente turbamento. “Oh.. vedete.. ne ho ancora traccia sul palato.” Rispose il giovane operaio, aprendo la bocca come davanti a un dottore e lasciando intravvedere il solco sanguinante che l’unghia appuntita aveva causato. “Ne avete parlato con altri?” Proseguì il Valier che stava riacquisendo la professionalità indagatrice. “No, no.. sono uscito, dopo aver pagato… senza farmi notare.. stavo male.. non ho detto niente a nessuno.. non sapevo che fare.. poi ho pensato di venire qui.. da voi.” Concluse, lanciando un implicito apprezzamento alla fama di onestà che circondava quel vecchio guerriero. “Avete fatto bene - Confermò Martino – Ora dovete mantenere il segreto.. mi capite? Nessuno deve sapere! Nessuno, niente moglie, niente amici fedeli, niente….Nessuno!” Il comandante aveva ripreso il controllo totale e lo esercitava, com’era solito fare, senza indugi e con quel tono perentorio che induceva facilmente all’obbedienza. “Nessuno” Confermò Tonio, come ipnotizzato. “Bene, ora lasciatemi i vostri dati e tornate al lavoro. Inventate una scusa e non fate parola di questo!” Repetita iuvant, pensò Martino mentre trascriveva il nome e l’indirizzo del giovane operaio che, subito dopo, uscì un po’ stordito, ma come risollevato da quella prima confessione. Le gambe ancora tremavano e il pensiero orrendo bussava di nuovo pulsante alla coscienza. Però, c’era ora una nuova barriera razionale, qualcosa di giusto aveva fatto. Se poi avesse avuto il seguito che si aspettava… l’arresto… la giusta punizione… forse col tempo sarebbe riuscito a cancellare quel sapore dolciastro che nella memoria lo perseguitava e lo costringeva ora a fermarsi alla prima malvasia, per tracannare d’un fiato un bicchiere di vin greco resinato.
Valier, rimasto solo, pensò che non doveva sbagliare una mossa. Il caso poteva avere enormi conseguenze e servivano certezze totali. Tutta la città conosceva quella bottega. Tutti, compresi molti nobili influenti, avevano assaggiato quella zuppa rinomata. Martino sapeva, per lunga esperienza di rapporto con i superiori, quanto fosse difficile convincere di sconvenienti ipotesi investigative persone che ne fossero in qualche modo coinvolte. Anche solo per leggerezza. In questo caso, poi, si trattava di trasformare una folla di entusiasti estimatori, in una bolgia di orrendamente truffati. Senza via di scampo, senza alcuna possibilità di furbesche vie d’uscita, del tipo sì io un po’ l’avevo capito. No. Restava solo l’idiozia, la stupidità di non aver compreso, di esserci cascati in pieno. E anche quel fastidioso senso di colpa, stupido ma inevitabile, che lui stesso aveva provato.
Servivano prove inconfutabili e che favorissero anche l’evidenza che nessuno avrebbe potuto sapere e neppure immaginare. Solo così sarebbe riuscito a trasformare il desiderio di cancellare, di non sapere, di minimizzare, di soffocare, di ridimensionare per salvare la faccia, nelle giusta rabbia, animata dalla sete di giustizia. Decise che anche lui non avrebbe parlato con nessuno. La sua autorità gli consentiva di utilizzare il corpo di guardia per operazioni improvvise, anche senza mandato delle magistrature, quando vi fosse sospetto di azioni delittuose in atto, che spettava a lui fermare. Dunque, l’unico vero problema era trovare evidenze talmente palesi da poter cancellare ogni dubbio. Se poi non ci fossero state, c’erano sempre quel misero reperto e la denuncia sincera di Tonio, sufficienti a giustificare l’indagine ed anche la chiusura cautelare del locale. Sulle frodi alimentari le leggi veneziane erano severissime e almeno di questo non si poteva dubitare.
Partì accompagnato dalle sue guardie migliori. All’inizio si accorse che bofonchiavano. Quando la giornata procede lenta e senza scossoni è difficile liberarsi da quella dolce pigrizia che induce a credere alla saggezza dell’ozio. Ma in realtà si trattava di uomini d’azione, abituati a trovare nel gesto fisico la soddisfazione euforizzante. Il piglio deciso del comandante poi non lasciava dubbi. Stava accadendo qualcosa d’importante. Dunque, niente indugi. Domani ne parlerà tutta Venezia e magari qualche giovane sposa vorrà saperne di più e si potrà dire, c’ero anch’io. Martino non aveva dato spiegazioni, se non il comando risoluto a formare il drappello per un’ispezione che avrebbe richiesto decisione e concentrazione. Contava sulla loro affidabilità e lasciò intendere che si sarebbe ricordato di chi non avesse tenuto fede al patto. Tagliarono la città con passo deciso, suscitando la curiosità momentanea dei passanti che si scostavano intimoriti, per lasciare il passo a quei soldati che, come al solito, in pubblico avevano assunto l’espressione determinata e feroce che si addice alle forze dell’ordine.
Giunsero che ormai si faceva sera in campo San Zan Degolà. Si era già formata la coda vociante dei clienti golosi, felici della giornata spesa e in attesa della calda pietanza e della brocca di vino, con cui di sera si poteva abbondare. Qualcuno protestò per le spinte irriguardose delle guardie che si facevano largo, incuranti di ogni ostacolo che veniva, facilmente e bruscamente, buttato a lato. Furono dentro il lungo corridoio in un attimo. Nessuno riuscì a capire cosa stesse accadendo. Martino, in testa al gruppo, si limitò ad annunciare l’autorità della Serenissima, già evidente a tutti dalle insegne della veste. Spalancò la porta della cucina e da dietro ai pentoloni fumanti, vide il grugno scolpito nel legno della Carnia di Biagio. Lo fissava tenendo sospeso in aria il coperchio che aveva sollevato per controllare la cottura. Le fiamme del caminetto, le luci balzane delle candele, i vapori brontolanti e gli odori speziati che abitavano la stanza, diedero al Valier l’impressione d’essere entrato in Inferno.
Il gigante sembrava immobile tra le nuvole del vapore. Una statua che s’interrogava rapidamente, uscendo dalla sorpresa. Poi capì. Un piccolo, sornione, complice, mellifluo sorriso si fece strada nel volto. Come dire, siete qui per quello? Ma ancor prima aveva inteso tutto Martino, che fu rapido nell’impugnare la spada, puntandola dritto verso quel ghigno che avrebbe voluto essere conciliante. D’istinto Biagio si riparò col coperchio, in tempo per sentire il comando urlato alle guardie dal Valier: “Voi dentro quella porta! Frugate ovunque! Aprite ogni vaso! E tu cuoco – aggiunse con voce tonante – non un gesto… O il naso e le orecchie finiranno in pentola!” Concluse, con cinica ironia.
L’urlo delle guardie fu udito anche dagli avventori che, accalcati, curiosavano petulanti e delusi per l’attesa che si faceva lunga. Perfino Biagio trasalì e Martino sentì la pelle raggrinzirsi e un’onda elettrica percorrergli la nuca. Se mai un suono può comunicare qualcosa, quel grido comunicò a tutti orrore. La prima guardia che uscì vomitò ai piedi del comandante. La seconda impugnò la brocca del vino e bevve avidamente prima di annunciare: “E’ la vista peggiore della mia vita… - prese fiato e aggiunse – un macello … di bambini.. pezzi sparsi.. dappertutto… perfino le interiora ha conservato… e il sangue …. Nelle brocche..” Si fermò e guardò quella piccola che ancora teneva in mano. Sputò di colpo il resto del vino che prima impulsivamente aveva ingoiato. Fece per avventarsi sull’immobile luganegher che ormai aveva rinunciato alla difesa. Tutto troppo rapido e nessuna via di fuga. Gioco finito. Ne era quasi contento. Niente più sotterfugi, e notti in bianco a squartare, tagliuzzare, sminuzzare e insaccare e cucinare. Tanti “schei”, ma anche tanta fatica. E poi, ultimamente, era divenuto tutto più difficile. Anche lì, in terraferma, gli accampamenti dei poveri diminuivano e nei mercati i bimbi erano tenuti d’occhio. Certo le sue salcicce, i salami attiravano sempre quei piccoli affamati. Però poi bisognava trovare il momento giusto e l’angolo buio in cui concludere l’azione. A volte li stordiva e li finiva poi in barca, per non lasciare tracce di sangue. Quello lui lo raccoglieva, tornava buono per le salcicce e il sugo. Ma tutto il tragitto, di notte e spesso col tempo incerto, doveva farlo da solo, vogando a un remo che è sempre un’agonia, anche se si è forti come una quercia. Peccato solo per il bel successo e il tanto denaro. In fondo, quello che più lo appagava era sentire dire che il suo era il miglior squazeto. E vedere anche quei nobili ben vestiti e quelle dame profumate che s’azzuffavano per un tavolo nella sua stamberga, in mezzo agli operai. “Incatenatelo robusto – ordinò il comandante – senza fargli del male.. ci penserà la quarentia.. io vado dietro a vedere!”
Lo fece e se ne pentì. Lui avrebbe dovuto riferire e per esperienza non si fidava di altri testimoni. Non immaginava che la meticolosa professionalità del lugangher potesse riservargli un tale sconvolgimento. A suo modo tutto era ordinato. Le membra sminuzzate da una parte. Visceri e interiora da un’altra. E sangue, sangue raccolto in brocche. A tutti, in natura, il cucciolo provoca irrimediabilmente una spontanea tenerezza, nella goffaggine di un corpo ancora incerto. Quel sentimento intenso si trasformò in un violento paradosso, di fronte ai pezzi confusi nel secchio, come relitti di una vita stroncata. E, ancor peggio, trasformata in pietanza dall’orco, come nelle fiabe. Il sistema vagale di Martino ne fu intossicato. Sudore e nausea presero il sopravvento. Dovette uscire. Si fece forza per senso del dovere. “Fate strada, Passa la giustizia!” Urlò, conducendo fuori il drappello col gigante incatenato.
“La bottega è chiusa per ordine della Serenissima!” Aggiunse, lasciando alcune guardie a custodia delle prove. La gente ancora non capiva. Molti apparivano dispiaciuti nel vedere trascinato via il cuoco preferito. Magari si trattava solo di qualche irregolarità nelle tasse o nelle misure della bilancia. A volte la Repubblica è fin troppo severa. Togliere dall’attività un così bravo luganegher per quisquilie burocratiche. Dove lo troviamo noi un altro posto dove si mangia così bene per pochi schei?
La quarantia criminale si riunì la sera stessa. Davanti ai magistrati increduli, Biagio tenne un atteggiamento conciliante. Non vi fu bisogno di tortura. Le prove indicate dal Valier erano evidenti. L’imputato stesso confessò, con stupefacente candore, che sì era tutto vero e che l’aveva fatto per i “schei” e la fama in città. Mentre gli scrivani tentavano di riordinare le molte denunce che si erano accumulate in quegli anni, bimbi poveri scomparsi e mai ritrovati, specie nella terraferma, i magistrati sconvolti disputavano sulla pena da infliggere. Inutile approfondire il conteggio, decine erano state le vittime. L’orrore si aggiungeva alla rabbia di non aver saputo scoprire prima i terribili delitti. Vi era anche il timore che il popolo sconvolto, e chi non lo sarebbe stato sapendo di aver divorato goloso i propri figli, si rivoltasse contro l’ignavia delle autorità che avevano permesso che accadesse. La pena doveva essere esemplare e crudele. Inutile pensare che il gigante che era giunto a tanto fosse pazzo. Nessuna scusante. E nessuno osò pronunciare parole di moderazione. Fu ripristinata la procedura più severa per la pena capitale, che doveva essere eseguita l’indomani, evitando che se ne potesse parlare troppo.
Biagio dormì tranquillo quella notte. I carcerieri non osarono accanirsi contro il gigante che incuteva, anche da prigioniero, un certo timore. Fu anzi dato loro l’ordine di tenere l’uomo in buona forma, per favorire il supplizio che lo doveva trovare ben consapevole dei suoi peccati. Ma vi fu chi si chiese cosa potesse capire quell’essere disumano, che pareva perfino lieto della sbobba che gli fu offerta. Solo all’alba, quando andarono a prenderlo, sembrò intimorito e continuava a chiedere quando sarebbe tornato alla sua bottega.
Vi ritornò quella mattina stessa, ma non come avrebbe sperato. Fu prima condotto a Santa Croce dove, come antipasto, fu torturato con tenaglie roventi. Poi gli venne amputata la mano destra che gli fu appesa al collo. Il moncone, cauterizzato con ferri roventi, fu ricoperto con interiora di vacca. Quindi, fu portato a San Zan Degolà, nel locus commissi delicti, dove patì l’amputazione dell’altra mano. Infine fu trascinato, a coda di cavallo, cioè legato dietro a un cavallo che lo faceva strisciare a terra e sbattere contro qualunque ostacolo, fino in piazza San Marco. Sotto le colonne della piazzetta, venne decapitato e successivamente squartato. I suoi quarti, a perenne ammonimento, furono appesi ai quattro angoli cardinali della città.
La bottega e la casa furono abbattute e bruciate. Si volle così cancellare ogni memoria degli orrendi crimini di cui si era macchiato, Biagio, per gli amici Biasio, Cargnio.
Ma a volte la storia organizza delle beffe. Benché non vi siano prove storiche certe della leggenda dell’orco veneziano, rimane curioso che unica, tra le tante rive di Venezia, in genere dedicate a Santi o chiese, vi sia ancora oggi la riva di Biasio esattamente nei pressi ove la leggenda collocava la locanda. Una cronaca, scritta tra la fine del secolo XVI° e il principio del XVII° (Cod.XXX, Classe VII, della Marciana) ne conferma almeno l’esistenza con le seguenti parole: “Nota che tutte le barche venivano da Mestrina arivavano all’hostaria di Biasio hora detta riva di Biasio”
Anche oggi, dove si fermano i “camionisti”, in genere si mangia bene con pochi soldi.
Sotto la tunica di lana grezza il pugnale premeva sul fianco. Saverio, seduto, accovacciato, ricoperto dall’abbondante cappuccio fingeva di dormire, ma vegliava tremante. Davanti a lui, steso a terra ai piedi del sottoportico, stava la figura rannicchiata, avvolta nel mantello povero del pellegrino. L’oscurità era quasi totale. Solo una piccola torcia ardeva ancora, lanciando bagliori dal vicino campo. La Marangona aveva da tempo annunciato la svolta della notte. Il freddo cominciava a mordere rallentando la corsa verso le ore piccole che parevano ibernate. Tutto sembrava essersi fermato. Solo il suo cuore pulsava sempre più forte. Poteva quasi sentirlo nel silenzio di quell’angolo appartato, rotto solo da qualche grido di gondoliere proveniente dal vicino Canal Grande. Nobili che ritornano da piacevoli avventure, aveva pensato, invidiando il morbido femmineo tepore che forse godevano al riparo della felza. A lui toccava altro destino. Non solo il freddo, ma il rischio di morte. Si mosse lentamente per accentuare la visione da sotto il cappuccio. Sapeva che questa era la situazione di maggior rischio. La sede segreta dei Cavalieri di Malta era vicina, appena oltre al campo, in Calle del Perdon.
L’accordo era stato chiaro, un fischio prolungato e subito sarebbero accorsi. Non dubitava che come lui vegliassero in attesa di eventi. Tuttavia c’erano buoni motivi per temere l’agguato. Troppi nemici, tanti. Gli imperiali di Federico Barbarossa, gli opportunisti seguaci dell’antipapa, i Comuni della Lega che temevano la pacificazione, le famiglie romane avverse, i Normanni che spesso non capivano i bizantinismi della politica, l’imperatore d’Oriente che sapeva mutevoli i confini dell’alleanza, gli stessi veneziani che in parte si professavano favorevoli all’impero tedesco e soprattutto mutavano con facilità alleanza a vantaggio dei commerci.
Il doge, Sebastiano Ziani, eletto nel settembre del 1172, aveva cominciato la carriera nell’attività mercantile. Sale, pepe e altre spezie, qualcuno diceva pure strozzinaggio, furono la sua fortuna. In breve era riuscito a costituirsi un immenso patrimonio. Fu anche per un periodo diplomatico a Costantinopoli ove sembrava aver appreso bene il concetto levantino di alleanza. Pur avendo aderito alla Lega di Pontida, infatti, non esitò ad allearsi col Barbarossa contro l’imperatore Commeno per il possesso di Ancona. Nel 1175, nonostante la sconfitta imposta ai Normanni nella battaglia navale di Corfù, si alleò con gli stessi contro i Greci. In quell’anno le alleanze dei veneziani mutarono per ben quattro volte solo con i Normanni e i Greci e due con gli imperiali.
Saverio aveva saputo da un cavaliere di ritorno da Costantinopoli che in quello stesso anno Enrico Dandolo, ambasciatore veneziano presso il Commeno, venne fatto abbacinare dall’imperatore dopo un acceso scontro verbale e divenne quasi cieco. Dunque quell’invito al papa Alessandro III per una riconciliazione col Barbarossa a Venezia poteva ben nascondere trappole mortali.
Il piano congegnato da Rolando Bandinelli, dal 1159 papa Alessandro III, aveva dunque senso e dimostrava ancora una volta la geniale prudenza del vecchio, travestito da pellegrino, che ora dormiva, o fingeva di dormire, disteso davanti a lui, sotto l’architrave del sotoportego de la Madona a S.Aponal. Vi erano giunti quel giorno da Zara, dove erano stati accolti qualche giorno prima con grandissime feste. Una fuga decennale, dopo la completa disfatta dell’esercito comunale romano, guidato da Ottone Frangipane, nel maggio del 1167. Giorni terribili, assediati dall’imperatore con le sue truppe sotto Monte Mario.
La popolazione, cedendo alle lusinghe di Federico imperatore aveva chiesto ad Alessandro III di abbandonare il soglio, insieme all’antipapa sostenuto dal Barbarossa, per eleggere un nuovo papa e chiudere la lunga contesa. Alessandro fu inflessibile. Resistette presso i Frangipane tra le solide difese delle case poste tra Colonna, la Thurris Chartularia e S.Maria Nova. Poi, crescendo i pericoli “evanuit”, sparì. Fu avvistato a Terracina, Gaeta, Benevento.
Nel frattempo avvenne il miracolo. Uno di quei segni che sempre avevano accompagnato la sua esistenza, impressionando non solo la mente del fido Saverio, ma tutta la coscienza dei popoli comunali allora in rivolta. La peste, scoppiata tra le truppe tedesche, distrusse l’esercito imperiale e lo costrinse ad una lenta e tragica ritirata.
Saverio aveva spesso riflettuto su quella strana “coincidenza” che spesso si era ripetuta nella vita di quell’uomo di cui era divenuto il più fedele servitore. Lo aveva conosciuto nel 1157, a Besancon in Francia. Era stato assegnato, giovane cavaliere ventenne, come guardia personale dell’allora cardinale e cancelliere pontificio Rolando, nella difficile missione. Il vescovo Esquilo di Lund, di ritorno da Roma, era stato rapinato e imprigionato da alcuni cavalieri imperiali. Il papa di allora, Adriano IV, aveva inviato Bandinelli dall’imperatore Federico Barbarossa per chiedere la liberazione del vescovo, la riconsegna dei beni e soprattutto il rispetto delle priorità del papa sull’impero.
Saverio ricordava bene la scena. L’imperatore, affiancato dai suoi cavalieri, stava in piedi di fronte al cardinale Rolando che, in ginocchio, chiedeva il rispetto delle prerogative papali. La sala vibrava di tensione mentre il Barbarossa, sorridendo, ricordava i suoi possedimenti, la forza del suo esercito, la grandezza del suo impero. Cosa avrebbe potuto fare il papa, armato solo dalle poche famiglie romane, in una piccola frazione della piccola penisola? Fu allora che Rolando si alzò e pronunciò la storica frase che apri la lunga contesa tra papato e impero. “I a quo ergo habet, si a domno papa non habet, imperium?” (Da chi dunque il principe ottiene l’impero? Da chi se non dal papa?)
Il gelo piombò nella sala. Gli occhi dei due contendenti si fissarono a lungo. Rolando resse la sfida, consapevole della forza, non solo simbolica, dell’incoronazione papale. Tutti lo sapevano, anche l’imperatore e i suoi cavalieri che mal sopportavano questo indissolubile vincolo dell’autorità.
La rabbia s’impadronì di uno di essi, Ottone, il più giovane e focoso. Voleva dare una lezione a quel prete saccente e chiuderla finalmente con questa stupida storia. Estrasse la spada e menò un fendente che certo avrebbe tagliato la testa a Rolando se la fibbia dorata che chiudeva il suo mantello e il rapido riflesso con cui aveva allontanato il capo non l’avessero salvato. Ottone fu subito bloccato dallo stesso imperatore che ben sapeva troppo pericoloso, in quel momento, un gesto così clamoroso. L’Inghilterra, Bisanzio e chissà quanti altri ancora aspettavano solo un simile errore per rimettere in discussione la sua autorità. Non avrebbe commesso una tale ingenuità. Si limitò ad ordinare al cancelliere papale di abbandonare immediatamente la corte, impedendogli di aver contatti col clero tedesco durante il viaggio di ritorno.
Saverio, che durante lo scontro era rimasto paralizzato e disarmato, com’era d’obbligo alla presenza dell’imperatore, aveva medicato al cancelliere pontificio la ferita che la punta della spada aveva inferto tra lo zigomo e l’orecchio. Provocò una cicatrice indelebile che il futuro papa spesso accarezzava quando era immerso nelle sue riflessioni.
“Vedi Saverio, come la forza della Provvidenza sa manifestarsi – gli disse mentre subiva la medicazione – quella fibbia con la croce… mi fu donata dal papa. Così si difende il regno di Pietro.”
Saverio aveva annuito, ancora scosso e certo impressionato dallo scampato pericolo. Nell’immediato si era chiesto cosa sarebbe stato di lui se il cardinale fosse morto. Inoltre, concordava sulla sorprendente efficacia della deviazione della lama che tuttavia, benché fedele non era un prete, gli parve al momento solo una favorevole coincidenza.
Ma di coincidenze ve ne furono molte altre. Ebbe modo di assistere da vicino nei vent’anni trascorsi al suo fianco, a molte sorprendenti situazioni nelle quali il destino sembrava favorire quel vecchio energico che ora giaceva davanti a lui.
A Roma, durante l’assedio, la sua scomparsa improvvisa era passata alla storia come una magica sparizione. Solo Saverio sapeva la verità di quella fune improvvisamente spezzata, mentre tentavano di calarsi dalla torre assediata. Ormai non c’era più scampo. Pochi gradini e l’ultimo portone, quindi il cul de sac. Non restava che calarsi dal finestrone verso il cortile posteriore. Saverio aveva lanciato la corta fune che fungeva da passamano della scala. Poi il papa si era aggrappato e aveva cominciato a scendere senza indugi. Ormai si sentivano distintamente le urla del combattimento e lo strepito delle spade che risalivano come fiamme sul caminetto. Anche Saverio dovette lanciarsi sulla fune. In quell’attimo la corda si spezzò. Nel punto esatto dell’ancoraggio, così che nella torre non ne rimase traccia.
Precipitarono entrambi per qualche metro. Poi si trovarono quasi soffocati nel carro di fieno che in quel preciso istante correva affannato per raggiungere il Tevere e salvare così il carico dal putiferio della battaglia. Erano quasi abbracciati, ammaccati, indolenziti, ma salvi. Non dissero niente finché l’andatura non si fece più tranquilla e tacitarono un poco gli echi dello scontro. Le urla del battelliere chiarirono che erano al fiume.
Solo allora Saverio riacquisì la freddezza del guerriero. Si alzò oltre la curva del fieno. Vide il fiume e quella specie di zatterone che attendeva il carro. Fece cenno al compagno di tacere e si nascose. Frugò sotto la tunica. Restava solo il coltello, quello segreto che celava per le emergenze. Ben più importante fu ritrovare appesa alla cintura la sacca delle monete. Un’arma più potente per quella fuga che gli parve davvero miracolosa. Sembrava quasi un piano predisposto con perfetta sincronia. Non ci avrebbe creduto se non la stesse vivendo concretamente, di persona.
Attese che il carro cominciasse a scivolare lungo la corrente, poi s’inerpicò oltre la balaustra di contenimento e saltò dietro il carraio e il battelliere che stavano discutendo. Si girarono improvvisamente muti. L’occhio popolare di entrambi capì subito dall’abito, dal corpo, dallo sguardo che quell’apparizione apparteneva al mondo delle armi. Gente con la quale non vale la voce grossa. Gente, peraltro, spesso in grado di pagare meglio di qualunque altro. Così fu.
“Mi serve il tuo mantello “ Disse Saverio rivolto al battelliere “Ed anche la tua tela” proseguì, rivolto al carraio che teneva sulla spalla una lunga pezza di cotone per ripararsi dal fieno.
L’ordine imperativo fu accompagnato da due brillanti e convincenti monete d’argento. Non servirono altre parole, neppure allo sbarco, quando altre due monete convinsero i due che la loro improvvisa fortuna non doveva chiedere troppo al destino. Nessuna domanda sul secondo passeggero, né tantomeno ebbre debolezze alla locanda. Quel guerriero dalle molte cicatrici non lasciava dubbi. Il complice silenzio significava aver rimediato alla scarsa annata, una parola in più e la loro vita era segnata. Gli umili ben conoscono la vendetta dei potenti.
E quale portentosa fortuna salvò la galea dei Normanni che li stava portando a Zara? Si erano imbarcati a Vasto ai primi di Marzo. La galea era scortata da altre quattro che la circondavano pronte ad ogni evenienza. Il cielo quasi primaverile, denso di un vento allegro e la fretta di evitare incontri indesiderati, avevano convinto i comandanti a salpare, nonostante gli avvisi dei locali. Qualche pescatore aveva suggerito che la luna fosca ed oscurata del giorno prima poteva annunciare tempesta. Leggende locali che ai comandanti normanni, avvezzi alle burrasche nordiche, parvero pretesti.
Le vele si aprirono all’alba e le galee volarono sulle onde spinte da un impetuoso vento di scirocco favorevole alla risalita. Nello spazio ristretto dove alloggiavano, non vi era possibilità di vedere all’esterno. Solo da una piccola feritoia laterale Saverio poteva scorgere le onde che si alzavano sempre più col procedere delle navi verso l’alto mare. Si sentiva lo stridere delle gomene che reggevano la vela, lo scricchiolio del legno che pareva stringere i denti per reggere lo sforzo. E il respiro profondo dell’onda ogni volta che, sollevata come in un lungo balzo la poppa, la abbondonava spingendola avanti quasi con rabbia. La galea accelerava in discesa sull’onda, poi rallentava e veniva di nuovo aggredita dalla cresta successiva.
“Il mare respira profondo” disse il papa che aveva colto nel viso di Saverio la traccia della preoccupazione “E il mio stomaco…lo accompagna” Aggiunse rivelando il non detto di entrambi.
In quella scatola di legno chiusa, la continua altalena cominciava a fare effetto. Fu così per tutto il giorno, fortunatamente confortato da qualche uscita sul ponte. La luce, l’aria, la bellezza del mare e qualche boccone di pane secco con acciughe salate avevano risolto anche la cornice di nausea continua.
Saverio aveva continuato a chiedere dove si sarebbero fermati. Il vento non calava, anzi sembrava rinforzare. Le creste delle onde, da piccole pennellate di giovane pittore, si erano trasformate in mezze lune sfolgoranti. Le galee al loro fianco, sempre più lontane, evidenziavano la lotta di galleggiamento. Un movimento che le portava prima così alte che si poteva intravvedere lo scafo, completo del remo timone quasi emergente. Poi con un tuffo improvviso, sparivano dietro l’onda, lasciando a vista solo l’estremità dei pennoni. Ogni volta che le navi sbuffanti risalivano, sembravano annunciare che anche per stavolta ce l’avevano fatta, ma chissà la prossima.
Saverio si teneva saldamente al legno che traversava la coperta sotto la timoneria. Dietro di lui due marinai e il pilota lottavano senza distrazioni per reggere la barra del timone laterale nella discesa sull’onda. Il nostromo incalzava con ordini affannati i marinai. La vela gonfia sembrava scoppiare e gli stralli tesi come corde d’arpa ritrovavano bruscamente la pace ogni volta che la prua affondava. Poi di colpo strappavano quando la galea risaliva a portata di vento. Benché tutto fosse stato assicurato con corde, sulla coperta vari oggetti correvano inseguendo gli sbuffi d’acqua ed i cavalli, sospesi alle cinghie che li tenevano eretti, nitrivano incessantemente. Sotto coperta, soldati e rematori toccavano frenetici gli amuleti in cerca di conforto. Qualcuno in silenzio pregava. E il peggio doveva ancora arrivare.
Verso sera il vento parve calare. Da un lato il cielo cominciò ad oscurarsi precocemente. Saverio intuì che non si trattava solo del tramonto. Lo confermavano i volti dei marinai che continuamente scrutavano l’evoluzione di quelle nubi. In un primo tempo le aveva confuse con l’incalzare della notte. Poi si rese conto con terrore che si trattava del nero bluastro di un possente temporale. Bagliori crescenti confermarono l’ipotesi. Si trovavano in mare aperto, forse vicini alla meta che tuttavia non si vedeva. Nessuna possibilità di tornare indietro. Nessuna possibilità di riparo.
Raggiunse il comandante, un nobile cavaliere francese che si stava consultando con il pilota. Concordarono che il luogo più sicuro per il papa restava quella piccola cabina del comandante. Si rifugiarono lì, mentre ormai il cielo plumbeo cominciava a lanciare le prime violente gocce. Fu abbassata la vela e i vogatori e soldati tornarono ai remi. Le voci concitate erano in parte coperte dal tamburo degli aguzzini che cercavano di mantenere il ritmo della voga. La pioggia arrivò di colpo, impetuosa. Sembrava una cascata montana moltiplicata. A stento si riusciva a vedere qualche metro avanti. L’acqua scorreva come un ruscello sul ponte, mescolandosi col mare che, con onde spazzanti, cercava di far sua la nave. Dentro quella scatola di legno gocciolante, Saverio cercava di riparare il papa con un telo che aveva trovato sul ponte. Lo aveva abbracciato per poterlo avvolgere completamente.
“Sei un soldato affettuoso – scherzò Alessandro – Non temere, qualcuno ci abbraccia anche in alto. La nostra missione non è ancora compiuta”.
Saverio accolse quell’iniezione di fiducia con tutta la speranza che aveva. Ma nell’intimo cominciava a dubitare che si sarebbero potuti salvare. I lampi illuminavano l’interno della gabbia attraverso le feritoie del legno e il frastuono secco e violento dichiarava che erano nel cuore della tempesta.
La barca aveva perso la regolarità dell’oscillazione. Ormai il rollio e il beccheggio si mescolavano con declinazioni sorprendenti. Non si capiva più da dove venisse il vento e l‘onda corta e cattiva rendeva quasi impossibile dare una rotta alla nave. Si sentivano le urla dei vogatori che tentavano di dare stabilità, se non con la spinta almeno con l’immersione dei remi. Lo scroscio della pioggia alternava pause a scardinanti raffiche, finché violenta, rumorosa, quasi condanna definitiva, giunse la grandine. Sembrava che la galea fosse inchiodata da cento, mille falegnami armati di possenti martelli. I chicchi rimbalzavano sul ponte con giocosi saltelli e poi si accumulavano tra le spire delle gomene. Grossi quanto una ciliegia, talvolta anche più mettevano a dura prova la resistenza del pilota e dei marinai scoperti nella guida del timone. I lamenti e le imprecazioni divennero più forti. Qualcuno tra i capelli inzuppati cominciò a intravvedere del sangue. Era divenuto difficile anche camminare su quel tappeto bianco che ormai assomigliava ad una nevicata. E davvero il vento era divenuto ora gelato. Si manifestava in pieno lo scontro dei venti che aveva generato il temporale.
Dopo un’ora di battaglia tra i flutti, durante la quale avevano perso di vista le altre navi, il cielo cominciò a rasserenarsi ed arrivarono le prime raffiche del grecale.
Saverio si era procurato una coperta di lana che sostituì al telo ormai completamente zuppo. Fu allora che scoprì tra le mani congiunte del papa la fibbia dorata, quella croce greca inserita in un tondo sporgente che già una volta lo aveva salvato. Alessandro sorrise alla sua scoperta. Non servivano parole. Tutto era già stato detto. Saverio non indugiò oltre. Fosse talismano magico o prodigio della fede, l’importante è che aveva funzionato. Il suo militaresco pragmatismo si limitava ad analizzare la situazione. Erano sopravvissuti.
Niente più pioggia o grandine. Il temporale era passato. Nel cielo si potevano scorgere le stelle tra le ultime nubi ritardatarie. Solo quel vento freddo che continuava a farsi più teso lo teneva in agitazione. La vela era inutilizzabile e tutto ormai dipendeva dalla forza dei vogatori. Sul ponte, dove era uscito a controllare la situazione, arrivavano sempre più spruzzi d’acqua gelata ogni volta che la prua frangeva l’onda imbiancata.
Di quel vento aveva sentito parlare dai marinai veneziani, abituati a navigare lungo le isole a sud della Grecia, verso Bisanzio. Vento Greco lo chiamavano, perché da lì sembrava originarsi. In realtà lo incontravano spesso anche più a Nord, lungo la costa degli Schiavoni. La leggenda lo descriveva come terribile al largo. Quel vento amava il dispari, poteva cioè durare un giorno, tre giorni o anche cinque.
“Se rinforza ancora dovremo metterci di poppa” annunciò il pilota al comandante che in silenzio scrutava l’orizzonte ormai frastagliato dal rilievo bianco delle onde. “I vogatori non possono tenere a lungo questo ritmo... E se qualcuno cede potremmo traversarci… con grande pericolo…”
Il comandante indugiava. Tornare indietro significava vanificare la missione e forse incontrare qualche nave all’inseguimento di quel papa in fuga.
Fu a quel punto che giunse l’urlo: ”Relitto a prua!!”
Nel chiarore della mezza luna che illuminava l’inchiostro magmatico delle onde, apparve il guscio della chiglia. A un centinaio di metri dalla prua. Quando l’onda sollevò quei resti apparvero alcune figure umane aggrappate.
Il pilota non attese ordini dal comandante. Erano per lui scontati. Da sempre per la gente di mare il soccorso è un obbligo indiscutibile ed anche la migliore assicurazione. “Prepararsi alla manovra!!” Urlò sottocoperta ai rematori, mentre studiava il piano di accosto. I tempi erano stretti. Comandò a due marinai di correre alla fiancata di dritta, pronti al lancio delle gomene. Fece poi rallentare la voga dei rematori a sinistra per traversare leggermente la galea e intercettare il relitto sulla fila dei remi di dritta. Sperava di poter rallentare senza troppi danni la sua deriva, giusto il tempo di far aggrappare i naufraghi alle corde lanciate. Poi bisognava abbandonare rapidamente il relitto al suo destino. C’era il pericolo che rompesse i remi o ancor peggio che danneggiasse lo scafo della galea. Tuttavia al piano mancava l’alternativa. O così o quegli uomini si sarebbero persi per sempre.
Saverio intuì le intenzioni del pilota. Impugnò una lunga corda che aveva nella cesta davanti a lui. La avvolse rapidamente mentre la galea cominciava a traversarsi, ondeggiando per il rollio. Divise le due spire tra le due braccia. Da ragazzo aveva navigato lungo la costa a bordo della nave dello zio. Con i marinai si era divertito alle sfide adolescenziali. Il lancio più lontano della fune di ormeggio era uno di questi nel quale, in verità, eccelleva. Aveva capito che il segreto stava nel coordinare il movimento delle due braccia, cosicché lo svolgimento della fune fosse continuo. Esaurita la prima spira, iniziava la seconda, fino alla completa estensione della fune. Condizione ultimativa: il calcolo del vento, che quando è teso non solo contrasta ma a volte aggroviglia.
Mai scelta fu più opportuna. Rapidamente il relitto quasi precipitò scendendo dall’onda contro i lunghi remi della galea. Tre uomini stremati e urlanti erano aggrappati alla chiglia della cocca.
La galea fu spinta di lato dall’urto ed il relitto cominciò a scivolare lungo la fiancata. I marinai lanciarono le funi su cui due naufraghi si aggrapparono, scorrendo sui remi che fungevano da scivolo. Il terzo, più lontano e forse più stordito o indebolito indugiò nonostante le urla.
Il relitto cominciò ad allontanarsi inesorabile, sfilando lungo la poppa della galea, preda ormai di un’altra onda che lo avrebbe rinviato lontano. Fu allora che Saverio lanciò. Aveva preparto una serie di nodi alla testa della fune. Prezioso aiuto per l’inerzia del lancio e migliore garanzia per una presa che doveva essere solida al primo colpo.
Quando ormai negli animi di tutti si fece strada la disperazione per la fine di quell’uomo ormai lontano, una lingua elegante si svolse nell’aria. Aiutata dal vento e dalla forza del peso, sciolse progressivamente le sue spire estendendosi per tutta la lunghezza. Magia del lancio o buona sorte dell’ardimento, il nodo di testa giunse perfetto nelle mani del naufrago. La consapevolezza dell’incredibile fortuna moltiplicò le forze e sciolse ogni indugio. Ebbe la lucidità di ruotare due volte su se stesso e strozzare poi il nodo sotto la volta, prima di lasciarsi andare trascinato via dal relitto che ormai navigava verso il nulla.
Saverio, che aveva fissato la fune alla coperta, fu aiutato a recuperare in fretta il naufrago che scompariva e riemergeva dai flutti. Una rete venne lasciata pendere a poppa. Lì il disgraziato infilò braccia e gambe e venne issato rapidamente a bordo. Gli altri stremati erano già stesi in coperta. Il papa, richiamato dalle urla, era uscito dalla cabina ed aveva assistito alla scena.
“Santità – disse Saverio avvicinandosi – Il vento è freddo e la situazione ancora difficile. Meglio ripararsi”
“Io sono venuto ad aiutare il mio generoso scudiero – rispose Alessandro lasciando intravvedere tra le mani la sua spilla – e confortare la fede di tutti. Tra breve il disegno sarà compiuto. E ora… eseguo gli ordini” Si girò e rientrò nella scatola di legno, consapevole che la sua presenza poteva essere d’impaccio.
Saverio rimarcò l’ennesima coincidenza, ma preferì imputare il successo alla sua allenata abilità del lancio. Si avvicinò al gruppo di uomini che stavano confortando i naufraghi con coperte e sorsi d’acqua. Si inchinò per vedere l’uomo che aveva afferrato la sua corda.
“Ti devo la vita….” Sussurrò tremante afferrando le sue braccia.
Fu allora che vide quegli occhi e fu turbato. Dal buio emergevano inequivocabili, come la linea particolare del profilo. Perfino la voce, seppur sussurrata, gli era parsa la stessa. Ancora una volta prevalse l’intuizione accompagnata dal piglio deciso.
“Quest’uomo è troppo debole per restare qui fuori!” Gridò, vincendo il frastuono delle raffiche che ancora imperavano “Aiutatemi a portarlo dentro prima che sia troppo tardi”.
La sua era un’autorità indiscussa. Tutte quelle galee si erano mosse per un unico motivo e l’uomo che aveva impartito l’ordine era la persona più vicina a quel motivo. Non che mancassero le ragioni per trasportare il naufrago al riparo. Vinto dalla stanchezza e dall’ultimo disperato sforzo era come svenuto. Lo trasportarono di peso dentro alla stretta cabina. Alessandro si alzò appena vide la porta aprirsi come se aspettasse quel momento. Fece posto nella piccola branda di legno in modo che potesse distendersi. I marinai si allontanarono in fretta per raggiungere gli altri. La porta si chiuse. Restarono soli. Una debole lampada lampeggiava appesa al soffitto.
Una fiamma tenue, piegata dai refoli che attraversavano le pareti, lanciava piccoli lampi di luce che tuttavia bastavano agli occhi ormai abituati all’oscurità. Saverio la impugnò staccandola dal gancio e la portò vicino al volto dell’uomo disteso. Stremato, sembrava dormire. L’esplorazione diede conferma.
“Santità…Guardate” Disse Saverio con un tono di conferma.
Alessandro si avvicinò con calma. Ormai aveva superato di molto i settant’anni e la vista, benché sorprendente per efficacia, necessitava di buona luce. Osservò in silenzio per lunghi istanti, mentre si reggeva alle braccia di Saverio per vincere il beccheggio ancora potente. Si sporse un po’ in avanti per capire meglio. Poi parve come annuire a se stesso.
“Ecco un altro segno della Provvidenza” disse rivolto a Saverio “Non dobbiamo perdere quest’uomo.”
Impartì la sua benedizione e di nuovo Saverio scorse la spilla. Poi iniziò il soccorso. Saverio lo spogliò dagli abiti bagnati. Con dei pezzi di lana lo sfregò a lungo sui piedi gelati e le gambe livide per riattivare la circolazione. Fasciò le mani lacerate dalle molte ferite inferte dalla chiglia incrostata. Lo tenne al caldo del suo mantello. Il respiro si fece più regolare, come la forza del vento che ora pareva aver frenato l’accelerazione. Un vento teso e regolare. Così pilota e comandante concordarono l’inversione. Bisognava approfittare ora della pausa delle raffiche, sfruttando le residue energie degli uomini già molto provati dalla notte di burrasca. Saverio se ne accorse per l’improvviso sobbalzo che lo fece cadere sopra il giaciglio. Un rollio che parve farli precipitare nel baratro. Poi di colpo la nave riprese l’assetto. Sentì le urla di chi rimetteva in opera la vela. Il timone reggeva. La galea riprese la corsa col vento in poppa ed ogni cosa parve acquietarsi.
Il primo chiarore dell’alba li sorprese dormienti. Saverio si alzò dalla scomoda posizione seduta che però non gli aveva impedito di cadere in un sonno profondo. La scelta di mettersi di poppa era stata opportuna, ma fortunatamente anche quel vento greco aveva deciso di dimenticare la progressione dispari. Se ne accorse appena si affacciò fuori dalla porta di legno. Il mare ancora brulicava di serpentelli bianchi, però con un andamento regolare, senza le raffiche rabbiose.
“Va spegnendosi” Si incoraggiò
“Quando il sole sarà alto sarà già possibile ritornare in rotta” Suggerì il pilota alle sue spalle. Anch’egli appena sveglio dopo poche ore di riposo.
Si organizzava il cambio di guardia e si cominciarono a svegliare marinai e vogatori cui era stato concesso un po’ di riposo dopo la violenta e lunga battaglia con la tempesta.
Saverio rientrò con una brocca di acqua calda mescolata al vino speziato. Qualcuno era riuscito a ravvivare il braciere e tutti cercavano conforto da quel benedetto tepore. La versò in una tazza per Alessandro che aveva appena concluso la preghiera del mattino. Poi si avvicinò al naufrago, risvegliato dalle urla delle manovre. Porse anche a lui una tazza che egli impugnò con le mani fasciate e tremanti. Dalla porta che aveva lasciata aperta filtrava la luce piena di un’alba ormai trionfante. La realtà riprendeva le sue forme. La tempesta sembrava essere stata solo un brutto sogno, un incubo da cui quel sole, che correva veloce col suo carro, pareva aver posto una fine definitiva.
Saverio riuscì finalmente a vedere chiaro il volto dell’uomo che la sua abilità o la buona sorte avevano salvato. Non c’erano più dubbi. Era la copia esatta del papa. Una perfetta somiglianza fisica, soprattutto del viso. Un Sosia, come nell’Anfitrione di Plauto, aveva subito pensato. Ma qui in gioco c’era ben più della conquista di Alcmena da parte di Giove. Ora si trattava dei destini della Chiesa e di tutta la cristianità.
Quell’uomo era un segno della Provvidenza. Tremava nel pensarlo, perché la sua fede era sempre stata più un ossequio ai doveri che una passione sentita. Tuttavia anche il suo pragmatico scetticismo cedeva ora alla forza evidente di una coincidenza troppo opportuna. La concretezza del carattere riprese forza. Si trattava di aiutare quel dono divino a compiere il disegno programmato. Doveva capire chi era, da dove veniva, convincerlo al gioco delle parti e soprattutto trovare il modo di invecchiarlo, perché, anche se provato dalla vita, certo era più giovane di Alessandro.
“Grazie…” Disse l’uomo dopo aver trangugiato il calore della bevanda. “Stanotte ho sognato il Paradiso… Ma i veri angeli ora sono qui… Voi che mi avete tratto dall’Inferno… Credevo d’essere ormai perduto… Non vedevo più nulla… Solo le mani ostinate credevano ancora d’aggrapparsi alla vita… Poi… Quella fune… Mi ha colpito al volto, uno schiaffo quasi a punirmi della poca fede… Ho capito che Dio ha voluto… Vi sarò per sempre servitore” Concluse abbracciando Saverio, che aveva raccolto la sua tazza aiutandolo a bere.
Alessandro era sempre rimasto di spalle. Sembrava sapesse già tutto. Si girò e si avvicinò lentamente all’uomo. Era in controluce. Non si distinguevano chiaramente i profili del volto
“Fratello – esordì con la sua voce chiara che sembrava leggere un testo già scritto – Noi siamo umili servitori di un disegno superiore. Così la tua e la mia vita saranno indissolubilmente legate. Non stupirti di quel che vedrai. Non chiederti perché. Tu stesso poco fa hai dato la risposta. Ed era quella giusta.”
Si avvicinò di più, mettendosi di profilo in modo che la luce illuminasse il volto. Al collo aveva la croce papale messa in bella evidenza. “Te lo conferma il tuo papa, Alessandro III°”
Per un istante tuonò il silenzio, come quando dalle mani vola un grosso otre e tutti aspettano il fracasso. Per un attimo il tempo è come sospeso, poi tutto sorprende per dimensioni ben superiori all’aspettativa. Così fu. Tanto che Saverio pensò che fosse stato un errore rivelarsi così bruscamente. L’uomo rimase allibito, incerto, confuso. Poi, come se il serpentello del pensiero cominciasse a penetrare nel cervello, cominciò a sospirare, a tremare.
“Ma... Sì… Ma… Il mio giuramento … Il maestro… Lo aveva detto…” farfugliava e guardava Saverio, poi Alessandro, poi di nuovo Saverio. Infine lacrime e singhiozzi sgorgarono inarrestabili. Si ripiegò su se stesso, come per riprendere forza. Poi, rivolto ad Alessandro dichiarò “ Sia fatta la tua volontà! “ E non vi era dubbio che si rivolgesse al papa come terrestre rappresentante di Dio.
“Navi a poppa!!” L’urlo della vedetta interruppe il colloquio.
Saverio balzò all’esterno chiudendo la porta. Si trovò accanto al comandante che con il pilota scrutava il mare nella direzione proposta dal marinaio. Sull’orizzonte ormai placato, la nitida visibilità dell’aria fredda settentrionale consentiva di scorgere chiaramente il profilo di due navi avanzanti, quasi affiancate.
“Forse sono le nostre” Suggerì il comandante rivolto a Saverio. “Dobbiamo attendere che siano più vicine per capire… comunque prudenza… voi restate al riparo fino a conferma”.
Non dovettero attendere molto. La schiuma, che ormai si intravvedeva ai lati delle prore, indicava che oltre alla vela c’era anche la spinta vigorosa dei remi. I colori della tela e la sagoma originale dichiaravano la loro origine: si trattava di due delle navi di scorta.
La galea papale lascò la vela. Ormai le insegne identificative non lasciavano dubbi. Inutile proseguire la corsa. Si concordò di strambare ed invertire la rotta verso le navi inseguitrici che ben presto furono a portata di voce. Allora si seppe che la burrasca aveva preteso un terribile obolo. Affiancati ad una di esse, con una manovra resa agevole dal mare ritornato amico, vennero a sapere che una galea si era rovesciata durante la tempesta. Pochi naufraghi superstiti erano stati raccolti da quella che navigava più vicino e che ora si dirigeva lentamente verso Zara con gravi feriti. Loro si erano lanciati alla ricerca dell’ammiraglia nella speranza, ora confermata, che si fosse salvata. Anche tra i loro equipaggi vi erano feriti. Chiedevano di raggiungere rapidamente il porto.
“Non indugiate” Fu la laconica e risoluta risposta di Alessandro. Le galee normanne si rimisero in formazione e cominciarono a scivolare veloci sulla superficie del mare azzurro e collaborativo. Il vento del Nord si era ormai spento, in attesa della brezza quotidiana. La tavola marina sembrava suggerire che fosse impossibile quanto accaduto solo poche ore prima. I vogatori apprezzarono la clemenza e la galee poterono finalmente evidenziare con la velocità il significato della loro forma allungata.
Nel frattempo, venne congegnato il piano.
Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis (I poveri compagni d’armi di Cristo e del Tempio di Salomone), così erano nominati inizialmente i cavalieri templari, quelli a cui il naufrago aveva dichiarato di appartenere. Di loro vi era traccia fin dal 1118. Il loro nobile intento di difesa dei pellegrini in Terra Santa aveva trovato ruolo ufficiale nel 1129, quando con l’appoggio di Bernardo di Chiaravalle, fu stabilita la legge monastica. Il loro abito, caratterizzato dalla tunica bianca, con la tipica croce patente rossa, era ben conosciuto da Alessandro. Quando, giovane docente, insegnava diritto canonico a Bologna, aveva dovuto confrontarsi con alcuni studenti contestatori sul ruolo contradditorio di quei monaci guerrieri. Ma ora ciò che gli premeva, fin da quando aveva notato quella croce sugli abiti zuppi che Saverio aveva sfilato, era poter contare sull’estrema dedizione di quei monaci. Saverio aveva notato che la croce era identica a quella della fibbia segnata dal colpo di spada di Ottone. Gli era parso un ennesimo segno di quelle coincidenze che rendevano il papa un uomo dal destino speciale.
Alberto dei conti Canali da Nrezine, così aveva declinato il suo nome. Il suo perfetto latino evidenziava un’educazione nobiliare. L’inflessione un po’ strana della pronuncia era tuttavia compensata da una somiglianza davvero sorprendente della voce, anche nei toni calmi dell’eloquio. Lui e il papa, sembravano più che fratelli, due gemelli di diversa età. Un paradosso che con qualche stratagemma si sarebbe potuto facilmente correggere.
“Non solo perché mi avete salvato la vita – esordì Alberto – ma anche e soprattutto perché questo è l’evidente segno di Dio – aveva proseguito – io vi sarò fedele per sempre come vostro umile servitore. La mia fede ha avuto il segno che mancava – aveva voluto spiegare – Di ritorno dalla Terra Santa dove tutti i miei compagni e il mio maestro furono uccisi, credevo che la mia vita non avesse più senso. Solo il ricordo delle ultime parole del maestro: “come Cristo dovrai rinascere” mi tennero ancora in vita. La tempesta… quell’onda gigantesca .. mi parvero la medicina ai miei tormenti.. la morte sembrava dolce conforto.. poi la vostra corda e quell’ostinazione nel farmi riemergere dal gelo della tomba… Infine il vostro volto, Santità, fu il suggello al segno della Provvidenza. La vita mi è stata ridonata con uno scopo preciso.”
Gli occhi brillavano nel pronunciare queste parole e Saverio capì che nulla avrebbe distolto quell’uomo dalla sua missione. I suoi compagni sopravvissuti erano in realtà due semplici marinai greci della piccola imbarcazione da carico affondata. Non lo conoscevano né l’avevano più rivisto dopo il naufragio. La sostituzione poteva dunque funzionare.
Perché questo era il progetto che Saverio ed Alessandro avevano subito congegnato simultaneamente, senza bisogno di parole. Grandi erano i rischi cui il papa si stava esponendo, nel quasi impossibile tentativo di arginare l’aggressività del Barbarossa e riaffermare il suo primato.
Doveva contemporaneamente conservare l’appoggio dei Comuni insorti contro l’imperatore, senza inimicarsi i normanni del regno di Sicilia che lo stavano difendendo. E che dire di Bisanzio e dell’altro imperatore, ancora risentiti dell’alleanza che Venezia aveva stretto nell’assedio fallito ad Ancona? Quella Venezia che Alessandro intendeva raggiungere per farne, nel suo piano di pace, la sede naturale della complessa trattativa. Tutti avrebbero potuto guadagnare qualcosa forse, ma certo tutti avrebbero di sicuro dovuto rinunciare a molti vantaggi conquistati. Molti buoni motivi, dunque, perché Alessandro avesse un incidente di percorso che evitasse in modo definitivo tale prospettiva.
Anticipare i tempi. Giocare la regia degli avvenimenti dietro le quinte, senza il rischio di subire incontrollabili vendette. Aspettare tranquillo le mosse degli altri. Non cedere alle lusinghe, restare saldo nei principi. Tutto era più facile nascosto in quell’abito grezzo di pellegrino mentre il suo doppio a Zara svolgeva inappuntabile i suoi doveri.
La folla al porto lo aveva accolto con gran clamore. Nessuno si stupì delle fasce che avvolgevano il collo del finto papa, perché la notizia della violenta tempesta era già stata annunciata dalla galea che li aveva preceduti. Valerio ed Alessandro erano sgusciati via tra la folla con i loro abiti sdruciti.
Ormai la scelta era fatta ed i rimpianti erano frenati dalle evidenti conferme. Il piano funzionava, Alberto sembrava in grado di reggere a lungo la parte, la sua cultura e la totale dedizione erano sicura garanzia. Anche i monaci addetti alla cura del papa avevano giurato totale fedeltà. Le uscite ufficiali sarebbero state limitate fino a completa guarigione dell’anziano papa, provato dalle terribili traversie del viaggio. Inoltre Alberto aveva indicato il nome di chi lo attendeva a Zara. Angelo Zoccolo dell’isola di Olivolo, un mercante veneziano complice segreto dei cavalieri templari, li aveva imbarcati assieme ad altri pellegrini, portandoli a Venezia.
A quei tempi dalle incerte e mutevoli alleanze era preferibile la clandestinità. Un tacito accordo con le autorità veneziane consentiva reciproci interessi. Il porto lagunare era la sede naturale di partenza per la Terra Santa. I cavalieri, spesso di alto lignaggio, erano non solo magnifici combattenti, ma anche ottimi pagatori. Una delle qualità da sempre preferite dai veneziani. Dunque, purchè tutto avvenisse nel silenzio dell’ufficialità, non si erano create difficoltà alla creazione di una base di partenza verso Gerusalemme.
“Presto, presto… è ora di andare… Presto…” Dal fondo della calle dietro al sottoportego, sulla riva del canale interno, la voce bisbigliata, ma decisa di Angelo scosse Saverio dai suoi pensieri.
In un attimo fu in piedi, scoprendo che la posizione rannicchiata lasciava pungenti ricordi alle articolazioni. Fu dunque sorpreso di vedere che Alessandro era stato quasi più rapido ed ora si aggrappava al suo braccio, sussurrando: ”Altre volte ho dormito meglio…ma non così sicuro.. qui eravamo protetti dalla Madonna”.
Il luogo era stato suggerito da Angelo per la vicinanza al canale ed anche perché abitualmente utilizzato dai pellegrini più poveri quando venivano ad omaggiare le spoglie del Santo Evangelista. Poco lontano era la sede segreta dei templari.
La barca che li attendeva era colma di sacchi e ceste. Angelo era stato presto al mercato per coprire quel trasporto. Magro, agile, esperto e deciso dava un senso di sicurezza e non dimostrava l’età avanzata. Li aiutò a salire e li sistemò tra l’esiguo spazio che aveva creato tra i sacchi e le ceste. Il figlio Marco, un uomo atletico e vigoroso, reggeva il remo di prua. Comunicarono a gesti nel silenzio ancora imperante del primo mattino. Fu stesa una tela sotto la quale divennero quasi invisibili, confusi tra la merce. Padre e figlio in un attimo conclusero la manovra e cominciarono a scivolare lungo lo stretto canale.
Una curva nel silenzio dell’alba inoltrata, poi di nuovo un angolo del palazzo incombente. I remi spingevano sicuri, quasi senza far rumore e la barca dopo una breve accelerazione, sembrava procedere quasi in discesa.
Scivolavano verso in Canal Grande che si aprì all’improvviso, dopo l’ultima curva. Saverio si sentì quasi scoperto in quel grande spazio spettacolare. Non erano più protetti dalle pareti di palazzi e lo spazio così ampio esplose alla vista. Ma non c’era motivo di temere. La grande via d’acqua era ancora quasi deserta, solo poche imbarcazioni incrociavano in direzione opposta.
Chi mai avrebbe potuto immaginare che tra quei sacchi di grano e le ceste di verdura e frutta si nascondeva una delle personalità più importanti del Medio Evo? La fonte stessa del potere, colui che poteva elargire la patente di autorità e con essa la forza di imposizione su tutti i principi della terra. Molti lo avrebbero voluto morto e sostituito da qualche altro più malleabile. Perché quel vecchio saggio non cedeva, anzi, con astuta e sagace determinazione, giocava le sue carte. Sembrava quasi si divertisse, pensò Valerio, e gli invidiò la fede che lo sosteneva anche nei momenti più duri, stimolando una forza anche fisica sorprendente.
“Ohee!!” L’urlo sommesso di Marco si sincerò che dietro la curva il canale fosse libero. Stavano di nuovo abbandonando il Canal Grande inoltrandosi in una stretta deviazione laterale. Dopo qualche centinaio di metri, accostarono a riva e si ormeggiarono.
“Dovete scendere qui – annunciò Angelo – proseguite poi lungo quella calle… Più avanti troverete un ponte, attraversatelo e continuate finché arrivate al convento della Carità. Non potete sbagliare.. troverete altri pellegrini che aspettano davanti al portone.”
Alessandro e Saverio abbandonarono in fretta la barca, aiutati da Marco che offrì al più anziano un bastone caratteristico ed efficace. “Io vi precederò in barca – proseguì Angelo – il monaco portiere è un amico.. molto sensibile alle mie donazioni… tutto questo è per il convento – aggiunse indicando la barca – ma la fiasca è solo per lui. Farò in modo che vi faccia entrare per primi. Presto, andate.”
Così dicendo fece segno al figlio di sciogliere la cima dal piccolo albero dov’era fissata. Subito si scostarono arretrando a spinta nello stretto canale aiutati dalla corrente.
I due finti pellegrini li seguirono con lo sguardo finché la barca scomparve come ingoiata dalla grande luce che si intravvedeva in fondo. Si misero in cammino. La stanchezza ed il disagio della notte trascorsa all’addiaccio uniti all’età ed agli abiti miserevoli, davano ad entrambi l’immagine indubitabile di pellegrini.
Trovarono conferma davanti al portone del convento, popolato da altri fratelli in tutto simili a loro. Alcuni giacevano a terra, altri cominciavano a muoversi affamati. Saverio notò più di una coppia come loro. Un vecchio aiutato da uno più giovane.
“Ehi, voi!!” Si girarono e videro Marco che si stava avvicinando “Il priore ha bisogno del vostro aiuto – aggiunse in modo stentoreo cosicché tutti potessero sentirlo – servono le vostre erbe mediche per un fratello… - aggiunse prendendo il vecchio per un braccio – presto, fatevi aiutare da vostro figlio..”
Avanzarono superando la fila di chi era in attesa che lentamente si scostavano al passaggio, poco convinti, ma forse solo stupiti e troppo fragili per protestare. Attraversarono il portone che subito si richiuse, accolti dal monaco portiere, stranamente sorridente di buon mattino. Incrociarono lo sguardo sornione di Angelo che ancora stava sistemando i sacchi nel piccolo carro.
“State qui alla mensa. Tra breve daremo qualcosa di caldo a tutti. Poi vedremo come sistemarvi. Per voi ci sarà qualcosa da fare nell’orto – disse a Valerio valutando la prestanza – e per voi … vedremo.. forse in cucina o a alle pulizie…”
“Stiamo andando alla barca… - annunciò Angelo – Non dimenticare che tornerò domani… E se Dio vorrà…”
“Oh Dio vorrà, vorrà… Dio vuole sempre il bene dei suoi figli generosi..” Rassicurò il monaco ben disposto.
Alessandro e Valerio attraversarono il breve corridoio che portava alla mensa e finalmente sedettero comodi su una panca. Il rifugio era finalmente sicuro.
Chi volesse conferma storica di quanto descritto (escluso l’incontro col naufrago noto solo all’autore) può recarsi a S.Aponal, dove una chiara iscrizione, sull’architrave ligneo del sotoportego de la Madona, ricorda la notte trascorsa dal papa Alessandro III°, in veste di incognito pellegrino. Riconosciuto da un frate qualche mese dopo, il papa sarà ospitato con grandi onori dal doge e concluderà la pace con l’imperatore Barbarossa, cui tolse la scomunica. In cambio Venezia otterrà l’indulgenza perpetua per coloro che, concludendo il percorso di penitenza (Calle del Perdon), recitavano un Padre Nostro e un Ave Maria davanti all’altare della Madonna, situato sotto il sottoportico.

