Bruno Pasetto
LAGUNANDO 2020 > selezionati 2020
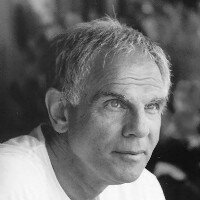
Architetto, professore in pensione con passione per la scrittura e la lettura.
il gran segreto
è vintage d’autunno tra il doratoche pacifica il respiro della campagnae chiama un’orchestrina di arco e violapescando musica dal fiumeal punto che le ragazze estasiatedanzano affrancando la loro leggiadriae i fanciulli le mimano stupefatti di emozionetutt’intorno una grigia bruma avvolge la terraimpregnando le spighe mozzeche ne fanno un campo di battagliaper chi le guarda dal tavolo parcodi vino degno e amicizia salda,lì dove con parole di umiltà e decoroil primo tenta di far uscire la verità dall’altrosposta il fornello dalla bocca che sputa fumorimanendo a mezz’aria con la pipa in mano,_ penso alla mia Nina quanto era bella,e morta lo è da un pezzo lasciandomi patiredi un sospetto che mi porto appresso _e torna al mezzo pieno del bicchierecon la metà perduta dell’amore vero_ le ali non ci appartengono ma abbiamo ideeche a volte ci portano a fare dei voli strani,proprio volessimo provare da soli a farci del male _risponde il compagno a quel turbamentoper lasciare in cielo la volontà del segretoe andare al mezzo vuoto del bicchierecon la metà perduta dell’antico eros
Hauser-Albinoni adagio
il volto tesole sudate gocce bagnanoche una manoil crine dell’archetto guidae l’altra con le falangile quattro corde mordeavendo per amoreil sensuale adagioevoca il solistagli spiriti della sua Croaziafacendo biauraletra pietre il suonoin compagnia d’altri musicie dita tentacolari al pianotanto a danzare il numestanno i bei ricordicon gli occhi chiusiche lo strumento cullae sono madriche hanno voluto i figliperché fossero oracon la propria guanciasullo stesso senoche ebbero fonte di vitaStjepan è passionevirtuosismo ed estasidavanti al saporedella bellezza slavadi giovani donne innamoratenell’arena di Pulaper sentire il dio del violoncellodallo sguardo struggentementre gli sposi sciocchiimprecano dentro taverneebbri di albagia tra carte e vinoma c’è nell’orchestrauna viola pizzicatada polpastrelli in fioretirata a vantareuno sguardo personell’età di quandoogni illusione è stellaio credo che divinoe promessa si cerchinocome fanno silenzio e musicadove il pathosè architettura e il suo spaziolibera tutto l’anelitodell’unica almaperché la vita è unae i sogni tutta e nessuna
opera compiuta
se penso a mio padrevado in direzione del mare,metto i piedi sulla sabbiastriata dal ventoin cerca della sua ormache ha la mia etàe provo testimonianza d’amorein un volo, non della velache all’orizzonte disegnal’argonauta del cui destinonon ho certezza,ma una migrazione aligerache mi conferma la logicasulla esistenza di due nididistinti nel tempoe agli opposti nel luogo,da convincermici sia nel librarsi in arial’agognato legameche sento tra le nostre vite,ancorché una vissutae l’altra perdutae che se così non fossecome spiegarmi allorala traccia spiritualedella pietas congiuntache il tutto rivendicadopo l’ora del trapasso?il guardare oltrediventa una visione,rifulge il cammino parallelomentre sto al confinetra terra e acquae colgo stupefattol’eternità dell’incontrocon la stessa sensibilitàe commozione che avvertoquando giungo all’apprododella compiutezza di un’opera d’arte
Le due sorelle
Antefatto
Piero si era imposto di avere rispetto per gli animali e la natura, dopo averlo perduto per il genere umano. Aveva deciso di continuare a esistere cercando di dimenticare il dramma della guerra vissuta. Se non ci fosse riuscito sarebbe diventato come un tronco d’albero abbattuto, legno utile a uno scultore capace di affrancarne l’anima nascosta dentro. Il nostro uomo, che non avrebbe mai potuto essere trasformato in una forma statuaria, a quel punto sarebbe stato costretto a liberarsi della sua croce soltanto urlando tutto il proprio dolore.
Tornato a Plodn dal lager di San Sabba nel maggio del 1945, dopo qualche anno di assenza, si era ritrovato a essere padre di una figlia che al momento della partenza non aveva. Fatti due conti per quanto approssimativi, la giovanissima età della bimba non poteva nascondere una verità inconfutabile quanto sgradita. Del resto lo sguardo abbassato e contrito della sua compagna fu già una risposta chiara. I parenti stretti non parlarono e a lui parve tempo perso chiedere delle spiegazioni. Pensava che fosse l’ultima tragedia da dover sopportare, non peggiore ma nemmeno tanto migliore delle persone uccise, della tremenda prigionia, della fame sofferta, della serenità perduta.
Per una sorta di rappresaglia dopo la cocente novità di casa, inattesa e indigesta, sua moglie non aveva più avuto un nome. Così la chiamava usando in senso spregiativo la parola dialettale femena.
Nei primi giorni, stordito e confuso, aveva sorriso amaramente tra sé dell’impensabile sorpresa che festeggiava il suo ritorno, ironizzando per la ciliegina sulla torta, per il chi non muore paga pegno, oppure per il chi va dall’osto perde il posto. Poi ai facili aforismi erano subentrati sentimenti tristi e avvilenti, già difficili da dominare per chiunque ma ancora peggio per lui, che si portava appresso l’aggravio delle allucinanti esperienze patite prima da soldato e poi da recluso.
Riprese il lavoro di mandriano, con le mucche che stimò più generose e pazienti di qualsiasi donna e con i cani che amò per conservare nell’animo l’idea della fedeltà.
Scansò il prete per i santi principi che proclamava tacendo, obbligato dal vincolo confessionale, la verità che lo riguardava. Entrava in chiesa quand’era vuota a specchiarsi nel crocifisso, cercando nel confronto di riconoscere, rispetto al Cristo, la pochezza della sua personale umiliazione. Quando passava dalla Borgata Mulhbach si consolava al pensiero che non gli sarebbe servito salire da penitente l’erta che conduceva in progressione alle quattordici stazioni sacre. Al Golgota era già salito da tempo e la sua via Crucis era tutta l’esistenza vissuta, strada ancora presente nella quotidianità con il peso insopportabile di quanto aveva dovuto vedere e subire specialmente da relegato a Trieste.
Per strada e nelle osterie ringhiava e fiutava tra la gente che apposta faceva di tutto per evitarlo. I paesani convenivano che avesse contratto, come fosse stata una malattia, la scontrosità delle bestie bovare e il selvatico dei predatori del bosco. Piero era convinto che tutti sapessero cosa e chi cercasse, perciò lo tollerassero semplicemente tacendo, che per i valligiani è sempre rimasta una forma dovuta di riguardo per le disgrazie del prossimo.
Per molto tempo Gina, la figlia non sua, fu una spina nel fianco. Il montanaro sappadino faticava a considerarla innocente, parimenti sventurata, destinata a tenere aperta la peggiore delle ferite non sanguinanti per un uomo tornato vivo dalla guerra e dalla prigionia. L’ostinazione di lei a cercarlo pareggiava la sua nell’evitarla. Li accomunava il silenzio, figlio della colpa che paradossalmente non avevano, ma erano costretti a penare al posto d’altri.
Rosa, la figlia legittima, non era ancora nata mentre lui cercava di lenire la rabbia per la piccola bastarda e viveva ossessionato dalla volontà del proprio riscatto virile.
La sua frequentazione in famiglia era ridotta allo stretto indispensabile.
Verso la fine del mese di ogni maggio era obbligato alla salita in alta quota. L’alpeggio, di proprietà regoliera, si trovava nella Val d’Olbe con la possibilità di utilizzare una vecchia baita di sassi per il deposito e il ricovero personale. Il periodo di assenza da casa si prolungava fino a settembre inoltrato e terminava con la demonticazione, cioè con la ridiscesa nella più ospitale vallata di Plodn. Per il resto delle stagioni la cura delle bestie continuava nella capiente stalla vicina al corso del Piave, poco distante dal maso di cui era proprietario.
Il lavoro faticoso, pressoché a tempo pieno per tutto l’anno, gli consentiva di sorvolare sui travagli vissuti. Ma certi brutti pensieri stavano incollati al suo cervello come i peli alla pelle e le spine al rovo, pronti a suscitargli reazioni dolorose se sollecitati volutamente o magari per caso.
Durante il giorno, occupato e in continuo movimento, aveva modo di tenere a bada soprattutto i brutti ricordi dell’internamento. Non poteva invece evitare gli spiriti malevoli che a volte, nel sonno profondo, lo attendevano come dei rapaci incalliti, pronti a richiamare quanto la sua mente non avrebbe mai potuto rimuovere in maniera definitiva.
Gli successe anche in una notte d’inverno, la prima volta che s’era ritrovato a dormire da solo nella camera matrimoniale. In quel periodo sua moglie, per poter essere assistita a causa della gravidanza complicata, si era trasferita dai propri genitori.
La cena con Gina, che aveva da poco compiuto sei anni, era iniziata e finita nell’usuale clima laconico e distaccato.
C’era stato però un momento in cui lo sguardo interrogativo della bimba, puntando diritto al volto del padre, l’aveva messo in soggezione. Turbato, lui aveva cominciato a sentirsi addosso altri occhi, decine di occhi inquisitori che lo guardavano. Poi aveva rivisto gli stessi suoi atterriti al tempo della cattura, supplichevoli verso un kapò che doveva operare in fretta una scelta. I disertori italiani erano stati raggruppati nel poligono di tiro di Villa Opicina, dopo giorni di continui rastrellamenti nei territori del Friuli e dell’Istria. Quella specie di comandante aguzzino doveva indicare uno soltanto tra i prigionieri presenti. Piero non capiva il motivo, ma la discreta conoscenza della lingua tedesca gli aveva permesso di tradurre quanto reclamavano i tre soldati del Terzo Reich appena giunti con una camionetta. Fu additato dal kapò e si rivestì presto avendo avuto la consapevolezza d’essere stato graziato. Ma il giorno seguente, quando rivide i commilitoni che erano rimasti spogli e attoniti mentre lui saliva sull’auto militare e spariva, provò un profondo disprezzo per se stesso. Con pochi altri avrebbe dovuto scaricare quei corpi gelidi e crivellati, carcasse umane spaventosamente scomposte, dal pianale del camion che li conteneva ammassati come volgare carne da macello. All’interno della risiera di San Sabba, fatalmente, il destino aveva provveduto a riunire l’unico rimasto vivo ai morti brutalmente uccisi a colpi di mitra.
Così, agitato e indifeso, Piero non rispose allo sguardo della bambina rimasta a guardarlo. Al momento vedeva soltanto occhi sbarrati e atterriti, incollati sulle sue spalle mentre si allontanava dal campo di sterminio. Si portava dentro la colpa atroce per l’imperdonabile vigliaccata. Sentiva ancora insanabile un dolore lancinante per averli abbandonati, con l’unico pensiero di salvarsi la vita.
Di notte, soffrendo l’orribile ricordo, stentò il sonno, ma infine dovette cedere alla stanchezza. Perciò non fu più in grado di guidare le sue emozioni che, incontrollate, si trasformarono nell’ennesimo incubo, nella rivisitazione dell’indelebile accadimento avvenuto il giorno successivo alla strage perpetrata.
_ La scala stretta e buia, impregnata di un odore nauseabondo, scende metallica fino al piano interrato. Laggiù la porta del forno crematorio è aperta per ricevere un indicibile carico di efferatezza e follia. Come quello degli altri trasportati a mano, il viso di un cadavere lo sfiora, costretto com’è a sostenerne il corpo tenendolo dalla parte della schiena. Il prigioniero che lo aiuta ne regge le gambe. Piero sente di avere il cervello svuotato e sconvolto alla pari dello stomaco. Non è in grado di pensare a niente né di vomitare qualcosa. Nemmeno può confidare in una soluzione alla continuità del suo stordimento e di conati ugualmente lancinanti. Però è in grado di percepire un impossibile tepore al contatto del suo braccio con la bocca del morto. Forse proprio per questo motivo, dopo l’ultimo gradino, le ginocchia gli cedono raccogliendo il volto emaciato dell’uomo e un rantolo appena percettibile che proviene da quelle labbra scure e tumefatte. S’accorge che è ancora vivo e lo grida a forza senza ritegno, non realizzando di sprecare soltanto del fiato. Urla più volte convinto di poterlo salvare. Volge i suoi occhi, ancora supplicanti, verso le guardie tedesche che invece, puntandogli le pistole contro, lo inducono terrorizzato a tapparsi la bocca con tutte le dita.
In un attimo dalle mani di uno dei militari spunta una mazza di ferro che va ad appoggiarsi al corpo di Piero e un’arma, che invece si accosta con la canna alla sua nuca. Il tutto succede nel silenzio più assoluto e con un unico comando essenziale, che suona gelido e rimbomba come il rintocco una campana a morto: schnell!
Sa bene di non avere scelta e ancora una volta decide di sopravvivere. Lo fa da meschino, tremante, macchiandosi nuovamente di codardia e ferendosi con la propria ira. Chiude gli occhi allo scempio che sta per perpetrare e, sollevata di peso la possente clava di metallo con entrambe le mani, la lascia cadere pesantemente dall’alto. Uccide un uomo moribondo e lo fa esercitando il più primitivo e barbaro degli atti distruttivi verso un proprio simile. Il fendente squarcia il corpo e il fragore si tramuta in frammenti di sangue e viscere che rimbalzano impazziti contro il muro maestro. _
Che adesso da sveglio non è più la parete del lager. Ma lui, stravolto dal massacro appena reiterato in sogno, non riesce a distinguerla.
Al tempo della permanenza nella risiera di San Sabba i suoi occhi avrebbero registrato in continuazione scene altrettanto raccapriccianti. Perciò era stato costretto a erigere dentro di sé argini di contenimento sempre più alti contro gli orrori che venivano commessi in quel posto. Per poter resistere aveva confidato nel dono dell’oblio, in una provvidenziale e totale dimenticanza attraverso l’annientamento progressivo del proprio spirito e del proprio intelletto. Così non era stato e, ancora dopo la liberazione, tutto lo strazio accumulato era rimasto chiuso dentro un perverso tormento interiore. Che infine quella notte era straripato di lacrime e urla irreprimibili.
Gina, spaventatissima, era corsa dalla camera vicina a gridare papà! papà ci sono io, voglio aiutarti, ripetendo le parole fino allo spasimo, senza che la mente sconvolta di Piero potesse udirla. Poi si era rintanata in un angolo della stanza, rimanendo accovacciata in compagnia di un flebile pianto di paura, che aveva preso la cadenza monotona di una triste nenia cantilenante. Sembrava volesse cullare con la sua voce il dolore inconsolabile dell’uomo.
Lì rimase immobile, paralizzata, impedita, fino a quando l’impeto dello sfogo di suo padre sembrò affievolirsi. Le palpebre abbassate di Piero ritornarono con fatica a essere aperte e la sua testa riprese coscienza.
Soltanto allora la bambina decise di avvicinarsi anche se lui era ancora ansimante, con il viso alterato e gli occhi spiritati. Eppure vedendola ai piedi del letto rimase come incantato da un’epifania.
Sbalordito dalla presenza di Gina, che aveva recuperato calma e compostezza, si mise a fissarla come avesse visto un angelo sceso dal cielo. Si risollevò pur sapendo che non avrebbe mai raggiunto la completa amnesia del trascorso patito.
Comprese che era il momento di iniziare a uscire dal suo pesantissimo lutto e dal conseguente isolamento deleterio. Gli sarebbe occorsa molta volontà, il tempo necessario e magari l’aiuto di qualcuno. Ci avrebbe provato. Sentiva rinascere nell’animo un sentimento di trasporto amorevole, che comprendeva non soltanto l’indifesa creatura che aveva di fronte, ma tutta l’umanità respinta e soprattutto se stesso. Aveva la sensazione di poter recuperare la fiducia e la speranza nel prossimo, di riprendersi tutto ciò che il destino avverso gli aveva tolto in maniera tanto ingiusta e violenta.
Mentre rifletteva, insperato e provvido come un bellissimo dono immeritato, si sentì accarezzare la mano, irraggiungibile e schiva né mai toccata prima dalla piccola. Lei continuò premurosa finché l’uomo, a rassicurarla del suo stato, volle stringere delicatamente in pugno con le proprie quelle piccole dita, ricambiando la cura e l’affetto che stava ricevendo.
Il loro silenzio continuò comprensivo e solidale, nel modo che fino al giorno prima sarebbe stato impensabile a entrambi. Per ultimo avvenne il miracolo. I due, senza dirselo com’erano usi, decisero per la prima volta di farsi compagnia per davvero.
Accostarono le loro solitudini riconoscendosi e proteggendosi a vicenda con le mani congiunte.
cronaca
_ Ho un unico scopo, conoscere la ragione per cui ho perduto il mio corpo.
Non ho il conforto della luce celeste e vago sul pensiero di ciò che non ho potuto essere. Non sono più materia, che so essere stata per un tempo limitato. Sono l’opposto della vita che avevo, ma rimango in una condizione di attesa, convinta che infine avrò la consapevolezza di cosa mi è successo.
Anche domani lo aspetterò. Ogni volta che passa, e sfiora il vaso di fiori freschi addossato al mio loculo, ne sento l’indispensabile presenza. La definirei vitale per me se non fosse un paradosso pensarlo, dal momento che io non esisto più. Per quell’uomo avverto una sorta di empatia e credo che il suo possa coincidere con il mio interesse. Quasi che entrambi avessimo necessità, per motivi diversi, dello stesso sapere. Di sicuro ha una qualità che quanti scorrono davanti alla mia urna non possiedono. E’ come se, attraverso una competenza che io non posseggo ma che lui conosce bene, potesse spiegarmi cosa non sono in grado di ricordare.
Sono sollevata dal fatto che l’ultima volta ha sostato qui, davanti alla mia fotografia. Ho percepito il suo sguardo manifesto, soprattutto di una compassione lieve, senza afflizione. Mi è parso che, intuendolo, volesse dichiarare e concedermi l’aiuto di cui ho bisogno. _
Passo dove il mio spirito si sente libero, in un luogo che in realtà mi è estraneo. All’inizio sono entrato per caso, in un giorno non sapendo che fare.
Da molti anni d’estate staziono tra le montagne del Cadore e da una settimana frequento il piccolo cimitero limitrofo alla chiesa di Plodn, come dovessi rispondere a un indefinito richiamo nell’aria. Flebile all’inizio e poi, nei giorni successivi, divenuto sempre più convinto. L’ultima volta ho creduto di sentirmi spiato e all’improvviso un mulinello di vento è sembrato investirmi apposta, bloccandomi. Mi trovavo a fianco del colombario funebre. Girandomi ero stato attratto dal volto di una ragazza, talmente vivido da stupirmi a vederlo in effige sulla lapide di pietra grigia. Lo sguardo, povero e interrogativo, nulla toglieva alla bellezza degli occhi perlacei e dei lineamenti morbidi e delicati, che lei pareva non ostentare. I capelli lisci erano di un rosso ramato, lucente. L’ovale serico di porcellana, che conteneva il ritratto fotografico, contribuiva a conferire al viso un giusto amalgama di nobiltà e mistero. Al momento non mi feci alcuna domanda, ma allontanandomi ebbi la sensazione che quello fosse stato un incontro previsto. Soltanto sulla via del ritorno ricordai di non aver letto un nome, non una parola incisa, né una data sulla lastra tombale così stranamente anonima.
La pioggia torrenziale di oggi sembra essere l’unica risposta al silenzio che mi alberga dentro, ancora maggiore della solitudine a cui le intemperie mi costringono. L’acqua che imperversa è comunque un regalo della natura. Per me lo è da sempre. Mi predispone a raccogliere i pensieri per farne produzione scritta. A volte mi sollecita a convenevoli inviti, altre ai piaceri della tavola. Comunque mi induce sempre ad ammirare l’inverosimile cambiamento in plumbeo del panorama sulla vallata, così martoriata dalla tempesta.
Infine devo uscire per la stanchezza dello stare in casa. Prendo la via che conduce alla borgata di Muhlbach, appesantito dal maltempo e dall’uggia conseguente. Più avanti mi viene incontro una donna cadorina con la faccia coperta, che provvede a redarguirmi d’essere in strada. Non le rispondo, non avendo voglia e nessuna ragione per farlo. Scendo verso il ponte di legno, per risalire al centro di Plodn. Lì, dentro un bar, immagino già di avere il conforto di una fetta di strudel e del buon cappuccino caldo.
D’improvviso, allo scroscio sento replicare il rintocco di una campanella che cala il suo richiamo dal cielo. Mi fermo. Ho l’impressione che tintinni proprio per farsi sentire, come volesse avvertire di qualcosa che devo sapere. Pare un lamento pietoso, perciò mi lascio attirare da dove quel suono proviene. Scende dal vicino percorso in salita che qui chiamano per l’appunto il Calvario.
Sono quattordici le stazioni di tale via Crucis che non ho mai voluto percorrere. Credo di non aver nulla di cui fare ammenda, da dover affrontare questa erta di penitenza cristiana. E’ però destino che oggi la debba scalare, senza un vero motivo e nelle condizioni meteorologiche peggiori.
Non ho fretta di salire. Penso alla fatica e a una breve sosta in ogni stazione che incontro. Le immagini dentro le piccole edicole mi coinvolgono nel vedere la Vergine Madre così sofferente, ancor più del patimento del figlio diletto.
Ho il ricordo di una Madonna di gesso bianco sulla mensola della cucina e di mia mamma spaventata e commossa che prega, in ginocchio e con le granelle del rosario consunte, convinta del miracolo che verrà dalla sua fede incrollabile. Mi aveva atteso in casa mentre fuori diluviava e io bambino ero chissà dove in mezzo alla montagna. Già a quel tempo mi perdevo da solo.
In cima alla salita c’è una chiesuola. Appena fuori del portone vedo piantate nel terreno tre enormi croci del Golgota, statue di legno rimaste affiancate dovunque dal tempo della storia evangelica. Le guardo, ma non ho più occhi per le sculture appena scorgo calda una debole luce, che dall’interno del piccolo tempio mi invita a entrare.
Vado a sedermi sulla panca davanti l’altare, gocciolando sul cotto del pavimento. Il rumore sordo della pioggia, e i boati nel cielo, aprono il mio cuore di adulto alle paure infantili e agli affetti perduti. Questa condizione solitaria li reclama improvvisamente dalla memoria e allora le immagini scorrono sotto le mie palpebre che, come valve cutanee, si abbassano per proteggerle. Così, esausto e confuso, dormo subito sui sogni dell’infanzia che ho vissuto insieme a mia madre.
Due mani mi sfiorano le spalle, giro il viso per capire cosa succede. Mi vedo sullo specchio degli occhiali di chi mi sta guardando. Ho un’espressione stupita sulla faccia già ebete dallo sforzo, ancora umettata e aggrottata dalla sorpresa. La donna abbassa le lenti e si mette a sedere vicino a me.
“Mi chiamo Gina. L’ho seguita per parlarle, per favore vorrei che mi ascoltasse. So che lei è uno scrittore e ho anche letto un paio dei suoi libri”.
Non le rispondo, ma lo fa il mio sguardo e un lieve gesto d’assenso del capo.
“Ho perduto la sorella che avevo, tragicamente. Sono passati degli anni e dopo la morte recente di mio marito ho deciso di lasciare Plodn. Penso proprio per sempre. Porto con me una storia molto triste e una lettera che vorrei leggesse. Contiene un segreto e non credo di riuscire a scoprirlo con le sole mie forze. Se può, le chiedo di aiutarmi”.
Mi porge una busta chiusa senza nessuna indicazione scritta. Si alza per andarsene e, quando si rimette gli occhiali e il cappuccio della giacca a vento, rammento di averla incontrata per strada prima di affrontare il Calvario.
Confesso la curiosità di leggere la lettera eppure ho atteso, contenendola fino a stasera che la pioggia si è spenta all’ora di cena.
Gina, sorella carissima.
Tutto l’affetto che ci unisce non mi basta a evitarti un altro grande dolore. L’ultimo.
E’ evidente che il bambino l’avevo già concepito prima del pomeriggio maledetto, quindi non è frutto della successiva violenza. L’ho avuto con un gesto d’amore vero e consapevole, che comunque Dio non potrà perdonarmi. Nonostante, come sai, penso d’aver espiato a sufficienza la mia colpa con quanto ho subito, giusto un mese dopo quel fatidico giorno.
Del padre conosco il nome, Thomas, e la sua condizione di diacono a Treviso.
Ho patito soprattutto il suo silenzio o il rifiuto, magari entrambi. Non posso sapere se voluti da lui o imposti da altri, quando le mie lettere sono tornate indietro con la dicitura sconosciuto al mittente.
Spero che almeno tu possa comprendere la mia scelta. Per gli altri della nostra famiglia so che ciò sarà impossibile. Esco e vado a raggiungere l’Orrido dell’Acquatona.
Sono al corrente dello spaventoso salto dell’acqua, poco distante dal paese. Oggi provo una pena profonda per quella ragazza disperata, che ha scelto il volo nel vuoto al giudizio della gente e anche al loro compatimento. Penso alla brutalità ricevuta, a Thomas e alla sua assenza che sono l’arcano da scoprire e torturano l’anima della sorella viva. Enigma che si aggiunge ai secolari segreti dei sappadini, addestrati a tacere di pesanti traversie fin dal tempo del loro insediamento tra questi monti. Uomini rimasti usi a non far trapelare gli eventi sventurati della propria storia più recente, compresi la barbarie di un atto violento, la nascita di un figlio naturale e la follia di un suicidio che pone fine a un grande dramma individuale. Tragedia che è stata sepolta, tacendola con rassegnazione nel collettivo dimenticatoio della splendida valle di Plodn.
Proseguo sulla strada oltre la chiesa di Santa Margherita, per andare nel posto che adesso conosco sotto una luce diversa. Non capisco in cerca di cosa.
Scendo lungo la ripida, scala precaria, rasentando l’acqua che si butta per raggiungere il fondo, crudo e gelido anfratto di pietre e di sassi. Qui sotto il mio raccoglimento è una pia vicinanza, un pensiero solidale, un’immagine della povera ragazza. Qui sotto avverto e soffro di una grave mancanza. Quella di non possedere il dono della preghiera. Rinuncio, che a proferirla ora come facevo da bambino mi metterebbe a disagio, mi metterebbe vergogna.
Alla fine decido di andarmene. Vado dalla parte opposta a quella della fiumana, che scende per continuare ad alimentare la portata del Piave glorioso. Torno indietro, confuso ma motivato se penso alla lettera diventata un lascito ineludibile non solo per Gina. Mi chiedo non tanto come lei abbia saputo del mio mestiere, né da dove le derivasse la certezza di coinvolgermi. Piuttosto mi fa specie la determinazione della donna a voler rompere il costume più vecchio di questi luoghi, che è l’atavico riserbo di Plodn per tutte le proprie sciagure.
Sul tramonto di una giornata difficile, il monte Siera che ho davanti altissimo è una sentinella sulla vallata, baluardo a difesa delle mie riflessioni, compagno con il quale dialogare in silenzio. Ancora non sono in grado di stabilire il fare del domani. Prima devo riordinare ogni parola del secondo incontro con la persona che aveva voluto seguirmi sulla via del Calvario.
Ero sulla strada di ritorno dall’Orrido dell’Acquatona. Non potevo fare a meno di fiancheggiare il cimitero, con la mente coinvolta dalla triste storia e con il pensiero fisso di fare mia l’intenzione di Gina. Né potevo sapere se sarei entrato nel piccolo giardino dei morti. In verità proprio la vista della donna che invece stava per farlo, per un momento, me l’aveva impedito. Avevo proseguito il cammino, poi stentato, senza capire se l’indecisione derivasse dal solito richiamo nell’aria o dall’idea che fosse utile, forse necessario, parlarle. Poi avevo scelto di seguirla, per notare che si era fermata proprio in prossimità del capiente colombario di lapidi grigie, presso il quale avevo sostato due giorni prima. Tratteneva con la mano sinistra dei fiori di campo e con l’altra stava facendosi il segno della croce. Senza il cappuccio del giorno precedente lasciava scoperta una folta criniera di capelli rossastri, ricci e scomposti. Gli occhi erano sempre nascosti da un paio di Ray-Ban da sole. Vedendomi arrivare non s’era scomposta, quasi fosse normale per lei il fatto che mi trovassi là. Ci eravamo stretti la mano, cordialmente. Poi lei aveva rivolto lo sguardo all’urna innominata.
“Mia sorella si chiamava Rosa e come vede era bellissima. Due giorni fa avevo notato che lei la stava osservando”.
“E’ vero, mi ero chiesto chi fosse e perché mancasse un nome e le date sulla sua lapide”.
“Da noi si continua a pensare che quando una persona uccide qualcuno, o si toglie la vita, sia immeritevole d’essere ricordata. Si preferisce credere che non fosse nemmeno esistita. Non scrivere il nome del peccatore è un’antica usanza delle nostre pievi che, per carità cristiana, permette comunque di apporre sulla stele marmorea l’effige dello sciagurato. Secondo l’intento, diviene un monito per gli uomini a non trasgredire al quinto dei comandamenti. E’ una consuetudine molto discutibile, ma purtroppo ancora praticata”.
“Ora capisco e me ne dispiaccio”.
“Abbiamo perfino la convinzione che l’omicida o il suicida subisca nell’aldilà l’oblio del crimine commesso, che non ne permette la redenzione. Come fosse imprigionato dal non ricordo, colpito da una condanna divina per l’atto violento perpetrato”.
Andare nel buio pesto della notte è voler affermare con coraggio la propria libertà. Perciò lo faccio ogni notte e questa, dopo un paio d’anni, ha un cielo talmente intarsiato di luci da riempirmi il cuore e gli occhi di una incommensurabile ebbrezza. Le montagne insuperabili vegliano sulla quiete della valle addormentata, mi indicano e avvicinano al Dio che mi manca più di cento preghiere.
Porto con me il libro che ho scritto e dei fiori screziati, seguendo il tragitto che conduce al camposanto di Plodn. Domani distribuirò questo romanzo suonando a ogni porta, perché gli abitanti possano leggerlo e avere un pensiero commosso al ricordo della fanciulla morta. E’ una loro figlia e non potrà essere riconosciuta soltanto per il suo bel volto anonimo. Quel volto rivendica un nome e due date vicine di una vita troppo presto conclusa. La liberazione della sua anima, che per la fede dei paesani sta nell’ascesa in cielo, le è preclusa soltanto perché costretta dalle ubbie delle loro paure ataviche.
Sono davanti al sepolcro disadorno. Lo è per la mancanza di Gina e per la dimenticanza di tutti. Eppure sento effondersi nell’aria il profumo dell’incenso sacrale di tutte le vegetazioni attorno, solidale concerto primario di erbe, cortecce, ortaggi, fioriture, terre, frutti, edere, foglie.
Con la lettura del mio libro, e il tempo, mi auguro che Rosa venga affrancata dalle vecchie superstizioni stantie del suo paese. Quel giorno, Plodn inciderà l’epigrafe che manca sulla sua lapide. Potrà prendere a prestito le parole che, nella brezza silenziosa di questa notte di pace, percepisco con un sussurro di giovane voce femminile sceso prodigiosamente dall’alto: adesso parlo con Dio tra le stelle.



