Piero Sesia 2022
LAGUNANDO 2022 > selezionati 2022

Laureato in Lettere, ora pensionato.
Collaboratore agenzia letteraria e partecipante gruppi di lettura.
Due libri editi:
Una valigia di perplessità -Ed. Tecniche 2019
Caro Celso, vinceremo -Ed. Araba Fenice 2022
SECONDO PREMIO

-Orti dei Dogi -
racconto
racconto
Ambientato
nelle cascine del vercellese a inizio '900, "Dinamite" deve
il titolo al nome di una giovane donna ed echeggia di guerra e di
contestazioni.
Le
protagoniste di questo racconto sono infatti le mondariso, le
mondine, che ad ogni primavera si spostano dalle campagne del
Piemonte e dell'Emilia Romagna, non senza qualche rivalità, per
lavorare nei campi allagati di riso.
Attraverso
uno stile asciutto e un ritmo serrato, il racconto ci fa toccare le
fatiche del lavoro, degli stenti, della fame e allo stesso tempo fa
echeggiare le emozioni e l'entusiasmo di queste lavoratrici
stagionali.
Apprezzabile
la ricostruzione storica che sa tenere di sottofondo la tensione
della guerra in corso, lo sfruttamento del lavoro, la povertà di
certe aree rurali e l'efficacia dei toni che all'occorrenza sanno
farsi leggeri.
Resta
in sottofondo per tutto il racconto, una nota costante di durezza e
violenza, ben riassunta dal titolo scelto dall'autore.
ORTI DEI DOGI
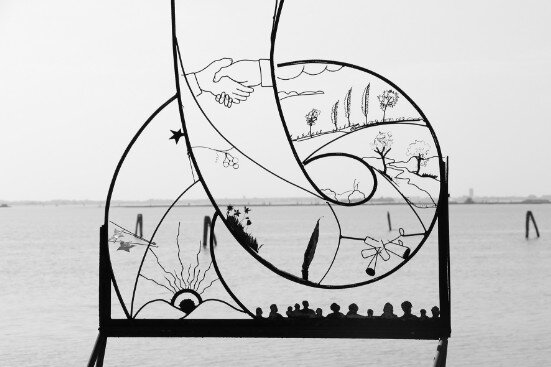
RACCONTI
DINAMITE
Che fossero povere disgraziate come noi e, per certi aspetti, molto più di noi, lo avevo capito quasi da subito, nonostante l’abituale, e quasi rituale, rissa di benvenuto alla stazione ferroviaria.
Succedeva infatti tutti gli anni che, all’arrivo del treno delle mondariso che provenivano dall’Emilia, un gruppo di donne vercellesi, esasperate dalla concorrenza sulla paga che la manodopera “straniera” esercitava, andasse ad attendere le rivali alla stazione con intenzioni non del tutto pacifiche. Per fortuna questo comitato di benvenuto si risolveva quasi sempre solo in una zuffa verbale, nella quale “puttane” e “crumire” erano i termini più utilizzati.
Mi ero fatta coinvolgere da Anita quel pomeriggio di fine aprile del 1917, nel quale anche noi due stavamo per partire con destinazione risaia. Per dare una lezione, come aveva detto lei, alle ladre di lavoro che stavano arrivando dalla provincia di Reggio Emilia.
Era la prima stagione da mondariso, nonostante i miei ventuno anni compiuti. Sino ad allora avevo sempre e solo aiutato i miei genitori nei campi e in casa. Ma poi scoppiò la guerra, i miei due fratelli ne furono coinvolti, le risorse presero a scarseggiare. E allora mio padre mi recapitò il suo pensiero. Dovevo impegnarmi a collaborare nella lotta contro la miseria che aggrediva la famiglia. Questo, nel nostro territorio e in primavera, aveva un solo significato: andare a fare la mondariso. E inoltre, aggiunse mio padre, era ora iniziassi a prepararmi il corredo. Che, appunto, costava. Anche se, e qui terminò con un umorismo non so quanto volontario, non si vedeva nessun fidanzato all’orizzonte. Ma su quest’ultimo aspetto io ero preparata. Come farsi un fidanzato con tutti i giovani in guerra?
Insomma, ripeto, pur avendo seguito Anita in quella sciocca iniziativa, capii subito che tutte eravamo donne misere, disperate, sfruttate. Insomma, nella stessa barca. Tutte. Piemontesi, lombarde, emiliane, toscane.
Dopo questa ridicola e inutile baruffa, una marea di donne, giovani e non, si diresse verso i numerosi autocarri che attendevano sul piazzale della stazione per condurre le aspiranti mondariso di qualsivoglia provenienza nelle diverse cascine di destinazione.
La confusione era tale che non riuscii nemmeno a salutare Anita. Sentii chiamare il mio nome e, in un baleno, mi ritrovai seduta in mezzo a donne che non conoscevo su un camion il cui cartello recitava “Cascina Mezzolago”.
Il viaggio non fu lungo, non più di un paio d’ore, ma il silenzio profondo ne amplificò la portata. Eravamo forse una trentina di donne sul camion. Tutte stringevamo con ferocia i nostri fagotti miseri e informi. C’erano ragazzine giovanissime. All’apparenza tredici anni, qualcuna forse anche meno. Pallide, stracciate, smagrite dalla fame e spaurite dalla circostanza. Qualcuna veniva abbracciata e quasi cullata da donne meno giovani e più esperte. Il tutto sempre nel più rigoroso silenzio.
Una cosa però era certa. Le differenze tra di noi, tra locali ed estranee erano definitivamente evaporate in un lampo.
Giungemmo alla cascina mentre il sole se ne andava scintillando sopra lucide e piatte distese d’acqua.
Per tutta la sera non udii altro che le indicazioni degli organizzatori del lavoro e del trasporto. Scese dal camion ci diedero un bicchiere di latte e una pagnotta a testa. Poi ci indicarono il fienile nel quale avremmo potuto sistemarci per la notte. Il fieno, eravamo in aprile, non c’era ancora e dovetti accomodarmi in un angolo con poca paglia.
Provai a far calare il sipario su quella giornata così lacerante. Non una parola o un suono accompagnò il mio viaggio verso il sonno.
Il primo ricordo lucido del mattino seguente mi consegna una immagine che vede noi mondariso alzare a turno la schiena per celebrare il rito della prima “pausa acqua”. Se eri simpatica al portatore del secchio di acqua potevi persino bere due mestoli.
Erano le 9.30 del mattino e lavoravamo da prima ancora che facesse completamente chiaro. Già stremate, eravamo però ben consce del fatto che il peggio doveva ancora arrivare.
Sole, caldo, zanzare, piedi ormai insensibili, schiena a pezzi. Tutto questo cresceva in maniera esponenziale con il progressivo avanzare della giornata.
Ero inserita in una lunga fila di donne e ragazze poste una accanto all’altra. Le guardai ripetutamente di sottecchi. Ma la conclusione fu inappellabile: non ne conoscevo nemmeno una.
Seppi successivamente, dalle chiacchiere con le altre mondariso, che creare gruppi eterogenei con donne che non si conoscevano l’una con l’altra era fatto apposta, rispondeva a una precisa strategia. Per evitare che si familiarizzasse troppo e si rendessero collettive disgrazie che, per il mantenimento della pace sociale, era meglio se fossero rimaste personali.
Durante la pausa per il pranzo ci sedemmo tutte sull’argine del fosso. Con i piedi ormai cotti dall’acqua e il culo bagnato. Passarono i cavallanti a distribuire l’acqua che ci fu versata nella gavetta che ognuna di noi possedeva. Poi due giovani donne, le nipoti del padrone, si incaricarono della distribuzione del pranzo: l’una ci consegnava due fette di pane e l’altra un pezzo di formaggio.
Dormire nel fienile, stare tutto il giorno chinata con i piedi nell’acqua, bere e mangiare poco. I diversi momenti della vita in risaia mi costrinsero a familiarizzare con quel contesto e mi indussero a mostrare una sicurezza che non ero certa di possedere.
Qualche giorno dopo, in una pausa come tante, notai seduta di fianco a me una ragazza cui non avevo mai fatto caso.
Capelli lunghi e neri circondavano il suo viso senza arroganza. Occhi scuri, vispi, cui faceva da contraltare una tristezza che pareva abitare lì da parecchio. Mani straziate dal lavoro, che però restavano delicate e stringevano con forza e grazia il pane e il formaggio.
La guardavo quasi di nascosto, provando a immaginare la sua età. Sussultai, quando lei, quasi apostrofandomi con durezza, sbottò in un sonoro “Ciao”, condendo il saluto con una gomitata nel costato. Mi voltai di scatto e intercettai un sorriso che, per un attimo, era riuscito a scacciare ogni ombra dal volto della giovane donna.
Il sorriso venne a sua volta allontanato, sconfitto dal lungo sibilo e dalle urla ripetute che chiamavano alla ripresa del lavoro.
La ritrovai nel pomeriggio a giornata di risaia conclusa. O meglio fu lei a venirmi a cercare mentre tentavo maldestramente di lavarmi nel cortile della cascina con acqua fredda e usata.
«Ciao» mi salutò con la stessa timida ruvidità mostrata poche ore prima.
Alzai la testa e rividi quegli occhi così luminosi ma sperduti.
«Ciao» risposi frettolosamente e con scarsa cortesia.
Poi, presa da un insolito affanno, proseguii.
«Da dove arrivi?»
Lei sorrise del mio malcelato imbarazzo.
«Vengo da Novi, un paese vicino a Modena. E’ ormai il terzo anno che faccio la mondariso qui. Tu di dove sei? Come ti chiami?»
«Io sono di qui. San Giacomo. Un pugno di case vicino a Vercelli. E’ il primo anno che lavoro in risaia. Mi chiamo Caterina. Tu?»
Lei mi guardò e sorrise. Quasi beffarda. Come chi si aspettasse che quel momento sarebbe infine arrivato.
Poi assunse un’aria quasi di sfida.
«Dinamite, il mio nome è Dinamite» rispose sparando i suoi occhi sul mio viso.
Si gustò il mio smarrimento, poi decise di tamponare l’imbarazzo, sospirò con accondiscendenza e proseguì.
«Va bene, Caterina, ti spiego. Devi sapere che il mio papà era un ferroviere anarchico. Come tanti all’epoca. Ha avuto tre figli. L’ ultima sono io. Mio padre ha dato ai figli nomi presi dalla sua fede politica. Dalle mie parti si usava e si usa ancora. Mio fratello si chiama Popolo e mia sorella Libertà. Io Dinamite. Violenta levatrice del mondo nuovo.»
Dopo tale spiegazione rise ancora, con una espressione a metà strada tra il chiedere scusa e, viceversa, mostrare una orgogliosa ostentazione.
Io qualche concetto molto vago circa parole come socialismo e anarchia e liberazione lo avevo sentito narrare. Soprattutto da mio fratello Mario che, in quel momento, era anche lui con i piedi nel fango come me, sia pur lontano e in condizioni ben più pericolose. Abituata però a un mondo nel quale ai neonati veniva affibbiato il nome dei nonni, fui tramortita dalle frasi della giovane donna e mi rifugiai nella prima domanda scontata che mi venne in mente.
«Il tuo papà è già morto?»
«Sì» rispose Dinamite di scatto «Papà Pietro è morto nel 1893, in un incidente ferroviario. La locomotiva che stava guidando andò a sbattere contro un muro mentre, a tutta velocità, stava viaggiando su un binario morto della stazione di Bologna. Fu un incidente strano. Che nessuno ci spiegò mai esattamente. O che comunque non illustrarono a me. Quando accadde io ero ancora nella pancia di mia mamma. Non ho mai conosciuto mio padre. E mia mamma non ha mai parlato volentieri della morte di suo marito e di come andarono le cose.»
Mentre proseguiva quella nostra bizzarra presentazione, io mi ero rivestita e avevamo preso a camminare per un viottolo che costeggiava cascine e risaie.
Era sabato. L’indomani sarebbe stato il primo giorno di riposo da quando eravamo arrivate.
Un crepuscolo dolce e insinuante coccolava noi e la nostra gioventù.
Gioventù che, minuto dopo minuto, si stava vendicando e prendeva il sopravvento sulla risaia e sullo sfruttamento.
Il buio cresceva ma non poteva coprire risate e mormorii di ragazze che fiorivano come da un immenso impianto stereofonico.
Dinamite e io alternavamo fitte chiacchiere avide di conoscenza a meditabondi silenzi.
Sommessamente prese a filtrare dalla sera il doloroso suono di una fisarmonica, cui, pochi minuti dopo, si aggiunse il pizzicare delle corde di una chitarra.
Poi un padrone con il cuore meno coriaceo degli altri illuminò il cortile della propria cascina.
Qualcuno montò velocemente un banchetto e un circolo vinicolo prese a vendere a basso costo bicchieri di vino.
Per ultimo le gambe di decine di giovani furono aggredite dalla frenesia e si diressero quasi correndo verso il punto dal quale proveniva la musica.
Si era in piena guerra e, quindi, gli uomini rimasti a casa erano pochissimi. E tutti non più giovanissimi. Le ragazze presero pertanto a danzare tra di loro.
«Si balla!» gridò Dinamite prendendomi per mano, vincendo la mia istintiva ritrosia e obbligandomi a planare sull’aia ormai trasformata in una rudimentale pista da ballo.
Io non ero per niente brava a ballare, anzi non avevo proprio mai imparato, ma Dinamite mostrava una così salda capacità di condurre che il danzare mi sembrò e mi riuscì semplice.
Tutte o quasi le ragazze e le donne ballavano. Con allegria e impegno. Spesso facevano una sosta per fare quello che a casa non avrebbero mai osato. Bere un bicchiere di vino.
Insieme al bicchiere di vino i compagni del circolo vinicolo consegnavano alle donne una litania. A volte urlata, ma per lo più sussurrata.
«Compagne, organizziamoci. Domani alle 15.00 riunione di tutte le mondariso alla frazione Vaschetta. Ordine del giorno: Lottiamo per obbligare i padroni a rispettare le otto ore di lavoro al giorno.»
Dinamite e io non facemmo eccezione nel ricorrere al vino e, in breve, mi sentii le guance infuocate e la testa leggera.
Danzai sempre con lei. Così, senza un motivo. Tutte e due lo davamo per scontato. Dinamite volteggiava in maniera straordinaria, con una leggerezza quasi eterea, riuscendo a mimetizzare con successo la mia incapacità.
Mi sorrideva con la bocca e con gli occhi e quando il suo sguardo era puntato sul mio viso la sensazione di essere nei pressi della felicità era grande.
La notte si era diffusa tutto intorno per inquietarci e poi proteggerci. Uno spicchio di luna metallo, minuscola ma luminosa, si incaricava di addolcire la cupezza dell’oscurità.
Con il progredire della sera i nostri guai di donne sole lontane da casa scomparirono. Padroni e sfruttati, risaia e fame, paura e fatica. Tutto si fece da parte, lasciando la scena a più o meno giovani ragazze che, stordite dal vino e dalla stanchezza, volevano sì il pane che quell’infame lavoro procurava loro, ma anche le rose della loro esistenza di donne.
Ballammo tutte a lungo, senza risparmiarci, come se quella fosse l’ultima volta che ci fosse concesso di farlo nella vita.
Anche io e Dinamite danzammo senza sosta. Restammo quasi sempre in silenzio. Io attenta ai passi di danza da eseguire e lei quasi sempre sorridendomi. Appena in un paio di occasioni Dinamite ruppe il nostro reciproco mutismo per sussurrarmi «Sei bravissima.»
Solo lo spegnersi progressivo delle luci, il vino ormai finito e il crollo fisico degli improvvisati musicisti e delle ballerine, prima smorzarono e poi condussero a termine quella serata nata dal nulla e divenuta magica.
Alcune coppie insistettero per alcune briciole di tempo a danzare senza musica, fischiettando motivi a labbra strette.
Poi il silenzio e il buio tornarono padroni del tutto.
Dinamite mi prese per mano e mi portò con se nell’oscurità. Come volesse attraversare insieme la notte a piedi. Quasi un viaggio intrapreso per truffare tristezza e malinconia.
Andai con lei senza timore, con una accondiscendenza che mi parve naturale e doverosa e un languore sconosciuto.
L’angolo di fienile nel quale mi condusse era scomodo e poco accogliente, ma a me parve un luogo dove si poteva provare a raggiungere la bellezza e la gioia.
Probabilmente provvisorie, ma molto meglio di nulla.
Fu come il ballo delle ore precedenti. Dinamite guidava, certo. Ma a me, inesperta e timida, tutto veniva naturale e spontaneo.
L’umido della notte, tremendo nelle zone di risaia, ci aggrediva. I nostri corpi, nell’atto di abbracciarsi, si incollavano letteralmente. Ricordo ancora che Dinamite e io ridemmo di questo, soffiandoci contro l’un l’altra per cercare di procurarci refrigerio.
Le sue mani, rovinate e imbruttite da anni di lavoro nei campi e in risaia, sapevano ritornare levigate come quelle di una bimba.
«Sei bellissima.»
Nessuno, e meno che mai nella stessa sera, si era mai rivolto a me dicendo «Sei bravissima» e «Sei bellissima»
A sentire quelle parole piansi. E lasciai che mi succhiasse le lacrime e mi baciasse gli occhi.
La notte ci scivolò addosso con delicata leggerezza.
Le ore passarono senza che io potessi percepirle.
Fu un alternarsi di assopimenti, veglie, baci e abbracci.
Cento, mille, milioni di carezze.
«Puzzi di vino»
«Anche tu»
La notte trascorse così. Tra sciocchezze e passione e intontimenti. Con un grado di consapevolezza molto basso.
Poi vennero altri giorni. E altre notti. Una alternanza quasi delirante di fatica e stordimenti.
Amai Dinamite in maniera forsennata e psicotica.
E lei amò me. Almeno così mi piace pensare.
Le settimane seguenti cullarono il nostro vivere.
Il lavoro e le carezze condirono le giornate.
Riuscimmo anche a sorpassare chiacchiere e cattiverie, che peraltro a volte furono persino benevole e affettuose.
Parlammo pochissimo, Dinamite e io, in quella primavera del 1917. Comunicammo soprattutto con sguardi e sorrisi. Tanti sorrisi.
Nessuna delle due provò a immaginare il futuro o a fare progetti. Per il semplice motivo che nessun progetto poteva essere fatto. Restammo semplicemente lì, a farci cullare da quelle umide notti.
Poi le erbe da estirpare in risaia terminarono e, in un giorno di giugno già afoso, nel cortile della cascina apparvero gli autocarri che dovevano riportarci a casa. Oppure, come nel caso di Dinamite, alla stazione per prendere il treno che la avrebbe ricondotta in Emilia.
Non ero né triste e nemmeno allegra. Mia mamma mi aveva scritto che Mario stava arrivando a casa in licenza agricola. La prospettiva di rivedere i miei genitori e almeno uno dei miei fratelli non poteva che procurarmi gioia.
Certo. Come dire. Il pensiero di lasciare la magia di quelle notti scure e bagnate mi opprimeva.
«Che Dinamite sei?» le dicevo «Se sei davvero esplosiva come recita il tuo nome, fai scoppiare il mondo e porta noi due da sole in una isola deserta.»
Ridevamo insieme quando io recitavo questa stupida battuta.
Ci accomodammo sullo stesso autocarro, ma non vicine. Non volevamo alimentare lo scandalo. Né enfatizzare troppo quel momento. Ostentammo, in sostanza, una indifferenza che non possedevamo.
L’autocarro sobbalzò in continuazione su strade sgangherate.
Riuscii persino ad appisolarmi al ritmo di quella andatura irregolare.
Una brusca frenata scosse il mio torpore.
L’autocarro, le ragazze, il frastuono, le voci, la piazza, la stazione ferroviaria. Insomma la realtà.
Saltai giù dall’autocarro tenendo ben stretto il mio fagotto con i pochi vestiti e qualche chilo di riso, importante parte del compenso ricevuto per qualche settimana di lavoro.
I soldi, pochi, erano, come da consuetudine per noi ragazze, al sicuro tra le mie tette.
In breve si diffuse la voce che tra pochi minuti sarebbe partito il treno per Reggio Emilia, Modena e Bologna. Le donne emiliane presero a correre con affanno e disordine.
Anche Dinamite si allontanò rapidamente, non prima di essersi voltata a gettare uno sguardo nella mia direzione.
Restai un lungo secondo impietrita a vederla andare via.
Nel volgersi verso di me il suo viso era disteso e sorridente. Non mostrava dolore e nemmeno tristezza, Un guizzo negli occhi mi parlò e disse «Vieni, Caterina»
Poi le mie gambe presero il comando di me stessa e si misero a correre. Seguendo Dinamite. Verso i treni che erano pronti a partire.
Non sapevo nemmeno io perché la inseguivo.
Forse per saltare insieme con lei su un treno che ci portasse via dal mondo. Oppure solo per abbracciarla un’ultima volta, magari sussurrandole «Grazie, Dinamite». O, molto più semplicemente, per lanciarle un “ciao” con la mano dal finestrino, come decine di donne che restavano stavano facendo nei confronti di altre decine di donne che partivano.
Fu mentre correvo che scorsi, immerso nella folla, mio fratello Mario. Immaginai subito che fosse appena tornato, con un treno che lo aveva portato dalla trincea del Carso a casa in licenza agricola. Mia madre, nella sua lettera, mi aveva informata.
La testa mi divenne subito confusa. Dinamite, Mario, salutare, partire, il riso, abbracciare, il treno.
Tutto si miscelò senza fondersi.
Mario si accompagnava con una mondariso del mio paese, che gli indicava qualcosa o qualcuno.
Dinamite salì sul predellino del treno e si voltò nella mia direzione. I suoi occhi presero a ridere, come facevano sempre quando incontravano i miei. Il mio stomaco si accartocciò su se stesso.
Mario, intanto, era arrivato proprio nei pressi della stessa carrozza, con la ragazza che gli era vicina che prese a gridare «Quella, quella!»
Nella mano di Mario apparve una rivoltella.
I colpi furono solo due, poi la pistola si inceppò.
Il piede di Dinamite si incastrò nello scalino. La gamba destra fece una torsione innaturale mostrando il suo polpaccio segnato dal lavoro. Il suo corpo si abbatté sulla banchina della stazione.
Il rumore della testa di Dinamite al contatto con il cemento fu simile a quello dei cachi dell’albero del cortile di casa nostra quando, troppo maturi, a novembre cadono in terra.
Un’ondata di silenzio artificiale si propagò per la stazione spegnendo ogni più piccolo brusio. Un fischio lontano fu l’ultimo suono percettibile.
Feci due passi. Forse solo uno. O magari nessuno.
«Grazie, Dinamite» sussurrai a bocca chiusa.

