Michele Zanetti
LAGUNANDO 2020 > selezionati 2020
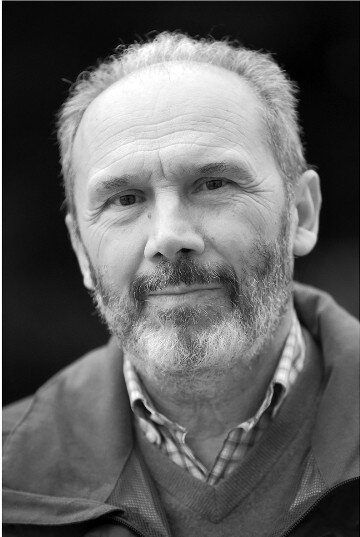
Nato nella Bassa Ferrarese.
Diploma di perito Industriale conseguito al Pacinotti di Mestre.
Tredici anni di lavoro nell’industria locale, ventidue anni come guardacaccia in provincia di Venezia.
Numerosi saggi naturalistici e alcune opere di narrativa pubblicate.
I moriglioni di Nane
La caccia era un affare serio in quegli anni: la guerra ch’era appena passata lasciando nei cuori cumuli di cenere, aveva soltanto sfiorato la laguna. Solo il rombo dei bombardieri che volavano al nord a seminare devastazioni e lo sferragliare dei carrarmati nella notte lunghissima in cui l’armata tedesca aveva abbandonato le postazioni, imbarcandosi: solo questo, poi il vuoto. L’assenza di speranza, di volontà e persino d’una parvenza d’autorità e di legalità, che rimettessero una comunità decimata sui binari della ricostruzione morale e spirituale. Tutto sembrava sospeso nel vuoto immateriale di una precarietà e di un’attesa che giorno dopo giorno esasperava gli animi, accendeva nuovi lutti, apriva nuove ferite e ingigantiva bisogni che non trovavano risposte. Per tutti l’imperativo era arrangiarsi, sopravvivere, uscire dal buio di un’avventura che sembrava ormai interminabile.
Nane era tornato dopo l’otto settembre a Burano; aveva vissuto l’avventura del ritorno come un naufrago stremato affronta lo sforzo per raggiungere la spiaggia ormai in vista: con protervia, con rabbia, senza risparmiare fatiche e senza perdere la lucidità. Era rimasto nascosto in baracca, sulle barene della Palude del Bambagio per dodici mesi, prima di tornare a casa, di notte ed era vissuto di ciò che la laguna gli concedeva e dell’arte antica d’arrangiarsi. Sapeva pescare Nane e raccoglieva con abilità tutte le messi che i fondali fangosi scoperti dalla marea concedono a chi conosce la palude salsa.
Poi, terminato l’incubo della guerra era tornato tra le mura di casa, ad aggiustare reti troppo vecchie e a rincuorare due anziani che avevano perduto due degli otto figli allevati con tante privazioni. Ed era lui, giunto ormai alla soglia dei trent’anni e dunque già quasi vecchio per prendere moglie, che s’era fatto carico di governare quella carretta del mare esausta e rattoppata, ch’era appunto la sua famiglia.
Nane però non s’era perso d’animo, ben sapendo che l’arte d’arrangiarsi avrebbe consentito a lui e ai suoi di galleggiare e di sopravvivere nel mare di miseria e di sofferenza che sembrava assediare Burano con le sue onde limacciose.
Lui conosceva le lune e la loro danza nel cielo notturno e leggeva dall’orientamento della falce, dal vento che ripuliva le notti lagunari e dalle nuvole che disegnavano un alone d’alabastro attorno al disco luminoso, gli eventi che avrebbero animato gli specchi e le secche della palude nei giorni e nelle settimane successive.
Aveva soltanto una passione segreta, ma neppure troppo e la praticava con assiduità, profittando del vuoto d’autorità e di controlli, che la recente fine del periodo bellico aveva lasciato sulle vastissime mura d’acqua: le stesse, che avevano specchiato e difeso i fasti della Serenissima per oltre mille anni. Nane era un cacciatore, anzi era quasi un bracconiere; ma tant’è labile il confine tra l’una e l’altra condizione in assenza di regole certe, che non gli si poteva attribuire con certezza la seconda, infamante e al tempo stesso prestigiosa, qualifica.
Quella fine estate del 1945 aveva dunque segnato il suo ritorno all’attività che più d’ogni altra esaudiva la sua voglia di vivere ed egli vi si era preparato con passione e senza risparmio di mezzi e di tempo. Venuti meno i rischi e le paure, con la fine ufficiale delle ostilità, egli aveva potuto recuperare la vecchia doppietta sepolta nel fango in prossimità della baracca da pesca, sulle barene del Bambagio. L’aveva ritrovata vicina al ramo di tamerice che lui stesso aveva infisso nella melma scura; era in buone condizioni e ancora oliata, grazie ad una protezione di tela cerata a doppio strato con cui l’aveva avvolta nel momento di nasconderla. Quanto poi alle cartucce, vi si era dedicato una settimana, dopo, quando la messa a punto dell’arma, smontata e rimontata più volte, gli era parsa perfetta. Durante le settimane luminose di giugno e fino all’estate inoltrata, nelle pause del duro lavoro al remo per il governo delle seragie e nei ritagli di tempo concessi dalle molteplici incombenze quotidiane, egli s’era dedicato alla fabbricazione di cartucce, recuperando vecchi bossoli di cartone e riempiendoli di pallini e di polvere, con gesti misurati e rituali e con un’abilità artigianale che affascinava i fratelli giovani.
A fine estate, quando i germani vanno in muta e assumono quell’abito dimesso che coincide con l’inizio della grande migrazione, Nane era pronto ad affrontare quella che si prospettava come una lunga e intensa stagione di caccia.
Lui però non si muoveva mai solo, anzi, era una sorta di animale sociale; se lo si fosse dovuto paragonare ad una delle creature che da tempi immemori abitano tra le canne e il fango dei ghebi e dei chiari di laguna, la scelta sarebbe caduta sicuramente sulla lodra. Sì, proprio la lontra, tanto odiata dai pescatori, ma al tempo stesso agile nuotatrice, abilissima cacciatrice di pesci, ma anche socievole e allegra per natura, anzi, per vocazione. Come la lontra, Nane amava il gioco, lo scherzo e la compagnia e non c’era domenica che, dopo la messa, non lo vedesse in chiassosa assemblea sulle fondamenta e nei campielli della sua isola incrostata di salsedine e di colori pastello. Allegro, vivace, giocoso e intelligente: proprio come una lontra.
Ecco allora che anche nella caccia egli cercava quella condivisione e quella comunione di emozioni e d’avventure che gli consentivano di rafforzare l’amicizia con la complicità e di raccontare le sue strabilianti imprese, con la certezza di condividere l’ammirazione e il prestigio che gli procuravano.
Suoi compagni di battuta erano i fratelli Ballarin e Toni Sperandio, tutti giovani poco sotto la trentina, ridanciani ed estroversi e tutti, come lui, redivivi dopo la bufera di una guerra che aveva tragicamente disperso i buranelli sui fronti d’Africa e di Russia.
Nane faceva solitamente coppia con Alfio Ballarin, mentre il fratello di questi Piero, s’accompagnava a Toni Sperandio. Erano due coppie di doppiette affiatate, oltre che abili e anche un po’ spregiudicate; e quando si muovevano dalle fondamente di Burano, nel tardo pomeriggio di sabato o a notte fonda, gli altri cacciatori cercavano d’intuire dove fossero diretti, per evitare di incrociarli o di trovarsi a cacciare nelle loro vicinanze. Dove s’accampavano e bivaccavano loro, occupando botti e controbotti, non rimaneva spazio e soprattutto selvaggina per altri e dunque era meglio girare loro al largo.
Quel sabato pomeriggio, s’era nella prima settimana di settembre, sembrava che l’estate avesse deciso di perpetuare le atmosfere agostane, avvolgendo la laguna in una calura insolita, che lo scroscio di una luce vivida rendeva ancor più estranea a quei giorni. Non v’era traccia delle brezze fresche che segnano il declino della stagione asciutta e che increspano di piccole onde il Canale di Burano, tingendolo di blu profondo. L’acqua dei canali che disegnano la prolissa geografia urbana di Burano appariva più grigia del solito e, oltre gli angusti confini dell’isola, stemperava i propri colori dimessi nell’azzurro verdastro delle grandi vie d’acqua. Queste stesse, accompagnate da sequenze di bricole, serpeggiavano pigre oltre i profili di Torcello, allungandosi verso gli orizzonti della laguna di frontiera: verso il Tralo, la Centrega e verso la Cona; lontano, nelle paludi dove i canneti del Dese formano una fascia continua che nasconde la foce del fiume.
I due sandoli, barche leggere e agili da basso fondale, erano partiti verso la metà del pomeriggio e formavano un piccolo convoglio che si muoveva al ritmo scandito dalla voga alla vallesana. Un movimento tranquillo, un fluido scivolare sull’acqua immobile, per risparmiare forze, che tanto c’era tempo e la strada era lunga. Era diretto, il piccolo naviglio, verso le sacche palustri che segnano il confine estremo della laguna, là dove comincia la bonifica; le stesse dove le acque basse nascondono praterie rigogliose di erba da ciossi, zeppe di minuscoli granchi e di s’chie, di corbole e di tremoline. Qui, nelle notti tranquille di fine estate fischioni e moriglioni, alzavole e germani, giungevano in volo dalle valli, affollandosi a branchi per la pastura. E proprio in questi luoghi remoti, che soltanto i cacciatori e i pescatori vagantivi conoscevano e riuscivano a percorrere, nonostante l’insidia dei bassi fondali, la prima luce del giorno era segnata dal frullo concitato ed eccitante di centinaia di ali.
La luna nuova s’era fatta da soli tre giorni e lo scuro di luna che l’aveva preceduta aveva portato nuovi branchi d’uccelli alla laguna, promettendo cacce memorabili ai buranelli che, sfidando le zanzare e i disagi di una notte in barca, accettavano la sfida sempre nuova della posta all’alba.
Uno dei cacciatori stava rannicchiato a prua, tra un sacco di zimbelli, la cassetta metallica delle cartucce e la sporta con i viveri, mentre le gabbie dei germani vivi erano sistemate sopra la stessa prua del sandolo. L’altro stava invece ritto al centro della piccola imbarcazione e manovrava i remi, incrociati sul petto, con l’energia e l’eleganza che distingue i buranelli, che essendo nati su un isolotto di fango in perenne balìa delle maree lagunari, si muovono sull’acqua con la stessa confidente disinvoltura con cui un montanaro percorre sentieri impervi.
Il primo turno di voga era toccato a Nane e Alfio, assiso tra le cianfrusaglie della caccia, gli stivaloni alti calzati e arrotolati al ginocchio, fumava una sigaretta preparata con la solita cura maniacale. Gli sbuffi di fumo azzurro si dissolvevano rapidamente nell’aria calda della sera imminente e una luce ancora intensa e brillante nei toni dorati, faceva splendere le barene di Torcello, appena tinte dell’azzurro ceruleo dei primi settembrini in fiore.
Il piccolo convoglio nautico aveva attraversato il canale di Burano e imboccato l’ampio canale di S. Antonio; aveva lasciato sulla sinistra gli austeri e solitari profili della basilica di Torcello e s’era inoltrato nel canale della Dolce, aggirando la grande barena che s’estende a est del settecentesco ossario di San Ariano.
Giunti nei pressi dell’isolotto abbandonato, proprio di fronte alla piccola valle de La Cura e trovandosi circa a metà strada, in procinto di imboccare il canale della Dossa che li avrebbe condotti ai bassi fondali e alle barene estreme della Palude della Rosa, Nane chiese il cambio. Era sudato per lo sforzo, anche se la brezza leggera e tiepida che si leva di solito nelle ore che precedono la sera, asciugava in fretta gli indumenti. Aveva anche sete, ma si tratteneva e non tanto per ostentare la sua rustica resistenza alla fatica del remo, quanto per non offrire il pretesto della stura delle bottiglie di rosso aspro e scuro che si portavano appresso e che dovevano invece durare almeno una giornata. Oltretutto le libagioni avrebbero potuto compromettere la sveglia e soprattutto la mira, nella battuta che si preparava per le prime ore dell’indomani.
Fu Toni Sperandio a proporre una sosta sull’isolotto, ma dovette impegnarsi per vincere le resistenze dei compagni, cui l’idea di condividere l’esigua sponda con i carbonazzi che la leggenda voleva padroni di quello scoglio dimenticato e un po’ tetro, non andava troppo a genio. Insistette dicendo che conoscendo quel luogo per averlo frequentato spesso, sapeva dell’esistenza di un grande fico stracarico di frutti neri e raggrinziti dal sole: un autentico concentrato di zucchero e miele che deliziava il palato.
I fichi ebbero la meglio sulla paura dei carbonazzi e gli uomini scesero calpestando i cocci della sponda di San Ariano, dopo aver assicurato i sandoli al remo infisso verticalmente nella melma. Toni li condusse lungo il lungo muro di cinta, traboccante di pruni e biancospini carichi di frutti vermigli, semidiruto e avvolto da edere secolari e infine raggiunsero il versante meridionale. Torcello galleggiava nel controluce tremolante delle acque che avevano sepolta la storia, mentre la barena, che accompagna il sinuoso alveo del Silone attraverso la laguna di gronda, disegnava una fascia scura e indistinta nello sfavillìo delle increspature che agitavano la superficie della palude.
Il grande fico, che cresceva sul versante protetto delle mura, protendeva i rami fin quasi al suolo, come se avesse voluto evadere da quel recinto di morte e inseguire il quotidiano fuggire del sole verso i misteriosi orizzonti di ponente. La sua chioma, appena rarefatta dai venti carichi di salsedine, appariva rigogliosa e il suo profilo arrotondato sembrava perfetto, quasi fosse una geometria dolce contrapposta dalla natura a quella spigolosa delle mura costruite dagli uomini.
Un ronzìo insistente, di api, di mosche e di vespe ubriache, accolse gli uomini che si avvicinavano, confermando l’abbondante esistenza della dolce risorsa ch’essi cercavano.
Così cominciò la grande mangiata di fichi. I frutti erano piccoli e neri, raggrinziti e come asciugati dall’acqua che l’estate calda aveva fatto esalare, concentrando gli zuccheri fino a trasformarli in miele puro.
Fu Piero il più solerte e dopo quasi un’ora, quando ormai il sole scendeva verso ponente smorzando la propria luminosità nei vapori della laguna mestrina, il fico appariva alleggerito, almeno sulle fronde accessibili dall’esterno del muro di cinta.
I cacciatori risalirono in barca con quella sensazione di sazietà vagamente opprimente che coglie coloro che s’ingozzano senza lasciare allo stomaco il tempo di demolire il cibo, ma anzi insaccandolo con ingordigia. La strada da percorrere per raggiungere le poste era comunque ancora lunga e la ginnastica del remo avrebbe loro consentito di macinare qualsiasi cosa avessero mangiato.
Ripresa la voga vennero loro incontro i primi, timidi canneti: quelli che le lame di corrente dolce trascinano fin dentro la laguna, lasciandoli poi dissolvere tra le salicornie e il limonio, mano a mano che esse stesse diluiscono nel salso delle acque marine.
Il sole ora galleggiava basso all’orizzonte e la luce scemava poco a poco, mentre l’aria rinfrescava appena e faceva svolazzare le camicie spavaldamente aperte sul petto dei vogatori.
La sera trascorse comunque tranquilla, con la celebrazione dei riti usuali: la sistemazione del posto caccia, che dopo un prolungato abbandono si presentava in precario stato; il taglio dei ciuffi di canna cresciuti davanti alla botte ad impedire la visuale verso il lago, lo spargimento della pastura per gli uccelli e la disposizione accurata degli zimbelli sui bassi fondali. A tutto questo era infine seguita la cena al lume di candela, con le due barche affiancate e legate l’una all’altra a formare una sorta di tavola galleggiante. Al solito pesce conservato e al salume buono, messo da parte e gelosamente custodito per l’occasione, s’era accompagnato il vino, che aveva abbondantemente annaffiato la cena, nella inconfessata speranza di ciascuno di far digerire i fichi di San Ariano.
Poi ciascuna barca s’era ritirata nella propria postazione, scivolando in silenzio nel buio e gli uomini, teso il pesante telo cerato sul guscio galleggiante s’erano disposti al riposo sul fondo stesso della barca, proteggendosi dall’umidità della notte lagunare sotto pesanti coperte militari.
Le due postazioni distavano si e no una trentina di metri ed erano accostate al canneto che le proteggeva verso est, impedendo agli uccelli che giungevano in volo dalle valli di scorgerle fino all’ultimo.
Nel volgere breve di una mezz’ora i silenziosi fruscii della notte lagunare di settembre s’erano sostituiti alle parole sommesse degli uomini e ai rumori del remo che urtava la forcola o la fiancata del sandolo.
Una falce esile di luna nuova, luminosa e struggente s’affacciò all’orizzonte orientale, disegnando nell’indaco del cielo il suo misterioso segno perfetto. I cacciatori però già russavano distesi sul fondo delle barche, indifferenti allo squittire delle pantegane che si rincorrevano sul terrapieno delle botti e al richiamo stridulo dei porciglioni, dispersi tra i grovigli della distesa sconfinata di canna.
E tuttavia a notte fonda Alfio si svegliò, quasi di soprassalto, come se qualcuno gli avesse collocato un macigno sullo stomaco. Era sudato e aveva una sete terribile, ma temeva, contorcendosi e brancolando al buio, di svegliare Nane, che gli dormiva accanto sbuffando lievemente come avviene quando s’è immersi in un sonno profondo e senza sogni.
Stentò qualche minuto, gli occhi sbarrati nel buio, a realizzare dove si trovasse e cosa lo affliggesse; poi ascoltò i suoni della notte, come sempre strani e sconosciuti. Sentì il fruscìo dell’acqua che scemava da sotto il ventre piatto del sandolo; sentì le canne agitarsi lievemente alla carezza della brezza notturna; sentì persino lo spettrale e lontanissimo richiamo d’allarme di un airone, forse disturbato all’improvviso da un cacciatore che si recava tardivamente alla posta.
Poi sentì distintamente i moriglioni.
Il loro richiamo era inconfondibile, quasi una sorta di rantolo, di verso gorgogliante e cupo; erano certamente numerosi e anche se non sembravano vicinissimi, il loro fischio rauco era insistente, a brevi intervalli, come se numerosi maschi fossero posati tra gli zimbelli, a pasturare.
Alfio allora svegliò Nane urtandolo dapprima lievemente, poi con più vigore, finché questi si destò dal sonno, sbarrando gli occhi nel buio e chiedendo che ora fosse. Ma Alfiò lo zittì subito, dicendogli con un filo di voce:
“Tasi, tasi e scolta … Senti! Questi i xe magàssi … Senti che roba! I sarà na ventena … Senti!…”. (Taci, taci e ascolta … Senti! Questi sono moriglioni … Senti che roba! Saranno una ventina… Senti!)
Nane trattenne il respiro, ma non sentì che il frusciare lieve delle canne; attese ancora un po’ e finalmente il richiamo inconfondibile delle tozze anatre tuffatrici si rivelò nel silenzio lieve della notte. Erano veramente tanti e come s’affannavano a lanciare il loro sgraziato richiamo; al punto che Nane ribattè, ancora sottovoce:
“Ostrega! I xe propio lori … Senti che roba … E come che i smagassèa … Senti che roba ciò…” (Caspita! Sono proprio loro … Senti che roba … E come starnazzano … Senti che roba …).
Fu difficile riprendere sonno per il poco di notte che ancora rimaneva, anche perché l’insistenza del richiamo, ad intervalli quasi ritmati, divenne quasi ossessiva. L’alba comunque si rivelò presto e quando il primo tenue chiarore apparve oltre i profili neri delle canne, i due cacciatori erano già pronti, insonnoliti e tremanti per la frescura, ma con il cuore trepidante per la mattanza che li attendeva. Lo specchio d’acqua palustre che s’apriva davanti alla botte doveva essere letteralmente invaso dai moriglioni.
L’alba non si fece attendere a lungo e mentre rischiarava e una fascia dapprima sanguigna, poi arancione dorato, lievitava verso il levar del sole sospingendo l’azzurro verso la volta profonda del cielo, a sostituire l’indaco della notte. Il paesaggio della palude e dello specchio d’acque basse che s’allargava davanti alle botti andava dunque prendendo lentamente forma e colore e quelle che sino a poc’anzi erano informi macchie nere o indistinte fasce azzurre, ora si svelavano lentamente e come per incanto, l’arabesco delle proprie forme. Alfio e Nane, rattrappiti nelle due cavità vicine, la doppietta stretta saldamente in mano, sgranavano gli occhi verso gli zimbelli, nel tentativo di cogliere il movimento dei selvatici, il rantolo dei moriglioni e i loro tuffi verso le granaglie depositate sul fondo. Stranamente però, nulla si muoveva e solo greggi di minutissime onde sollevate dal vento leggero percorrevano la superficie speculare, facendo dondolare ritmicamente gli zimbelli inanimati. Le stesse anatre, che con un piombo legato a una zampa avevano liberato tra le sagome di sughero dipinto, lanciavano richiami starnazzanti e quasi festosi, come se non riuscissero a sopportare la solitudine.
I due cacciatori si sporsero perfino un po’ di più, tirando il collo, per vedere come andava a Piero e Toni, ma anche su quel versante nulla si agitava e, anzi, persino i due compagni erano invisibili, rannicchiati com’erano dentro le botti.
Eppure era proprio da quella parte che il richiamo insistente e lungamente ripetuto dei moriglioni si levava nella notte; dov’erano finiti dunque questi benedetti uccelli, a farsi fucilare dai signori nelle valli, come di solito accade?
La mattinata trascorse lenta e inesorabile, un’ora dopo l’altra, tutta intera; con il sole che, emerso dai profili della canna, aveva inondato l’intera Palude della Rosa di una luce pastosa, che scaldava l’aria e faceva ruotare lentamente le ombre dei pali e delle stesse canne. L’attesa si protrasse estenuante e nonostante la bravura dei richiami vivi, che si profusero in concerti da fare invidia a un pollaio, tutto ciò che i cacciatori videro attraversare la volta d’azzurro, fu il volo alto e goffo di un tarabuso, oltre a rari gabbianacci.
Verso le dodici anche i più tenaci cedettero e decisero che non era il caso di insistere oltre; era una mattina storta, scalognata e ormai perduta: tanto valeva portarsi verso casa e consumare una buona pastasciutta con il resto della famiglia, magari concedendosi poi un sonnellino pomeridiano.
Fu così che la barca di Toni e Piero s’accostò alla postazione di Nane, che ancora indugiava a sistemare i materiali e fu in quel momento che lo stesso Nane si avvide del viso cereo e stravolto di Toni. L’uomo stava accasciato sotto la prua del sandolo e si reggeva il ventre con le mani, rispondendo a monosillabi alle domande che gli venivano rivolte. E tuttavia il suo aspetto era così preoccupante che Nane non potè fare a meno di apostrofarlo e di chiedergli cosa mai gli fosse mai capitato.
La risposta fu lapidaria:
“Go pasà la note col culo fora dala barca, parchè m’ha ciapà a’ scagaréa…” e dopo una breve pausa: “Jé stàti i fighi … gò magnà massa fighi…” (Ho trascorso la notte con il sedere fuori dalla barca, perché m’ha preso la diarrea… Sono stati i fichi … Ho mangiato troppi fichi …).
Il mistero dei moriglioni e del loro insistente rantolare notturno aveva finalmente trovato una spiegazione.


